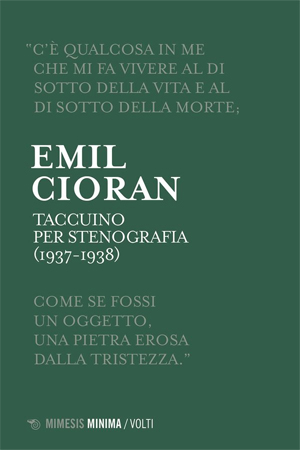|
|
Esercizi di stile: «Taccuino per stenografia» di Emil Cioran
 «Un metafisico. Ma non distante, non eretico, non enigmatico: un amico. Un antidoto contro le stregonerie, contro le intossicazioni del secolo. Leggerlo è avvertire la presenza di una mano tesa, afferrare una corda senza timidezza, avere alla propria portata una medicina che non sospetta». Sono queste le parole lungimiranti registrate da Guido Ceronetti, nella prima edizione del 1981 di Squartamento, per Emil Cioran. Leggerlo con timidezza significa non aver ancora individuato quella misteriosa miscela «di rispetto e di disgusto per la vita» [p. 37] che il buon Esculapio del VI Arrondissement ha cercato di infondere in ogni parola scritta. «Un metafisico. Ma non distante, non eretico, non enigmatico: un amico. Un antidoto contro le stregonerie, contro le intossicazioni del secolo. Leggerlo è avvertire la presenza di una mano tesa, afferrare una corda senza timidezza, avere alla propria portata una medicina che non sospetta». Sono queste le parole lungimiranti registrate da Guido Ceronetti, nella prima edizione del 1981 di Squartamento, per Emil Cioran. Leggerlo con timidezza significa non aver ancora individuato quella misteriosa miscela «di rispetto e di disgusto per la vita» [p. 37] che il buon Esculapio del VI Arrondissement ha cercato di infondere in ogni parola scritta.
È all’abolizione della timidezza che giungerà il lettore di Taccuino per stenografia (1937-1938), curato da Antonio Di Gennaro e tradotto da Magda Arhip (Mimesis edizioni, 2022).
Il Taccuino, arricchito da un’introduzione di Eugène van Itterbeek e da una postfazione dello stesso Di Gennaro,si pone come una vera e propria introduzione allo ‘stile’ di Cioran. Come accade per i Quaderni, questi ‘carnet’ rappresentano una forma di diario dove Cioran scarabocchiava i propri pensieri, ma si istituiscono altresì come esercizio di scrittura in vista di una ‘futura pubblicazione’. Come appunta van Itterbeek, il Taccuino non reca alcuna data, ma alcuni elementi fondamentali hanno permesso di precisarne l’anno, ovvero il 1937. Infatti, alcuni frammenti del Taccuino – riformulati più volte in queste pagine – compariranno quasi letteralmente in Le Crépuscule des pensées, scritto nel 1938. Vediamone degli esempi:
«Si j’étais Dieu, je me ferais n’importe quoi, sauf homme. Comme Jésus serait grand s’il était un peu plus misanthrope!». [Cioran, Œuvre, p. 388; ID, Taccuino, p. 53]
«Pascal – et surtout Nietzsche – semblent des reporters de l’éternité». [Cioran, Œuvre, p. 391; ID, Taccuino, p. 45]
Quest’ultimo frammento può sembrare uno dei tanti attacchi diretti al poeta dello Zarathustra – il quale ebbe un grandissimo peso nella formazione intellettuale del giovane Cioran, ma venne presto ripudiato –, ma come giustificare l’amato ‘Pascal giornalista dell’eternità’?
Poco più in alto, sullo stesso foglio del Taccuino, Cioran dichiara «la mia aspirazione: essere un giornalista dell’eternità». «L’espressione jurnalist al eternității – scrive van Itterbeek nella sua introduzione – traduce quel gusto pascaliano (e baudelairiano) di conciliare gli opposti, ora la fretta del giornalista che si occupa di momenti fugaci, ora l’atemporalità del mistico che si esercita nell’eternità». [p. 16]
In questi pochi frammenti che formano il libro edito da Mimesis, si pongono le basi teoriche per una nuova retorica che rimette Cioran in manutenzione, secondo la lettura di Jean Paulhan, il quale mira a una creazione letteraria che si nutre di contraddizioni e le mantiene nel discorso, sviluppandole entro i limiti di un determinato linguaggio. L’uso di un certo stile, che comincia a svilupparsi in questi anni, è indotto da una scelta esposta in un passo nei Quaderni, in cui il doppio ricorso al verbo venire a patti (composer nell’originale francese) attira l’attenzione sulla soglia tra due universi tra loro incompatibili: «Se mi sono tanto interessato allo stile, è perché vi ho visto una sfida al nulla: non potendo venire a patti con il mondo, sono dovuto venire a patti con la parola». [Quaderni, p. 82]
In tal modo Cioran, in dialogo serrato con i propri ‘appunti’, si avvia verso l’adozione della forma espressiva più appropriata a verbalizzare quei «pensieri strangolati» che troveranno in seguito migliore dimora nella gabbia dorata della lingua francese. Il lavoro di riscrittura costituisce una sorta di igiene intellettuale e linguistica che fa riferimento a una ricerca sempre rinnovata della parola giusta; «scrittura esplosiva», scrive van Itterbeek: certamente, ma tutt’altro che irregolare e immediata.
I futuri testi cioraniani mostreranno da sé l’impostazione di una scrittura fortemente disciplinata.
Notiamo infatti, già in questo piccolo Taccuino, riformulazioni di una stessa frase nel tentativo di trovare la giusta posizione delle parole all’interno della medesima, al fine di evocare la giusta sensazione. Torniamo dunque alla timidezza:
La timidezza è il più misterioso miscuglio di rispetto e di disgusto per la vita. [p. 35]
La timidezza è il punto d’incontro tra il disgusto e il rispetto per la vita. [p. 37]
Numerose variazioni di una stessa formula le troveremo disseminate nelle pagine dei Quaderni. Vediamo degli esempi:
Gli ultimi a cui perdoniamo l’infedeltà nei nostri confronti sono quelli che abbiamo deluso.
oppure: Perdoniamo a tutti l’infedeltà, tranne a quelli che abbiamo deluso.
oppure: Siamo sempre intrattabili con quelli che abbiamo deluso. [Quaderni. p. 153]
Provo una sensazione di benessere solo quando nessun pensiero mi sfiora la mente.
oppure
Si prova una sensazione di benessere solo in assenza di pensiero.
(Non vi è benessere che al di qua del pensiero). [Quaderni. p. 262]
Come si è detto, queste varianti – di cui ho fatto solo due esempi – si riferiscono a una ricerca della parola giusta, e la formula più ‘appropriata’ può avere vita nei testi più organici pensati alla pubblicazione.
Più che alla probità intellettuale o a una flaubertiana preoccupazione per la perfezione stilistica, dunque, è alla ricerca della Parola essenziale cui fa riferimento l’approccio cioraniano: ritenere i frammenti di Cioran immediati, come fa van Itterbeek, «usciti da un ‘incendio’ o da un naufragio», «improvvisamente apparsi» in una «furia elementare», [p. 17]» significa pensare al filosofo di Rășinari come a un Bukowski leggermente più erudito e non aver colto lo spessore teoretico del frammento cioraniano. Lo stesso esercizio filologico si può fare anche con molti frammenti di Le livre des leurres, rimaneggiati nei Quaderni e, alcuni dei quali, pubblicati nelle opere degli anni ’70 e ’80. In tal senso, il Taccuino non ha un carattere a sé, come sostiene van Itterbeek, e non va distinto dal Cahier; esso non solo indica un’opera ben precisa ma conserva testimonianza del gesto della scrittura di Cioran.
In questi pochi frammenti, inoltre, vengono gettate le basi di quell’arte del «pensare contro sé stessi», che annovera tra i grandi Maestri Nietzsche, Baudelaire e Dostoevskij. Cioran deve confessare che «Il mio difetto è di non riuscire a pensare contro me stesso; il pensiero si confonde con l’umore. Sono presente persino nella logica». [p. 41]
Lo stesso concetto verrà riaffermato in Le Crépuscule des pensées («Je découvrirai la vie dans sa plénitude lorsque je commencerai à penser contre moi, lorsque je ne serai plus présent dans aucune pensée…») e troverà sviluppo più sistematico nel primo capitolo di La tentazione di esistere, intitolato «Pensare contro sé stessi».
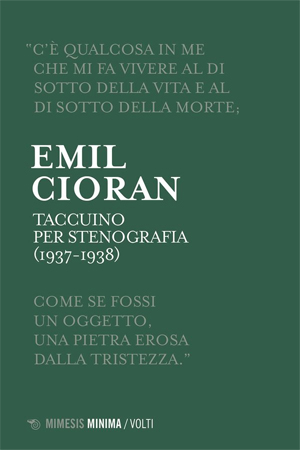
Arlindo Hank Toska
(n. 1, gennaio 2023, anno XIiI)
| |