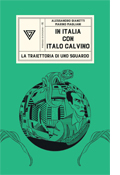|
|||
In Italia con Italo Calvino. Intervista doppia ad Alessandro Gianetti e Marino Magliani
Magliani: Forse, per quanto mi riguarda, è solo il viaggio di Ramón, un uomo che era stanco, fin da ragazzo, di spaccarsi la schiena nelle fasce davanti al mare, con un destino così diverso da quello del ragazzo Calvino, figlio del botanico e proprietario della terra di san Giovanni. Un giorno Ramón scopre quanto Italo Calvino, suo coetaneo, sia diventato famoso e si decide a ripercorrerne le piste della vita. Gianetti: È un’invenzione letteraria con un proprio stile; e lo stile, diceva Calvino, è senso e morale. Magliani: Ramón è una «necessaria invenzione letteraria». Calvino da ragazzino aveva un progetto letterario: far viaggiare un bambino lungo i binari per cercare la fine degli stessi. Ramón diserta la ferrovia ma un po', crede lui, si sente anch'egli inventato da Calvino. Certamente, come nota lei, Ramón è un perdedor per dirla nella lingua di suo padre, che era un anarchico spagnolo, e io, ma forse anche Alessandro, amiamo tradurre la letteratura dei perdedores ispanoamericani, e quindi, in quel senso, di inventarne anche di nostra. Gianetti: Quando si scrive della Liguria, della Toscana e più in generale dell’Italia si deve fare attenzione a non cadere in simili tentazioni. Il rimedio può essere la materia; nel nostro caso le fasce, le cave di ardesia, la pineta e i tetti di Roma, le isole. L’allegoria nasce da lì, come ci insegna Cosimo Piovasco di Rondò, che fece della sua vita sugli alberi una metafora. Magliani: Ci siamo rifatti, tra l'altro, alle pagine di Calvino, soprattutto a La strada di San Giovanni, in cui lautore descrive la sofferenza, la fatica e la severità di una terra interna situata davanti al mare ma lontana dalla sua mondanità. Gianetti: Io e Marino siamo anche noi due vagabondi, come Ramón. Facciamo la spola tra l’Italia e l’estero, scriviamo e traduciamo libri, abbiamo molti punti in comune. E tuttavia è stata una sorpresa accorgermi che il suo sguardo e il mio confluivano da soli nella scrittura di questo libro. Forse entrambi desideravamo scriverlo da tempo. Magliani: Abbiamo parlato molto, anche durante la stesura, se ben ricordo. Io vivo in Olanda e lui a Siviglia, io ho qualcosa da dire sulla Liguria estrema in cui Calvino è cresciuto, lui sulla Toscana, la Toscana delle pinete dove Calvino ha trovato la morte. Gianetti: Senza Pavese non si capisce Calvino, e questo vale per sia l’amicizia che li legò, sia per l’insegnamento che Pavese rappresentò per il giovane Calvino, ma anche per la differenza di sguardo sulla vita e sulla scrittura. Magliani: Credo che Pavese sia parso un riferimento indispensabile a Ramón, più che agli autori, è lui, Ramón (chissà se Gianetti sarà d'accordo, magari ci troviamo distante su questo punto o su altri, ma è giusto che ognuno fornisca le sue risposte autonomamente, a costo di ripeterci) che indaga il carattere di Calvino e si stupisce nello scoprire che sì, Pavese è stato un maestro per Calvino, ma con quelle riserve che le stesse parole di uno e dell'altro, pubbliche e private, sotto forma di lettere, fanno emergere. Gianetti: Il nostro personaggio è un faticante privo d’istruzione, che usa i libri di Calvino per interpretare il mondo. Non si deve però confondere la leggerezza di Calvino con un distacco – che non l’ha quasi mai colpito – tra la concretezza e la fiaba. La sua straordinaria popolarità credo risieda appunto in questo, nell’aver concepito volatili allegorie senza dimenticare le piante, le terre, la storia della sua gente. Magliani: È la fatica di Ramón, è quel suo essere dolorante e sofferente, bracciante, operaio, la sua fatica stessa va pari passo con la sua scarsa cultura, con la difficoltà nel leggere certe opere di Calvino, nel sentirle estranee, una condizione ideale, in qualche modo, che gli rende Calvino irraggiungibile. Gianetti: La biografia e il saggio, benché narrativo, erano per così dire iscritti nel libro che eravamo chiamati a scrivere. Il nostro contributo risiede nella storia di fondo. Non era scontato che questi luoghi fossero raccontati attraverso gli occhi di uno come Ramón. Magliani: Sapevo molto bene, e ce lo siamo detti, che sarebbe stato difficile scrivere un altro saggio su Calvino come ne sono stati scritti in passato e ultimamente. Uno perché, parlo per me, non sarei stato in grado di reggere la qualità di certi libri, due perché – e ancora una volta parlo per me – avevo qualcosa da dire come figlio di un contadino che imparato una lezione senza metterla in pratica, che forse altri non avevano. Riuscivo a ragionare insomma come era capitato a lui di ragionare e di raccontarsela? Gianetti: «Sono tanto nato a Sanremo che sono nato in America», disse Calvino in un’intervista. Nel posto dove si nasce si torna sempre, fa parte del caso. L’importante è il viaggio che si compie. Magliani: Secondo mente si gioca tutta lì la sua forza, da lì parte, dalla visione del mondo in discesa. Gianetti: Forse la domanda più importante. Confrontarsi con Calvino è guardare da vicino uno scrittore che sapeva pensare come romanziere, saggista e critico della propria epoca; un autore immerso in una realtà che leggeva e al contempo cercava di trasformare. Dà l’impressione di aver vissuto almeno due volte; la prima nel mondo di tutti, la seconda in un universo tutto suo. Si impara o si cerca di imparare, leggendolo, a guardare: la cosa più difficile. Magliani: Per scrivere questo libro ho viaggiato molto attraverso quello che mi piace chiamare il marsupio, l'entroterra frequentato da Calvino da bambino, ragazzo, e partigiano, ora scoprendolo, ora ritrovandolo, dopo tanti anni e libri. Gianetti: Vorrei tanto chiedergli come sta. Magliani: Io, che sento il senso di colpa di non aver seguito nei pomeriggi pieni di brusii di insetti, mio padre negli orti e sotto gli ulivi, così come è capitato a lui quasi quarant'anni prima, chiederei a Calvino di starcene un po’ in silenzio all’ombra di un fico e ogni tanto alzarci e faticare a schiena bassa nei solchi di pomodori e fagiolini. Per ultimo raccogliere un po' di pomodori, tagliarli, usare olio buono, del nostro, due foglie di basilico, cipolla e aglio se era nel suo gusto, aceto, ma siccome è davvero una questione di gusti, condirli ognuno per conto nostro, e mangiarli sotto il fico, in silenzio, anche senza guardare il mare. A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone |
|||