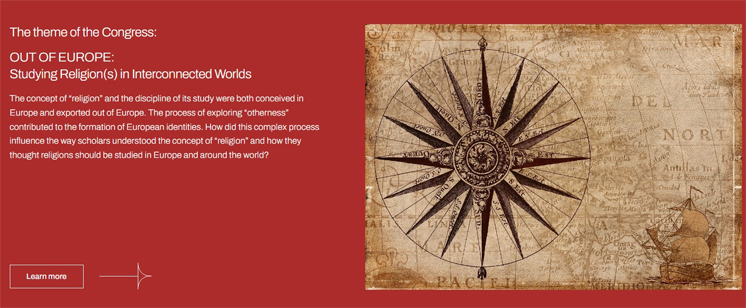|
|
Dopo il Congresso Internazionale di Storia delle Religioni di Cracovia
 Dal 24 al 30 agosto 2025 si è tenuto, nell’antica città universitaria polacca di Cracovia, il ventitreesimo congresso di storia delle religioni. I congressi dell’Associazione Internazionale di Storia delle Religioni (IAHR) si svolgono ogni cinque anni. L’ultima edizione si è tenuta a Erfurt, in Germania, nel 2015. L’edizione del 2020, che si sarebbe dovuta svolgere a Otago, in Nuova Zelanda, è stata annullata a causa della pandemia di COVID-19; pertanto, quella di Cracovia è la prima dopo una pausa di dieci anni. Al congresso hanno partecipato oltre mille professori e ricercatori provenienti da ogni angolo del mondo e di tutte le fasce d’età, il cui numero impressionante testimonia lo sviluppo attuale della disciplina, nonostante la crisi metodologica che sta attraversando il mondo delle scienze umane, compresa la storia delle religioni. Dal 24 al 30 agosto 2025 si è tenuto, nell’antica città universitaria polacca di Cracovia, il ventitreesimo congresso di storia delle religioni. I congressi dell’Associazione Internazionale di Storia delle Religioni (IAHR) si svolgono ogni cinque anni. L’ultima edizione si è tenuta a Erfurt, in Germania, nel 2015. L’edizione del 2020, che si sarebbe dovuta svolgere a Otago, in Nuova Zelanda, è stata annullata a causa della pandemia di COVID-19; pertanto, quella di Cracovia è la prima dopo una pausa di dieci anni. Al congresso hanno partecipato oltre mille professori e ricercatori provenienti da ogni angolo del mondo e di tutte le fasce d’età, il cui numero impressionante testimonia lo sviluppo attuale della disciplina, nonostante la crisi metodologica che sta attraversando il mondo delle scienze umane, compresa la storia delle religioni.
Il tema di quest’anno era Out of Europe: Studying Religion(s) in Interconnected Worlds, un titolo che conferma il desiderio di aprire il campo degli studi storico-religiosi all’universalità e a un mondo multipolare, in modo tale da ridurre le distanze non solo spaziali ma soprattutto culturali; distanze visibili il più delle volte attraverso gerarchie, talora arbitrarie, tra centri e periferie, tra imperi e colonie. Mircea Eliade ha spesso parlato del provincialismo della cultura occidentale, della tendenza autoreferenziale nel suo sistema di pensiero e dell’opacità nei confronti dell’alterità delle culture extraeuropee, in senso sia sincronico che diacronico. Egli è stato non solo uno dei padri fondatori della disciplina – ha partecipato alla prima edizione del congresso tenutasi nel 1950 ad Amsterdam –, ma anche uno dei pionieri dell’apertura della storia delle religioni a tutte le religioni del mondo, non tanto al livello del rapporto soggetto-oggetto tipico del razionalismo dei secoli scorsi, quanto piuttosto a quello che contraddistingue le società aperte, post-razionali e post-coloniali.
In questo breve report, vorrei segnalare in particolare un panel del congresso dedicato all’opera di Mircea Eliade, il primo dopo venticinque anni, quando si tenne un altro panel sullo stesso tema nell’ambito del congresso IAHR a Durban, in Sudafrica (2000). Una parte dei lavori presentati in quel panel è stata pubblicata nel volume The International Eliade (New York, State University of New York Press, 2007), a cura del professor Bryan Rennie, un noto esperto di Eliade. Il panel di quest’anno, che ha avuto luogo il 25 agosto (il primo della prima giornata), era intitolato «Mircea Eliade and the Other: Prospective and Retrospective» e ha riunito i lavori di alcuni ricercatori italiani e romeni, a testimonianza dell’attuale interesse per l’opera e il pensiero di Mircea Eliade. A parte il mio intervento («Modern Art as Symbolic Representation. A Critical Analysis of Modernism in Mircea Eliade’s Works»), vorrei riportare qui i titoli delle relazioni presentate dagli altri partecipanti: Wilhelm Dancă, «Homo symbolicus in Mircea Eliade’s “Memoirs”»; Luca Siniscalco,«Interpreting with Hermes: Comparing Mircea Eliade’s and Hans-Georg Gadamer’s Hermeneutics«; Igor Tavilla, «Kierkegaard and Eliade on Repetition». Il professor Wilhelm Dancă è specializzato in filosofia e teologia ed è autore, tra l’altro, del volume Mircea Eliade. Definitio Sacri (ultima edizione: Bucarest, Spandugino, 2022). Luca Siniscalco, cultore della filosofia tedesca contemporanea, dell’estetica, dell’ermeneutica e della filosofia della religione, sta preparando una tesi di dottorato in cotutela (Università di Bergamo e Justus-Liebig-Universität Gießen) dal titolo The Event of the Sacred in the Post-Secular Age. Encounters with Hans-Georg Gadamer’s Hermeneutics, Hermann Nitsch’s and Anselm Kiefer’s Art. Igor Tavilla ha una formazione filosofica ed è uno specialista dell’opera di Søren Kierkegaard, avendo pubblicato diversi volumi di studi e tradotto dal danese all’italiano diverse opere di e sul pensatore di Copenaghen. Negli ultimi anni, Tavilla si è inoltre occupato dello studio e della traduzione di autori romeni, fra cui Nae Ionescu, Mircea Eliade (del quale ha tradotto, insieme a Horia Corneliu Cicortaș, l’edizione integrale della narrativa fantastica) e Tatiana Niculescu (sempre insieme a Cicortaș). Il panel ha goduto della presenza del prof. Giovanni Casadio, presidente della Società Italiana di Storia delle Religioni e già docente presso l’Università di Salerno. Del resto, in qualità di appassionato ed eminente studioso dell’opera di Mircea Eliade, è stato proprio lui a promuovere l’organizzazione del panel nell’ambito di un evento prestigioso come il congresso della IAHR. Riccardo Nanini ha svolto il ruolo di discussant, commentando le comunicazioni di Siniscalco e Tavilla e tracciando alcune conclusioni sull’interpretazione dell’opera di Mircea Eliade nella prospettiva della filosofia moderna.
Il professor Giovanni Casadio, che ha partecipato alla tavola rotonda «Globalization and the Academic Study of Religion: a Methodological Trojan Horse?», insieme ad altri sei illustri studiosi, tra i quali Tim Jensen e Marco Pasi, ha moderato anche la quarta sessione del panel «Rethinking the History of Religious Studies: Beyond Post-Colonialism and Eurocentrism», la cui seconda sessione è stata moderata dallo studioso romeno Sorin Antohi. Antohi e Casadio hanno presentato le loro relazioni, rispettivamente su Ioan Petru Culianu e Raffaele Pettazzoni, durante la prima sessione del panel, insieme all’orientalista di fama mondiale Michael Pye [1].
Oltre ai tanti panel, troppo numerosi per essere menzionati qui, il congresso ha ospitato diverse sessioni plenarie, conferenze dei più importanti specialisti del settore, riunioni dell’Associazione Europea per lo Studio delle Religioni (EASR) e della Società Italiana di Storia delle Religioni (SISR).
Va segnalata inoltre la partecipazione, ormai costante nel corso degli anni, di diversi ricercatori romeni delle generazioni più giovani, fra cui Alina Pătru, la quale ha tenuto una comunicazione sul fenomeno religioso nella società romena odierna [2], Eduard Iricinschi, che ha partecipato al panel «Ritualized Emotions (I): Power, Hierarchies, and Emotional Strategies in Social Structures» (insieme ad altri tre ricercatori italiani), Daniela Dumbravă (con una comunicazione sulle esplorazioni asiatiche di Nicolae Milescu), Bogdan Tătaru-Cazaban (sull’approccio alle religioni nell’opera giovanile di M. Eliade) e Daniel Dumitran, che ha trattato l’illuminismo ebraico e la questione della tolleranza nello spazio romeno e centro-europeo, nell’ambito delle due sessioni del panel «A Comparative Religious History of Central-Eastern Europe, 1500-2000: Problems, Methods, Perspectives» [3].
In chiusura di queste righe, ricordiamo che la prossima conferenza EASR si terrà a Bucarest nel settembre del prossimo anno, a vent’anni di distanza dalla prima conferenza ospitata in Romania: un ritorno, in qualche modo simbolico, ai luoghi natii di Mircea Eliade, uno dei padri fondatori della storia delle religioni come disciplina accademica. [4]
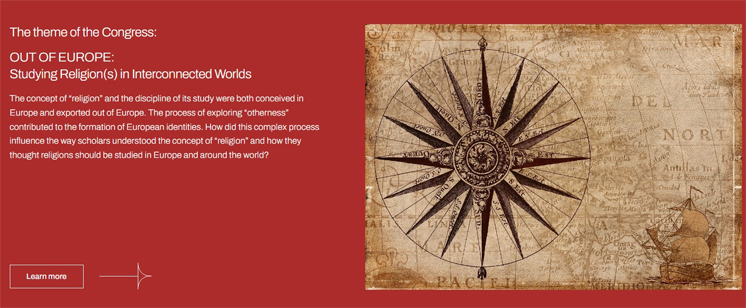
Gabriel Badea
(n. 10, ottobre 2025, anno XV)
NOTE
[1] Giovanni Casadio & Márcia Maria Enéas, «Pettazzoni’s Integrative Approach to the Science of Religions»; Sorin Antohi, «From Historicism to Cognitivism: Ioan Petru Culianu and he History of Religious Studies».
[2] A. Pătru, «Religious return and individualization in present-day Romania. The 2024 presidential elections and their significance for the study of contemporary religious dynamics».
[3] D. Dumbravă, «The peoples descended from Iafet and Ginghis Khan – an investigation into the development of religion and proto-ethnography in the exploration of Nicolae Milescu (1675-1676). A comparative historical-religious study»; B. Tătaru-Cazaban, «A Question of Subjectivism? Eliade’s Approach to Religions in an Early Manuscript Note»; D. Dumitran, «The Jewish Enlightenment and the Issue of Tolerance in Central European and Romanian Context».
[4] Desidero ringraziare il prof. Casadio per i suoi suggerimenti, di cui ho tenuto conto durante la redazione della versione italiana di questo articolo, che riprende – con lievi modifiche e aggiustamenti – quella romena, pubblicata il mese scorso. |
|