









|
|
Antologia Giuseppe Pontiggia. Da «Il giocatore invisibile»
 Era quasi sempre vero, del resto. Il problema del tempo libero, di cui favoleggiavano sui giornali, per lui era il problema di averne. E quanto meno ne aveva, tanto più se ne prendeva fatali ritagli nel corso del lavoro, per poi trovarsi alla fine con l’acqua alla gola. Ma erano ventitré anni che usava questo paragone, senza mai rimuoverne la causa: e una volta rifletté che per un nuotatore l’acqua non è poi così temibile, anzi è necessaria, soprattutto alla gola. Talora quando rileggeva, tra un manoscritto e l’altro, certi libri che aveva in biblioteca, la pagina iniziale del Circolo Pickwick o di Moby Dick, ad esempio, oppure Pel di Carota o i Viaggi di Gulliver, provava una inattesa commozione, come se incontrasse autori di un altro pianeta e che però scrivevano proprio per lui. Era quasi sempre vero, del resto. Il problema del tempo libero, di cui favoleggiavano sui giornali, per lui era il problema di averne. E quanto meno ne aveva, tanto più se ne prendeva fatali ritagli nel corso del lavoro, per poi trovarsi alla fine con l’acqua alla gola. Ma erano ventitré anni che usava questo paragone, senza mai rimuoverne la causa: e una volta rifletté che per un nuotatore l’acqua non è poi così temibile, anzi è necessaria, soprattutto alla gola. Talora quando rileggeva, tra un manoscritto e l’altro, certi libri che aveva in biblioteca, la pagina iniziale del Circolo Pickwick o di Moby Dick, ad esempio, oppure Pel di Carota o i Viaggi di Gulliver, provava una inattesa commozione, come se incontrasse autori di un altro pianeta e che però scrivevano proprio per lui.
Quello che stavano dicendo lo riguardava, lì, in quel momento, in piedi nel suo studio, senza bisogno di appelli e di riletture, con la felicità vivificante di una intimità completa. Quando poi ritornava a un manoscritto di trecento pagine dove magari – per esplicita volontà dell’autore – capiva “tutto”, non si sentiva più nella condizione giusta per giudicare. Spesso l’autore falliva non perché non avesse qualità, ma perché non sapeva rinunciare a qualcuna. Ingordo e infantile, si comportava come quei clienti che, in un pranzo a prezzo fisso e scelta libera, non sanno rinunciare a nessuno tra i primi piatti e al secondo, come il cuoco ha previsto, arrivano esausti. Talora, rileggendo questi giudizi, si accorgeva di avere sbagliato il tono, la valutazione, la previsione, e se ne sentiva responsabile. Le lettere di rifiuto erano invece opera degli editori e venivano elaborate sulla base di una robusta diffidenza nella obiettività del destinatario, atteggiamento ricambiato con uguale convinzione dall’altra parte; larghe di lodi e di ritrattazioni, esse sconfinavano, come i risvolti e la pubblicità, nell’immaginario: la verità era un accidente in cui potevano anche incorrere, ma casualmente.
“Immaginario” era una parola che gli piaceva. E anche la protagonista del romanzo che avrebbe scritto – il giorno che si fosse liberato dei suoi impegni di lavoro e avesse potuto dedicargli tutte le energie – era vittima di una gravidanza immaginaria. Si era documentato su questi casi non frequenti, in cui la gestazione può durare nove mesi e arrivare alle doglie del parto: talora anzi al parto stesso, che consiste in una improvvisa e completa emissione dell'aria, al momento ormai indifferibile della verità. Questa sarebbe stata la conclusione del romanzo e più ci pensava più la trovava aderente a quello che lui aveva capito del mondo. E quando ne aveva parlato con le sue tre donne, in luoghi e tempi diversi – con una al cinema, con l’altra sulle scale, con la terza in taxi – tutte e tre avevano mostrato segni. di curiosità, e così anche un editore e due amici: soprattutto per quello sgonfiarsi e afflosciarsi del finale. S’era persuaso, giudicando e correggendo testi altrui, che una idea narrativa, perché sia buona, deve convincere anche se riassunta in poche frasi. Certo se, esponendo la sua, sbagliava un verbo o un aggettivo, sentiva incrinarsi e indebolirsi tutta la trama, ma questo era giusto: ogni parola è un mondo e non ci si può permettere distrazioni. Però a volte temeva che l’interesse per la sua storia fosse suscitato soprattutto dalla sua abilità nello scegliere e collocare le parole, esercitata da una lunga esperienza di risvolti: e che, una volta che si fosse applicato a svilupparla, ad ampliarla in un romanzo, l’idea si sarebbe rivelata una bolla d’aria. Come quella della sua protagonista. Lo facevano trasalire d’angoscia anche il passare del tempo e l’avanzare dell’età, ma lo confortava il pensiero che molti narratori danno il meglio di sé nella maturità. Gli esempi però, a mano a mano che aumentavano gli anni, diminuivano di numero. De Foe e Swift, a parte pochi minori, erano i classici che ancora gli restavano.
Cattaneo abitava nel quartiere più vecchio della città, una roccaforte di facciate scrostate, forate da portoni bassi e bui, per cui si penetrava in cortili sporchi, con scale di pietra esterne e piante rampicanti, si avanzava in altri cortili circondati da ringhiere e coperti da lucernari grigi, e si sbucava improvvisamente in nuovi spiazzi, con botteghe di ferramenta, negozi di lavanderia, vetrine polverose con la scritta “Vini” e intorno uno sventolio di panni lungo balconi di ferro. A volte si finiva su mucchi di immondizia, su piramidi di copertoni e di automobili sfondate, tra finestre inchiodate con assi, in case abbandonate dagli inquilini, tranne qualche piano, dove si vedeva magari una vecchia immobile vicino a una canna fumaria che usciva dal muro.
In uno di questi cortili, al termine di due portici dalle volte basse, ci si trovava di fronte, inaspettatamente, ad una collinetta di qualche metro, con in cima una casa minuscola di un solo piano, addossata, nell’angolo, a un altro muro di cinta, oltre il quale salivano i palazzi del quartiere moderno. Un arco di ferro incorniciava un viale a gradini di pietra che portava all’ingresso. Qui Cattaneo abitava con i suoi, che non si erano mai rassegnati a questa scelta, soprattutto sua moglie, anche se da principio aveva mostra un incerto entusiasmo. Ma poi l’angustia dei locali, gli sbalzi della temperatura, d’estate e d’inverno, lo squallore delle ringhiere sulla facciata di fronte la facevano guardare con invidia, alle sue spalle, agli appartamenti moderni che si travedevano nell’altro quartiere, grappoli di balconi che sporgevano da edifici a cubi sovrapposti. Lui l’aveva persuasa a pazientare fino alla pensione, quando avrebbe cominciato il romanzo e una vita nuova. Nel frattempo continuava a ricevere i plichi degli editori in una portineria invasa dai fumi della cucina e gli ospiti nell’unico locale ampio della casa, la sala-studio con il divano-letto ribaltabile e le finestre che si affacciavano su un pendio di sei metri.
Quella sera temporalesca stava sull'uscio a prendere il fresco, nella sua poltrona di vimini. Guardava le ultime nuvole di un rosa pallido, al di sopra dei tetti. Fu appunto in quella posizione, gli occhi socchiusi e le braccia abbandonate fuori dalla poltrona, che il professore lo vide, sbucando dal portico.
“Ciao!” gli gridò mentre si inerpicava per il vialetto di pietra.
“Ti aspettavo” gli disse. “Ma che faccia hai?”
“Stanca, vero?”
“Sì” rispose Cattaneo con un viso preoccupato. “È successo qualcosa?”
“Adesso ti spiego” gli disse il professore, riprendendo la salita e precedendolo sulla porta. “Sono venuto per questo”.
tratto da Il giocatore invisibile, di Giuseppe Pontiggia
© 1997 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano
© 2018 Mondadori Libri S.p.A., Milano
Per gentile concessione degli Erede e dell'Editore.
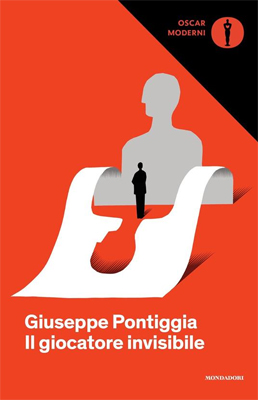
(n. 9, settembre 2023, anno XIII)
|
|

