









|
|
Dalla periferia latina dell’Impero sovietico, il primo romanzo dello scrittore moldavo Iulian Ciocan
 Iulian Ciocan è uno degli autori moldavi più tradotti. I suoi libri sono apparsi in Francia, Serbia, Repubblica Ceca, Olanda e Stati Uniti. Già ospite del PEN World Voices Festival di New York e della European Literature Night di Amsterdam, Ciocan è autore di una «trilogia moldava» inaugurata nel 2007 con il romanzo Prima che Brežnev morisse, recentemente pubblicato in Italia dalla casa editrice Bottega Errante grazie alla traduzione di Francesco Testa. Come scrive Filip Noubel nella quarta di copertina, «i personaggi di Ciocan lottano con scelte morali, nostalgia per il passato e aspettative irrealistiche. Questa esperienza traumatica di dover ricostruire completamente il proprio sistema di valori, ricreare la posizione sociale e sopravvivere in un ambiente nuovo e raramente misericordioso è ciò che milioni di cittadini sovietici, incluso Ciocan, hanno vissuto direttamente negli anni Novanta». Iulian Ciocan è uno degli autori moldavi più tradotti. I suoi libri sono apparsi in Francia, Serbia, Repubblica Ceca, Olanda e Stati Uniti. Già ospite del PEN World Voices Festival di New York e della European Literature Night di Amsterdam, Ciocan è autore di una «trilogia moldava» inaugurata nel 2007 con il romanzo Prima che Brežnev morisse, recentemente pubblicato in Italia dalla casa editrice Bottega Errante grazie alla traduzione di Francesco Testa. Come scrive Filip Noubel nella quarta di copertina, «i personaggi di Ciocan lottano con scelte morali, nostalgia per il passato e aspettative irrealistiche. Questa esperienza traumatica di dover ricostruire completamente il proprio sistema di valori, ricreare la posizione sociale e sopravvivere in un ambiente nuovo e raramente misericordioso è ciò che milioni di cittadini sovietici, incluso Ciocan, hanno vissuto direttamente negli anni Novanta».
Un pomodoro marcio
Lanciato dal quinto piano del palazzone popolare con l’inconfondibile precisione di un tiratore scelto, il pomodoro marcio esplose sul capo calvo e lucente di Polikarp Feofanovič. Per un attimo, il veterano-da-poco-pensionato fu colto da un forte spavento che immediatamente si trasformò in un senso di imbarazzo e stupore alla vista di quel liquido, viscoso e maleodorante, che gli colava sul viso e sul collo. Sarebbe voluto sprofondare sottoterra. Sentiva tutti gli occhi puntati addosso. Lassù, da qualche parte, udiva sghignazzare. Con mano tremante estrasse dalla tasca dei pantaloni un fazzoletto stropicciato e si guardò attorno impaurito. Nonostante fosse pieno giorno, il cortile era deserto. Tirò un sospiro di sollievo. Lanciò uno sguardo ai piani superiori dell’edificio. La testa bislunga di un bambino sporgeva dalla balaustra in cemento armato del balcone, nascosto sotto la gronda del tetto e ingombro di cianfrusaglie.
D’un tratto si ricordò di Veniamin Nikanorovič, il difensore di Stalingrado, l’amico con cui giocava a domino e andava a pesca di carpe a Ghidighici, il quale a volte si lamentava di venir “bombardato” nel bel mezzo della giornata con uova e pomodori marci. Soltanto in quel momento Polikarp Feofanovič realizzò di non aver preso sul serio una questione tutt’altro che innocua. Aveva serenamente ignorato un’empietà che di norma avrebbe dovuto farlo riflettere: dei bambini – forse pionieri o membri i del Komsomol – prendevano per i fondelli i veterani dell’Armata Sovietica. Colto da inquietanti rimorsi di coscienza, gli tornò alla mente un altro particolare: Veniamin Nikanorovič, quando parlava di quei fatti incresciosi, abbassava ogni volta il tono della voce e lo sguardo si perdeva nel vuoto. Peraltro, l’idea che fossero soltanto scherzi infantili, come voleva Polikarp Feofanovič, faceva innervosire Veniamin Nikanorovič. Un giorno, quando il veterano-da-poco-pensionato non era riuscito a trattenere le risa udendo quelle parole bisbigliate che evocavano la tragicomica esperienza dell’amico, investito da una pioggia di uova marce, il difensore di Stalingrado gli aveva voltato le spalle e per giorni interi non gli aveva più parlato.
Sovrappensiero, Polikarp Feofanovič sentì un imperioso bisogno di urinare. La vescica gli stava per esplodere, inviava disperati messaggi di SOS. Si guardò attorno, raggiunse in tutta fretta le aiuole di fronte al grigio casermone, tirò fuori quatto quatto il membro raggrinzito e pisciò a lungo, a intermittenza, il viso paonazzo per lo sforzo. All’improvviso sbucò una donna, aveva la schiena curva a causa delle pesanti buste della spesa, strabuzzò gli occhi e accelerò il passo. Il secondo pomodoro, lanciato da quello scalmanato dalla testa bislunga, mandò su tutte le furie Polikarp Feofanovič. Nel tentativo di proteggersi cadde sul sedere, alcune gocce di urina gli macchiarono i pantaloni. Chiuse la cerniera e si diresse con decisione verso l’entrata dell’edificio. Non era abituato a scalare tutti quei gradini (abitava al pianterreno) e sbuffava come una locomotiva. Suonò il campanello di una porta ricoperta da uno spesso strato di sporcizia. Si udì un impercettibile ronzio seguito da un silenzio di tomba. Suonò di nuovo. Alla fine sentì avvicinarsi dei passi e una testa bislunga spuntò fuori dalla porta socchiusa. Era un ragazzino dalle guance scavate e dallo sguardo penetrante.
«Chiama i tuoi genitori!» tuonò il veterano-da-poco-pensionato.
«I miei genitori sono al lavoro e non vogliono che parli con gli sconosciuti. Chi sei?» domandò la testa bislunga con malcelato stupore.
«Questa è buona! Cosa intendi, moccioso? Mi tiri i pomodori addosso e ora fai finta di niente?».
Polikarp Feofanovič schiumava di rabbia.
«Se non te ne vai chiamerò la polizia!» disse lo sfacciato, urlando a gran voce e sbattendogli la porta in faccia.
Il veterano-da-poco-pensionato rimase a bocca aperta. Scese le scale lacerato da un acuto senso di umiliazione. Sentiva che non se ne sarebbe liberato neanche dopo che i genitori e il dirigente scolastico del piccolo teppista gliel’avessero fatta pagare.
Rientrato a casa, nel suo spazioso appartamento composto da tre camere dove, dopo la morte della moglie, regnava il disordine, fu assalito da un cronico senso d’inquietudine. Andò in bagno e cercò a lungo di svuotare la vescica, gemendo dal dolore. Poi mangiò dello stufato di fagioli. Inarcò le sopracciglia e trangugiò le medicine prescritte dall’urologo, crollando stremato e depresso sul letto dove ogni notte si pisciava addosso. Per la prima volta pensò di essere troppo vecchio per continuare a lottare contro l’ingiustizia. Realizzò con tristezza di aver trattato – proprio lui – Veniamin Nikanorovič in modo poco gentile. Il sonno scese solo dopo aver ingerito i sonniferi. Un sogno ricorrente, per nulla piacevole, s’interrompeva ogni volta prima del finale.
Si trovava a un funerale, in un edificio semidistrutto da un bombardamento. Al centro una bara: da un lato un bambino e una donna, china e disperata, che piangevano dal dolore, dall’altro c’era lui, Polikarp Feofanovič, in imbarazzo. A tratti, la donna e il bambino fulminavano Polikarp Feofanovič con lo sguardo, apostrofandolo in tono accusatorio. Ma lui non riusciva a capire cosa dicessero. Vincendo la paura si avvicinava lentamente al feretro dove giaceva… Stop! Il sogno s’interrompeva all’improvviso, il veterano-da-poco-pensionato si svegliava trafitto da un terrore insondabile e col cuore in gola. Fu così per molti anni. Ma quel giorno, forse a causa dei sonniferi, il sogno prese una piega ancora più inquietante. Finalmente riuscì a comprendere le parole di quella donna macilenta che parlava in tedesco, la quale lo accusava della morte del marito. Questa volta il sogno non si interruppe, come di consueto, mentre si avvicinava alla bara. Vide allora il cadavere di un nazista in uniforme militare e capì che si trattava del prigioniero ucciso nel 1944 per una tentata fuga. Il fatto che avesse una moglie e un figlio angosciò Polikarp Feofanovič. Il cadavere, per giunta, cominciò a prendere le sembianze di un bambino dalla testa bislunga, gli occhi infossati che ardevano nelle orbite e la faccia livida. Saltò fuori dalla cassa da morto e gli lanciò contro un pomodoro marcio, urlando a squarciagola: «Chiamo la polizia!».
Polikarp Feofanovič si svegliò nel cuore della notte, rivoltandosi tra le lenzuola sgualcite. Dopo essersi calmato, scese dal letto e accese la lampada. Urinò per terra prima ancora di raggiungere il bagno. Con gli occhi offuscati dal sonno cercò invano un paio di mutande pulite tra i vestiti ammucchiati uno sull’altro nell’armadio. Guardò dalla finestra: fuori il buio era impenetrabile. Si mise a sedere su una poltrona, cercando di individuare la causa del suo malessere. Aveva la sensazione di conoscere il teppista dalla testa bislunga. Paradossalmente, quell’impressione si rafforzò contemplando il disordine nella camera da letto. Fu una rivelazione repentina e sconcertante. Incredulo, realizzò che il teppista era uno di quei cortesi pionieri inviati dalla scuola russo-moldava, solo un anno prima, per riordinargli la casa e fargli la spesa.
Al diavolo! Quel pioniere dalla testa bislunga era un bambino affabile e intraprendente, un ragazzino dallo sguardo cordiale. Ci poteva mettere la mano sul fuoco. Si ricordò distintamente quando lo aveva aiutato a sbattere tutti i tappeti e a ripulire il forno, o quando pieno di entusiasmo gli aveva chiesto, dopo che i compagni impazienti se ne erano andati, di raccontare il suo glorioso passato. Aveva fissato assorto gli occhi di Polikarp Feofanovič mentre narrava la crudeltà degli invasori nazisti e l’eroismo dei soldati sovietici, le sanguinose battaglie cui aveva preso parte e la liberazione, ovviamente, della Moldavia sovietica. Grazie a quel ragazzo curioso, da cui veniva spesso interrotto perché ricordasse ogni minimo dettaglio, Polikarp Feofanovič aveva ritrovato un bisogno di comunicare rimasto a lungo sopito. Com’era possibile che un pioniere così assennato si fosse trasformato in uno scapestrato? Come poteva bersagliarlo di pomodori quel bambino che aveva ripulito il suo appartamento? Con lui non si era mai mostrato scortese. Al contrario, in più di un’occasione gli aveva dato qualche soldo per comprarsi un gelato. Di certo il ragazzino non era uno svitato, nonostante la testa bislunga potesse far pensare alle conseguenze di un’infanzia difficile. Ma come si poteva parlare di infanzia difficile per quei pionieri che vivevano l’epoca del socialismo avanzato? Era fuori discussione. Polikarp Feofanovič emise un profondo sospiro. La sua generazione aveva avuto un’infanzia piena di difficoltà.
Senza volerlo, ripensò a una situazione imbarazzante. Una volta era entrato in un negozio di alimentari dove la gente stava in fila per acquistare le salsicce Doktorskaja. Si era diretto verso la cassa dicendo ad alta voce: «Sono un veterano!». Stanche ma rispettose, le persone si erano fatte da parte. Tuttavia, un villano dai capelli lunghi, con indosso un paio di jeans, non si era lasciato per nulla impressionare dalle medaglie al petto e gli aveva urlato contro infuriato: «Ma cosa spingi! Pensi di esistere solo tu?». La commessa e i clienti, alla fine, erano riusciti a far rinsavire quel villano impertinente, ma Polikarp Feofanovič era rimasto avvilito tutto il giorno. Sforzandosi di ricordare, il veterano-da-poco-pensionato si rese conto di essere stato offeso e ridicolizzato in più di un’occasione: su un filobus strapieno dove nessuno gli aveva ceduto il posto, dove alcuni scolari, per giunta, si erano presi gioco di lui, chiedendogli, con tono canzonatorio, se non avesse male ai piedi; i giornali che erano spariti dalla sua cassetta postale, riempita di spazzatura; il vicino di casa, un ragazzo del Komsomol, che, dopo essere stato rimproverato perché si ostinava a scarabocchiare i muri del pianerottolo, gli aveva tolto il saluto; un gruppo di chiassosi sbandati – strimpellavano la chitarra davanti al palazzone in cui abitava – che non solo avevano ignorato le sue proteste, ma lo avevano invitato a togliersi dai piedi.
Un po’ alla volta l’amara verità stava venendo a galla: la giovane generazione era contaminata dall’indifferenza e dalla mancanza di senso etico. Tutta una serie di fatti era lì a dimostrarlo. Una paura profonda e divoratrice lo pervase. Pionieri e giovani del Komsomol non mostravano più rispetto per i veterani di guerra che avevano versato il proprio sangue per loro, e come se non bastasse la società non condannava l’andazzo generale delle cose. Quei teppisti restavano impuniti! Di conseguenza la società era malata.
Stava accadendo qualcosa di grave. All’apparenza era tutto come prima, se non addirittura meglio: i nemici del popolo erano stati annientati e la paura paralizzava gli avversari esterni. Ma non esistevano più lo slancio e l’entusiasmo del primo piano quinquennale, lo spirito eroico degli anni di guerra e la proverbiale bontà dei giovani. Tutto evaporato, a dispetto di una migliore qualità di vita. Non era forse l’assenza di nemici e avversità ad aver causato una tale decadenza morale? Prese di fretta il telefono e iniziò a digitare il numero di Veniamin Nikanorovič. Riattaccò subito, ricordandosi che era notte fonda. Tornò sulla poltrona e sprofondò nei ricordi.
Un tempo aveva conosciuto pionieri ben diversi, bambini straordinari che lavoravano al tornio e nei campi, aiutavano le famiglie dei militari inviati in battaglia, davano concerti negli ospedali, si prendevano cura dei feriti, spedivano pacchetti e lettere ai soldati in guerra. Ovunque si trovassero – lontani dalla linea del fronte, vicini alla zona dei combattimenti o in territori temporaneamente occupati dal nemico – erano rimasti sempre ligi ai doveri del pioniere, custodendo con cura le cravatte rosse e facendo tutto il possibile per favorire la vittoria. I nazisti non avrebbero mai potuto immaginare che Vladimir Kaznaceev, il feroce partigiano che aveva fatto saltare in aria quindici battaglioni, avesse soltanto quattordici anni. Migliaia di giovani eroi erano stati decorati con medaglie. I pionieri Marat Kazei, Lionia Golikov, Zina Portnova e Valja Kotik vennero insigniti post mortem del titolo di Eroi dell’Unione Sovietica, diversamente da quei pionieri che oggi lanciano in testa pomodori marci e mancano di rispetto. Perché i genitori e gli insegnanti facevano finta di nulla? Cosa sarebbe accaduto se il numero di questi individui insensibili e privi di ideali avesse continuato a moltiplicarsi? Gli fischiavano le orecchie. Urinò di nuovo. Programmò la sveglia per le sette e ingerì altri sonniferi. Poi si addormentò.
La mattina seguente il suo pessimismo aveva fatto passi da gigante, tanto che non volle più andare dall’urologo, che gli aveva prescritto un trattamento. A dire il vero, dal giorno in cui era morta la moglie le cose non andavano più troppo bene al veterano-da-poco-pensionato. Quell’uomo allegro e baldanzoso si era trasformato a poco a poco in un rottame. Mangiava male, non aveva la pazienza di cucinare e aveva cominciato a bere per evadere da quel senso d’inquietudine che lo rodeva dentro. Tuttavia, la vodka russa e il vino moldavo non facevano più per lui, come negli anni della gioventù, e così, grazie a Veniamin Nikanorovič, si era dedicato alla pesca. Ma dopo un violento attacco di prostatite fu costretto a smettere. In principio aveva avvertito un dolore diffuso e intermittente tra le gambe, poi aveva cominciato a pisciarsi addosso ripetutamente e il dolore, col tempo, era diventato insopportabile, causandogli sempre maggiori difficoltà a urinare. Ogni notte il silenzio dell’appartamento veniva spezzato da lamenti strazianti, accompagnati dallo strascichio lento delle pantofole e dal gorgogliare del lavello. Alla fine si era fatto coraggio e aveva raggiunto il policlinico. L’urologo Vasile Octavianovič, un uomo piuttosto noioso in presenza del quale non aveva mai l’impressione di disturbare, gli aveva prescritto antibiotici e vitamina E, esprimendo tuttavia il timore che i medicinali, senza un massaggio prostatico, non avrebbero sortito l’effetto sperato. Polikarp Feofanovič si era sentito preso in giro: alla sua veneranda età c’era qualcuno che voleva ficcargli un dito in culo. Ma Vasile Octavianovič credeva che non ci fosse nulla di cui vergognarsi. Da quel momento aveva avuto molto più tempo a disposizione: per paura di pisciarsi addosso davanti a tutti lasciava l’appartamento di rado, si appisolava davanti al televisore, giocava a domino con altri veterani e contemplava senza mai stancarsi delle fotografie ingiallite riesumate da un baule. Nonostante avesse trangugiato regolarmente gli antibiotici, quell’insopportabile disfunzione non gli dava tregua. Lo faceva infuriare. Anche Vasile Octavianovič era deluso per l’inefficacia del trattamento. Un giorno, dopo l’ennesimo massaggio rituale, l’urologo gli aveva chiesto di fermarsi; per alcuni minuti aveva osservato pensieroso il veterano a disagio, senza proferire parola. Aveva preso a parlare solo quando il silenzio si era fatto intollerabile: «Polikarp Feofanovič, faccio tutto il possibile affinché guarisca dalla malattia. Gli antibiotici, le vitamine e il massaggio hanno ridotto sensibilmente l’infiammazione alla prostata, ma… ho l’impressione che il suo contributo possa rivelarsi decisivo».
«Il mio contributo?» Polikarp Feofanovič sembrava non capirci più un accidente. «Ma non sono forse io a trangugiare tutte quelle medicine stomachevoli che mi prescrive?».
«Non mi ha capito. So che è vedovo. Mi spiace doverglielo dire, ma ha bisogno di relazioni sessuali, in altre parole deve trovarsi una donna…».
Polikarp Feofanovič aveva deglutito a secco e tolto il disturbo, immerso nei propri pensieri. Dalla morte della moglie non era più stato con nessuna donna e le erezioni, dopo l’attacco di prostatite, erano sempre più rare. Tre o quattro eiaculazioni notturne all’anno rappresentavano il massimo del piacere. A volte sentiva il desiderio di avere una donna accanto. Non certo per placare la sua prostata infiammata, quanto per evadere da quell’orrenda solitudine. Ma chi avrebbe mai voluto un vecchio rammollito? Al mercato rionale c’era una moldava di mezza età che vendeva ortaggi, una donnetta divorziata della periferia di Chişinău, e ogni volta splendeva di gioia alla vista di Polikarp Feofanovič. La moldava non gli poneva le solite domande sulla salute o sul tempo, ma era curiosa di conoscere i suoi successi e i suoi progetti. Quando parlavano, gli occhi della donna esprimevano calore e ammirazione, e il veterano-da-poco-pensionato aveva cominciato a ritrovare la sua sicurezza. La moldava gli aveva raccontato tutto del suo matrimonio fallito, convinta che solo un uomo con l’esperienza e l’autorità di Polikarp Feofanovič sarebbe stato in grado di separare il grano dalla zizzania, dispensando saggi consigli. Il veterano aveva ascoltato con attenzione, dandole ragione. Aveva biasimato la deplorevole maleducazione dell’allora marito e l’aveva rincuorata, dicendole che non c’era motivo di sentirsi infelice. L’affascinante moldava, commossa, se lo era mangiato con gli occhi. Era seguito, come da copione, il passo decisivo: uno scambio di visite. Ma Polikarp Feofanovič aveva dovuto anzitutto parlare con il figlio stabilitosi a Odessa. Una sera che era di buonumore lo aveva chiamato al telefono, comunicandogli l’intenzione di volersi risposare. Oleg Polikarpovič, un ingegnere molto occupato, aveva inveito contro il padre pregandolo di rinsavire: «Stai vaneggiando, papà! Quella puttana si mostra gentile solo per mettere le mani sul tuo appartamento! Forse hai dimenticato di avere un nipote?». Se ne era dimenticato, ovviamente. Figlio e nipote si facevano vivi solamente a Pasqua e a Natale. Non trovavano nemmeno il tempo per una telefonata. Polikarp Feofanovič era andato su tutte le furie. Non ci poteva credere. Lo avevano abbandonato, lasciandolo solo e senza aiuto, e ora sbavavano dietro a quell’appartamento! Il figlio e la nuora aspettavano la sua morte? E l’idea di perdere l’appartamento era forse più spaventosa della solitudine?
Dopo quella telefonata Polikarp Feofanovič era stato preso dallo sconforto. Usciva di casa sempre meno e gran parte del suo tempo la trascorreva a riflettere sul senso dell’esistenza. Troppo tardi aveva scoperto il fascino dell’introspezione. Fino a prima del pensionamento la sua vita era stata una corsa a perdifiato. Mai aveva trovato il tempo per riflettere. Ora non si sentiva più così sicuro di essere stato realmente felice. Che avesse fatto grandi cose era indubbio: aveva annientato la bestia nazista, prendendo parte all’assalto del Reichstag, aveva dissodato la steppa kazaka, lavorato presso il Comitato cittadino di partito e ottenuto un appartamento con tre camere nel quartiere Rîşcanovca. Ma la morte improvvisa della moglie, la prostatite, il pensionamento, la solitudine e soprattutto la decadenza morale della gioventù lo avevano fatto sprofondare nella disperazione…
Quando i vicini, guidati da Veniamin Nikanorovič, forzarono la porta, scocciati, il cadavere del veterano-da-poco-pensionato era in stato di avanzata decomposizione. A causa del fetore irrespirabile molti di loro vomitarono o se la diedero a gambe. Nella mano dell’amico, Veniamin Nikanorovič trovò una fotografia ingiallita: Polikarp Feofanovič, sua moglie e il piccolo Oleg erano abbracciati, nel centro di Chişinău, accanto al monumento di Lenin. Al funerale presero parte dieci persone: sei veterani di guerra, due vicini di casa, un annoiato istruttore politico del Comitato cittadino di partito e una donna col capo velato, di mezza età, che piangeva disperata. Risucchiato dal turbinio della vita, il figlio di Polikarp Feofanovič raggiunse Chişinău solo due giorni dopo. Prima di andare al cimitero, rovistò con attenzione nell’appartamento vuoto. In cucina, dimenticato sul davanzale, un pomodoro marcio emanava un miasma nauseante…
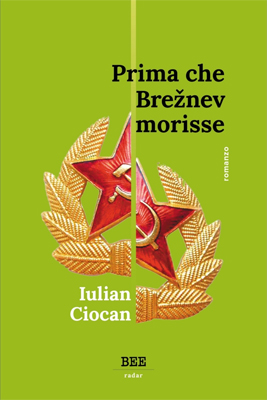
A cura e traduzione di Francesco Testa
(n. 2, febbraio 2023, anno XIII)
|
|

