









|
|
«Farse alle porte dell’Oriente», va in scena la Romania di Andrei Pleşu
 Comédii la porțile Orientului («Farse alle porte dell’Oriente», Humanitas 2005) è un libro carico di graffiante, sarcastica, quasi irriverente verve ironica su vizi (soprattutto) e virtù (qua e là) della Romania post-comunista: così si potrebbe riassumere questo volume che raccoglie articoli firmati da Andrei Pleșu (1948), scelti dal curatore, Radu Paraschivescu, apparsi tra il 1991 e il 2004 sulle riviste «Dilema», «Plai cu boi» e sul quotidiano «Jurnalul Național». Comédii la porțile Orientului («Farse alle porte dell’Oriente», Humanitas 2005) è un libro carico di graffiante, sarcastica, quasi irriverente verve ironica su vizi (soprattutto) e virtù (qua e là) della Romania post-comunista: così si potrebbe riassumere questo volume che raccoglie articoli firmati da Andrei Pleșu (1948), scelti dal curatore, Radu Paraschivescu, apparsi tra il 1991 e il 2004 sulle riviste «Dilema», «Plai cu boi» e sul quotidiano «Jurnalul Național».
Con il suo tipico stile e tono tagliente e diretto ma calibrato, senza peli sulla lingua ma mai oltre le righe, Andrei Pleșu ci conduce per mano nelle pieghe della società romena ʻorientaleʼ, tramortita e smarrita, orfana di Ceaușescu e libera dopo anni di un asfissiante regime comunista, colta nel(l’eterno, quasi) periodo di transizione che è seguito dopo la Rivoluzione: dalla variopinta fauna del mondo politico, allo stato penoso delle ferrovie; dalla tv nazionale soporifera e monocorde e dai nuovi intrattenitori di talk show, ai mutamenti di linguaggio e di comportamento dei romeni; dai personaggi riciclati dell’ex apparato di regime sotto camuffamenti più rispettabili ma non meno perniciosi, all’arte sopraffina di apoteotica e roboante ingegnosità profusa a iosa, anche da persone insospettabili, nelle dediche rivolte alla ditta Nicolae & Elena; dal racconto di viaggi all’estero carichi di sapidi episodi, alle implicazioni antropologiche dell’autoctona arte culinaria… e via via, in una gustosa galleria di allegri orrori o di oscene gag, dove il lettore alterna il sorriso sotto i baffi con l’aggrottamento delle sopracciglia.
I due articoli scelti, che formano un tutt’uno, toccano uno dei miti più radicati nell’immaginario dei romeni, cioè la loro tradizionale ospitalità, che va inquadrata a sua volta nell’ottica del loro rapporto con lo straniero. Nel frammento che presentiamo, abbiamo da un lato alcune monache con cui si scontrano «simpaticamente» Pleșu e i suoi amici americani, e dall’altro l’accademico romeno che critica l’articolo di Pleșu per il suo atteggiamento, a suo dire, pregiudizialmente animoso verso la Romania usato nell’articolo in cui narra dello «scontro di civiltà» tra le suddette astiose monache e gli allibiti cittadini americani. Potremmo dire che è qui esemplificato il comportamento ambivalente dei romeni che, pur fieri, e a ragione, della loro ospitalità, sono alternativamente restii e disponibili, espansivi e introversi, curiosi e sospettosi, affabili e scontrosi… nei confronti dello straniero. È quel comportamento che trae origine in qualche modo da un malcelato senso di inferiorità che lo storico Lucian Boia – espero di mitologie romene e non – coglie e sintetizza molto bene in questo passaggio tratto da La Romania, un Paese ai confini dell’Europa [1], nel quale ritroviamo in nuce le argomentazioni di Pleșu:
«I romeni sono convinti di possedere un atteggiamento positivo nei confronti degli stranieri. Nessuno è più benevolo, più amichevole, più accogliente di loro. Un fatto in gran parte vero. Tuttavia un simile atteggiamento non caratterizza esclusivamente i romeni, ma anche le comunità tradizionali in genere. (…) Il trattamento “di favore” che gli viene riservato significa però innanzitutto che lo straniero è trattato da straniero. Una comunità tradizionale è benevola nei confronti dell’altro, ma mantiene anche le distanze. Nell’immaginario romeno, lo straniero, con tutte le sue qualità e tutti i suoi difetti (specie i difetti!), è investito di un forte carattere di alterità. All’occorrenza, viene accusato di tutti i mali possibili occorsi ai romeni. Lo stato in cui si trova oggi la Romania, il suo ritardo storico, si dovrebbero in special modo agli stranieri; senza tante invasioni, senza turchi, né russi, né ungheresi e tutti gli altri, la Romania sarebbe stato un paese florido (sulle cose buone portate dagli stranieri si sorvola più in fretta, così come si sorvola in fretta sopra il fatto che sono stati i romeni stessi a farsi del male da soli, senza aver avuto bisogno necessariamente a tal proposito di “assistenza” straniera)».
Una banale e normale visita ai monasteri di alcuni stranieri in visita in Romania diventa, per ciò che un episodio come questo riesce a sviscerare, argomento di accesa disputa fra due mentalità, fra due visioni che la dice lunga sull’eredità storico-geografico-culturale della Romania, Paese latino con le stigmate dell’orientalità balcano-slavo-bizantina. Da un lato l’apertura, l’anelito a integrarsi, a sentirsi partecipi dei valori occidentali – da sempre, e con maggior impeto e speranza dopo la dittatura –, e dall’altro la preclusione, lo steccato, i paletti infitti nel terreno come limite, come marchio distintivo «noi vs. loro». D’altronde, è anche vero che l’occidentale che viaggia non solo in Romania, ma anche in altri paesi dell’Est europeo, trova o affascinante o straniante l’atmosfera che vi respira e quel vivere che sente lontano e vicino a sé allo stesso tempo. Ne è sedotto e respinto, forse, ma non può non cogliere che è un mondo specifico, con una sua personalità vigorosa, che deve saper cogliere e apprezzare nel giusto modo.
Nel suo libro, Andrei Pleșu ci offre il suo punto di vista come romeno che scruta e denuncia con ironia e intelligenza le pecche, le storture, le ingenuità del suo Paese. Un esercizio di pedagogica utilità che aiuta noi stranieri a capire la Romania e i romeni a capire se stessi.
[1] România, Țară de frontieră a Europei, Humanitas, Bucarest, 20124, pp. 211-212.
Frammento da «Farse alle porte dell’Oriente»
Descriptio Moldaviae
Dovevo accompagnare per un giro turistico in Romania una coppia di amici americani. Lui, professore di filologia classica a Berkeley; lei, musicista. Lui nato in Inghilterra, a Manchester; lei, in Olanda, da una famiglia traboccante di profumi esotici: un po’ di sangue indonesiano e portoghese, frammisto ad echi armeni, il tutto sullo sfondo comune dei Paesi Bassi. Siamo partiti salendo verso il nord della Moldavia, fino a Gura Humorului e Sucevița, e siamo tornati a Bucarest passando per il Lago Rosso, e scendendo poi lungo la Valle del Prahova. L’esito è stato quello su cui contavo: luoghi incantevoli, persone pittoresche, vini generosi. I miei amici avevano risposto al mio invito con passione, ma anche con qualche reticenza. Per delicatezza, avevano esitato a domandarmi se fosse stato opportuno portarsi da casa acqua potabile, farmaci contro il colera e giubbotti anti-proiettile. Come tutti gli stranieri, vedevano nel nostro Paese una sorta di ʻAltro mondoʼ («Siamo a due passi dall’Ucraina. In capo al mondo!» – dicevano senza smettere di stupirsi mentre osservavano la cartina geografica). Avevano sentito storie terribili di orfani, di handicappati e di vari altri accadimenti cruenti, che spaziavano da Dracula ai neonati malati di AIDS. Partiti con simili premesse, era inevitabile che rettificassero sensibilmente il loro punto di vista, giungendo anzi a usare toni entusiastici: «Suvvia, non è proprio così!» Anzi, lo possiamo dire alto e forte: è tutta un’altra cosa. Che colline! Che monasteri! Che manicaretti! Toh, ci sono anche le banche, la Coca-Cola, le Mercedes! Certo, il panorama in generale presenta ancora un aspetto alquanto spurio. Percorrere le strade romene lascia perplessi: si passa da sordide bettole a snack-bar sfolgoranti, da carretti che sprofondano nella notte dei tempi alle Daewoo, dalle BMW a branchi di oche confuse o di galline nevrasteniche. Ma se riesci a schivare le latrine «istituzionali» e rifugiarti dietro cespugli «decentralizzati» e a schivare i mendicanti con la tintarella che stanno appostati agli ingressi delle chiese, e che ti si lanciano sopra il parabrezza colti da mistica logorrea, allora tutto fila liscio. Ma ci riesci? Perché se anche ci riesci, non sarai risparmiato da altre sorprese, il cui fascino è, in modo irritante, arduo da sviscerare. Durante una tappa a un monastero, dopo aver pagato il biglietto d’ingresso, una monaca stizzita e baffuta ci ha chiesto di pagare una tassa anche per usare la macchina fotografica. «Non possiamo scattare nessuna foto; è finito il rullino», le replicano i miei amici. «Oh bella!», ribatte la monaca. «E chi vi crede? Lasciate qua da me l’apparecchio!» Gli amici ammutoliscono. Qualche sconosciuto in mala fede li aveva anche avvertiti che in Romania ogni tanto si ruba. Ma ecco che i romeni vedono le cose al contrario: sono loro quelli minacciati, sono loro le vittime potenziali dei turisti dilapidatori. «Va bene, madre – intervengo io imbarazzato – ma è così che lei si comporta da cristiana? Le pare bello non aver fiducia nel tuo prossimo che viene da lontano?» La madre non era certo incline a divagazioni teologiche. Era una via di mezzo tra un sergente autoritario e una commessa annoiata. Anche i miei amici assumono allora un atteggiamento più pragmatico. «Se vuole che le lasciamo in custodia l’apparecchio, ci lasci un biglietto, qualcosa che ci garantisca che lo potremo recuperare! Non si sa mai, per errore lo potrebbe restituire a qualcun altro». «Questa poi!», protesta la monaca, offesissima. «Mai sentita una cosa del genere!» La situazione è da tregenda, al limite del penoso. Afferro l’apparecchio e lo porto in macchina. Le due fazioni sono contrariate. Sbuca però la monaca-guida, giovane e carina, che chiede scusa per la sua «collega» addetta alla biglietteria. È fragile di nervi. Dovrebbe essere sostituita. Poi, in un buon tedesco, spiega ai miei ospiti il programma iconografico della parete occidentale della chiesa: il fiume dell’inferno e, da una parte e dall’altra delle sue sponde, i redenti e i dannati. Chi sono i dannati? I turchi. È ovvio. Erano il nemico quotidiano dei cristiani. E chi ancora? Gli ebrei. Che uccisero Cristo. E chi ancora? I negri. Perché? Nell’esercito turco c’erano anche mercenari negri. E chi ancora? Gli armeni. Gli armeni? Erano eretici, di fede copta. Rinuncio a tradurre tutto ciò in un inglese politically correct… Avevo appena finito di rassicurare i miei amici che da noi la xenofobia non ha preso. Ci siamo avviati quindi verso altri monasteri, più accoglienti… In uno di questi siamo stati accolti dalla madre economa che ci ha offerto «salatini», vino e caffè. Ma anche un po’ di conversazione. «Hanno, là da loro, in America, monasteri come i nostri? Quando è stato edificato il nostro monastero, loro ancora non c’erano!» Ho un attacco di vigliaccheria, non traduco. «Che ci hanno portato questi in cambio? Le sette religiose!» Non traduco. I miei amici scalpitano. Hanno come la sensazione di aver commesso qualcosa di sbagliato. Perché in quanto inglesi e olandesi non possono accampare, come gli americani, nessuna scusa. Cerco di rabbonire la madre economa. Invoco la nostra tradizionale ospitalità («finché siamo ancora in pace, io ti accolgo con un benvenuto!»), suggerisco che non va bene offrire agli ospiti del vino (e che vino!) dicendo loro al contempo quanto sono balordi e peccatori. Affermo che non è bello come cristiani ortodossi ostentare tanta vanagloria, considerarci l’ombelico del mondo e dileggiare gli ospiti. Ma la madre economa mantiene il tono fermo (e stridente) di chi si crede depositaria di tutte le verità. Tiene, insomma, nella stessa tasca le chiavi della dispensa e del Paradiso. È una cordiale e solerte moldava, un esempio di ʻaltruismoʼ autoctono, frammisto a un ilare disprezzo verso il resto dell’umanità. Perfino nei confronti degli altri pii monasteri della zona, con i quali si dichiara, tra il serio e il faceto, «in concorrenza».
Una storia come questa dovrebbe concludersi, secondo protocollo, con un «ritorno al senso dell’equilibrio». Dovrei dire che non tutte le nostre monache sono come quelle che ho ricordato, che fra loro ce ne sono anche di ammirevoli. Dovrei dire che i ricordi piacevoli del nostro viaggio predominano, nell’animo dei miei amici e del mio, su quelli spiacevoli. Non mentirei. Ma passerei sopra una realtà che rischia di minare la nostra reputazione. Non credo che si possa migliorare la qualità del grano se non ci si preoccupa mai della presenza della gramigna.
«Dilema», 28 giugno-4 luglio 1996
Diritto (mio) di replica
(Descriptio Moldaviae 2)
Su «Curierul Național» del 27 giugno, un membro corrispondente dell’Accademia Romena (il dott. Șt. Teodor Oroveanu) commenta l’articolo Descriptio Moldaviae pubblicato dal sottoscritto nel n. 181 di «Dilema» e conclude affermando che la mia politica – e di tutta la rivista – consiste nel calunniare il popolo romeno. Gli argomenti dell’esimio accademico sono, di per sé, frutto dell’ingenuità. Essi rispolverano, senza reticenze, i sofismi del più trito giornalismo di partito (comunista) degli anni ’50, con piccoli (e insignificanti) aggiustamenti di linguaggio. Lo schema polemico è semplice: nessuno nega che anche noi abbiamo i nostri difetti e le nostre difficoltà, ma neppure gli altri stanno meglio. I mendicanti e i bambini di strada di Bucarest? E che dire allora degli afro-americani senzatetto di Atlanta? E dei barboni che dormono all’addiaccio a Washington? «La povertà esiste ovunque». Il mondo, nell’ottica patriottica del signor Oroveanu, non è altro che un miscuglio indistinto di pregi e di difetti, ripartiti in modo democratico da Tecuci a New York, da Stoccolma a Lusaka. La terra è rotonda. Gli americani pensano che siamo l’ultima ruota del carro? Ma che si guardino loro! Siamo rimasti indietro? Forse! Ma neppure loro, con gli hamburger e le sette religiose, devono sentirsi in diritto di squadrarci dall’alto in basso. La nostra disoccupazione? C’è anche da loro! La nostra corruzione? Loro non ne hanno di meno! Non sono affatto «immacolati», «e qualche volta non è male ricordarglielo». Si potrebbe dire che per l’esimio accademico il turista americano ideale sarebbe quello che, percorrendo la Romania in estasi, si desse ai mititei, evocasse in modo tenebroso le tare del capitalismo d’oltreoceano e chiedesse continuamente scusa per Yalta… Al limite, si potrebbe pure farsi monaco in qualche eremo locale e implorare in ginocchio di ricordargli ogni giorno quanto sia ignobile. Ma l’esimio accademico dovrà comunque rassegnarsi. Un turista del genere non esiste né può esistere. Viviamo in un mondo ingiusto, nel quale ci sono nazioni più grandi e altre più piccole, alcuni popoli fanno la storia e altri gli vanno a ruota, alcune zone sono più fortunate, altre più iellate. Per questo gli americani si possono permettere di non sapere dove si trovi la Romania, mentre i romeni farebbero molto bene a sapere dove si trovano gli Stati Uniti. Perché, siamo noi a chiedere agli americani la «Clausola di nazione più favorita», non certo gli americani a noi. Ciò non significa che dobbiamo andare a piagnucolare alle porte delle grandi potenze o sprofondare nei complessi e nel risentimento. Ma tanto meno è il caso di insuperbirci come suonatori da strapazzo, ostentando blasoni da nobili decaduti, considerandoci il centro del mondo. Perché è proprio questa boria a renderci davvero provinciali e ridicoli. Oltre tutto essa ci svilisce. Se continuiamo a ripeterci all’infinito che «neppure gli altri stanno meglio», che le nostre pecche sono passabili e che finché avremo un Voroneț ci possiamo permettere qualsiasi rilassatezza e disgrazia, sopravvivremo in uno stato di torpore ravvivato solo da sprazzi folcloristici lontani dal mondo e dalla sorte. Questa sufficienza, questa tendenza a elencare i peccati degli altri per camuffare i nostri non è segno di amore per la patria, bensì stupido orgoglio e vanagloria. È ridicolo minacciare un editore anglosassone di non pubblicare in romeno Byron se non pubblicherà anche lui in inglese Coșbuc.
Per nostra fortuna il signor accademico Oroveanu non ha avuto la malasorte di nascere americano. È facile immaginarsi, in questo caso, come sarebbe il tono del suo discorso rivolto a un misero consesso come il nostro. «Da noi – avrebbe detto – ci sono sciocchezze di ogni genere su cui voi vi siete gettati per farle anche vostre: la Coca-Cola, McDonald’s, le sette religiose ecc. Ma guardate le nostre autostrade, i nostri musei di Boston, New York e Philadelphia (dove sono custoditi, fra gli altri, i capolavori di Brâncuși che voi avevate rifiutato), guardate le nostre università di Princeton, Yale, Harvard e Berkeley, la nostra industria, la nostra Costituzione, così ben scritta da rimanere immutata per duecento anni, pensate alla Biblioteca del Congresso, allo Smithsonian Institute, alla sfilza di studiosi e di uomini di cultura americani vincitori del Premio Nobel, all’architettura americana, e perfino, e me ne scuso, alle toilette americane, frequentabili a dispetto del melting pot che ne fa uso (vi è forse servito essere più etnicamente omogenei se non avete ancora scoperto l’igiene pubblica?). C’è poi anche il cinema americano, e la prosa americana, e il teatro americano (che ha offerto ad alcuni romeni come Liviu Ciulei e Andrei Șerban, sabotati nel loro proprio Paese, l’unica opportunità per emergere). Abbiamo ovviamente anche noi i nostri difetti, i nostri imbecilli (tema su cui ha scritto il vostro compatriota Andrei Pleșu su «Dilema»); è vero che non abbiamo un Voroneț, ma, ecco, veniamo ad ammirarlo e crediamo che ne avremmo maggior cura noi più di quanto ne avreste voi. A che pro accoglierci con discorsi altezzosi sulla nostra vacuità? Siamo, è vero, una nazione giovane. Esistono comunità africane più antiche del nostro paese (forse più antiche di voi…). Gli Stati Uniti sono più giovani addirittura della Turchia. Ma vi consigliamo di non scegliere i vostri modelli in base al semplice criterio dell’anzianità. Esistono anche anzianità sterili, stanche o desuete. Quanto alla Coca-Cola o a McDonald’s, nessuno vi obbliga ad accettarle con euforia, nessuno ve le ha imposte a proposito. Non dovete far altro che abbandonarle e creare i vostri marchi culinari. Non sarà certo l’America a impedirvelo».
Così si esprimerebbe più o meno un Oroveanu americano, forte del prestigio e dei risultati del suo Paese. E non riesco a vedere come gli potrebbe replicare il suo omonimo romeno, se non ricorrendo ai soliti e scontati piagnistei riguardo la nostra iattura storica: Yalta, Malta, i turchi, i russi e gli ebrei.
Per il resto, gli appunti che mi muove l’accademico autoctono sono formulati a sproposito. Egli crede che a infastidirmi sia stato l’esborso di denaro preteso all’ingresso di un monastero per l’uso dell’apparecchio fotografico. Vorrei che leggesse attentamente: a infastidirmi sono stati i modi villani della monaca-cassiera e i suoi sospetti pochi cristiani nei confronti di alcuni ospiti che non erano abituati a essere trattati come dei lestofanti. L’esimio accademico crede inoltre che io abbia dei preconcetti di ordine ideologico circa la nostra pittura religiosa. Sorvolo sul fatto che egli collochi l’episodio incriminato a Voroneț quando, in realtà, esso è accaduto al monastero di Agapia, il che cambia un pochettino i dati della questione. Ma ciò che a me è parso inammissibile non era il discorso a commento dell’affresco, bensì quello proferito dalla monaca-guida, che è un rimasuglio degli schemi di prima dell’89: nessuna traccia di rinnovamento, di flessibilità, di adattamento alla specificità del visitatore. Gli stessi sproloqui storici patriottardi, la stessa mancanza di tatto, lo stesso sentimentalismo pietista che erano in voga all’epoca, prima dei «gruppi organizzati». Non mi perito di commentare la bizzarra tesi dell’esimio accademico secondo la quale una monaca può essere scortese con un professore americano dal momento che alcuni giornalisti americani hanno detto e dicono cose sgradevoli sul conto della Romania. Il rimescolamento delle carte è totale, e la cattiva fede, palese. D’altronde, in conclusione, è lo stesso esimio professore a scoprire le carte. È con quelli di «Dilema» che egli ingaggia questa polemica, rei di «mettere in cattiva luce i romeni» con i soldi dello stato. L’esimio accademico è in compagnia di persone assai poco accademiche. Tale stupida e volgare insinuazione è stato infatti uno dei chiodi fissi del povero Vadim Tudor, oggi praticamente sparito dalla scena. A ogni modo, è triste constatare che, nella mente di un accademico, l’amore per il proprio Paese si riduca a parlarne bene. Una mentalità del genere offre solo il destro a tutti i baciapile e colpevolizza ogni tentativo di usare l’assennatezza. Non sappiamo in che settore è specializzato il signor Oroveanu. Ma egli ha letto Cantemir con la stessa negligenza con cui ha letto il mio testo. Se l’avesse letto con più attenzione, sarebbe stato sorpreso dalle pagine nelle quali il principe moldavo diceva peste dei moldavi. E non con i soldi dello stato, bensì sulla sua parola di voivoda. Anche Eminescu e Caragiale hanno detto peste di noi, come pure Cioran, e altri ancora, che, secondo il signor Oroveanu, sarebbero tutti quanti da consegnare alla polizia. Che ne sapevano questi illustri scrittori degli afro-americani e dei barboni senzatetto di Washington?
Un’ultima precisazione per rassicurare l’esimio accademico: i miei ospiti americani hanno lasciato la Romania con un’ottima impressione. La qual cosa temo non sarebbe accaduta se fossero incappati in qualche patriota della sua stessa risma.
«Dilema», 9-15 agosto 1996
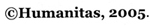
A cura e traduzione di Mauro Barindi
(n. 10, ottobre 2013, anno III)
|
|

