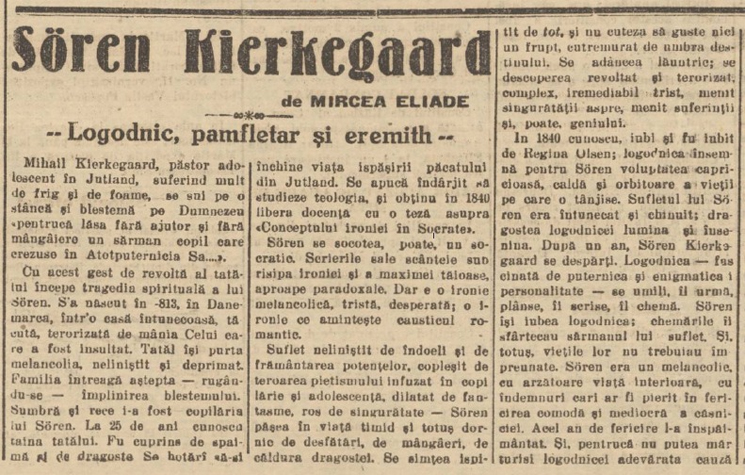|
|
Un inedito di Mircea Eliade: «Søren Kierkegaard. Fidanzato, pamphlettista ed eremita»
 Nel 1928, sulle colonne del quotidiano «Cuvântul», Mircea Eliade pubblicava un articolo su Kierkegaard – autore destinato a esercitare una costante attrazione sul saggista romeno, come testimoniano diversi suoi scritti – letterari, diaristici e scientifici – risalenti a vari periodi, tra cui alcuni articoli giovanili, il romanzo Gaudeamus, il Diario portoghese, il Mito dell’eterno ritorno e il Trattato di storia delle religioni. L’articolo Søren Kierkegaard. Fidanzato, pamphlettista ed eremita, inedito finora in italiano, viene qui presentato nella traduzione di Igor Tavilla. Nel 1928, sulle colonne del quotidiano «Cuvântul», Mircea Eliade pubblicava un articolo su Kierkegaard – autore destinato a esercitare una costante attrazione sul saggista romeno, come testimoniano diversi suoi scritti – letterari, diaristici e scientifici – risalenti a vari periodi, tra cui alcuni articoli giovanili, il romanzo Gaudeamus, il Diario portoghese, il Mito dell’eterno ritorno e il Trattato di storia delle religioni. L’articolo Søren Kierkegaard. Fidanzato, pamphlettista ed eremita, inedito finora in italiano, viene qui presentato nella traduzione di Igor Tavilla.
Mihail [Michael] Kierkegaard, pastore adolescente nello Jutland, soffrendo molto il freddo e la fame, si inerpicò su una roccia e maledisse Dio «perché lasciava senza aiuto e senza consolazione un povero ragazzo che aveva creduto nella Sua onnipotenza…».
Con questo gesto di rivolta del padre comincia la tragedia spirituale di Søren. Nacque nel 1813, in Danimarca, in una casa buia, silenziosa, terrorizzata dall’ira di Colui che era stato offeso. Il padre sopportava la sua malinconia, inquieto e depresso. La famiglia intera attendeva – in preghiera – il compiersi della maledizione. Tetra e fredda fu l’infanzia di Søren. A venticinque anni conobbe il segreto del padre. Fu preso dal terrore e dall’amore. Decise di offrire la propria vita in espiazione al peccato dello Jutland. Prese a studiare con fervore la teologia, e nel 1840 ottenne la libera docenza con una tesi sul «Concetto di ironia in Socrate».
Søren si considerava, forse, un socratico. I suoi scritti sfavillano sotto lo spreco di ironia e di una massima tagliente, quasi paradossale. È un’ironia però malinconica, triste, disperata; un’ironia che ricorda il caustico romantico.
Spirito agitato da dubbi e dal turbamento delle facoltà, sopraffatto dal terrore del pietismo instillato nella fanciullezza e nell’adolescenza, affollato di fantasmi, roso dalla solitudine – Søren incedeva nella vita timido e tuttavia desideroso di piaceri, consolazioni, del calore dell’amore. Si sentiva ispirato da tutto, e non osava assaggiare nemmeno un frutto, scosso dall’ombra del destino. Si approfondiva interiormente; si scopriva in rivolta e terrorizzato, complesso, irrimediabilmente triste, destinato a una dura solitudine, votato alla sofferenza e, magari, al genio.
Nel 1840 conobbe, amò e fu riamato da Regine Olsen; la fidanzata significa per Søren la voluttà capricciosa, calda e accecante della vita che aveva anelato. Lo spirito di Søren era tetro e tormentato; l’amore della fidanzata illuminava e rasserenava. Dopo un anno, Søren Kierkegaard si lasciò. La fidanzata – affascinata dalla di lui personalità potente ed enigmatica – si umiliò, lo seguì, pianse, gli scrisse, lo supplicò. Søren amava la sua fidanzata; le suppliche dilaniavano il suo povero spirito. E tuttavia, le loro vite non dovevano unirsi. Søren era un malinconico, dalla fervente vita interiore, con sollecitazioni che sarebbero venute meno nella felicità comoda e mediocre della vita domestica. Quell’anno di felicità lo terrorizzò. E, dal momento che non poteva confessare alla fidanzata la vera ragione – mentì. Mentì scrivendo il Diario del seduttore [1] e In vino veritas [2]. Mentì, lasciando credere ai lettori che lui aveva abbandonato la fidanzata perché era un esteta, un uomo che colleziona piaceri senza sosta, che crede nell’amore ma crede anche nella necessaria mutevolezza dell’amore.
Separatosi dalla fidanzata, appreso del matrimonio di lei con un oscuro borghese – Søren cercò di dimenticare il dolore nel lavoro. In pochi anni scrisse un numero travolgente di opere (Aut-Aut, 1843; Timore e tremore, 1843; La ripetizione, 1843; Briciole filosofiche, 1844; Il concetto d’angoscia, 1844; Prefazione [sic], 1844; Stadi sulla via della vita, 1845; Postilla conclusiva non scientifica, 1846, per citare soltanto le opere principali, pubblicate sotto pseudonimo, senza considerare i lavori religiosi, autografi), sotto forma di frammenti, memorie, discorsi, paradossi. Quella che si potrebbe definire la «filosofia» di Søren Kierkegaard, la concezione dell’estetico, dell’etico e del religioso come sensi del mondo e valorizzazioni della vita – sui quali torneremo –, era già compiutamente delineata in questi anni di crisi.
«Spesso un uomo è diventato un genio per una ragazza, spesso un eroe, spesso poeta, spesso santo per una ragazza. Ma per la ragazza che ebbe, l’uomo non divenne genio, bensì consigliere di Stato; non divenne eroe, bensì generale…». Scrivendo ciò (In vino veritas) Kierkegaard pensava alla realizzazione interiore, alla spinta alla creazione che gli diede l’amore infranto. Infatti, «una relazione negativa con una donna può rendere l’uomo infinito… Importa che essa appaia al momento opportuno in cui lo spirito apre gli occhi. È un momento breve, dopo il quale essa farà bene a sparire. Perché una relazione positiva rende l’uomo finito nella maggiore misura possibile». (Idem).
La fidanzata non avrebbe compreso questa verità, rivelata ai solitari. Per costringerla a dimenticare l’amore, Søren Kierkegaard fece l’apologia della voluttà estetica del seduttore. Ma il suo seduttore è un erudito fine, raffinato, enigmatico. Settimana dopo settimana domina lo spirito di Cordelia, una ragazza pura nella sua incoscienza femminile. Sono fidanzati. Ma il seduttore insinua in lei la libertà dell’amore. Cordelia rompe il fidanzamento. La città intera lo crede infelice, lui, che è padrone dello spirito e – se volesse – del corpo della ragazza. «Con le sue fini facoltà intellettuali, egli sapeva in modo meraviglioso indurre una ragazza in tentazione, legarla senza prenderla, senza volerla, in senso stretto, possedere». (Il diario del seduttore; poiché seguo traduzioni italiane e tedesche, non indico la pagina della citazione). Il seduttore vuole il corpo perfetto di Cordelia; una sola notte; dopodiché, non legge più le sue lettere, ma cerca una nuova avventura. «Una fanciulla è un essere debole; quando interamente si è data, tutto ha perduto» (Idem). Le fanciulle devono essere sedotte dagli spiriti mascolini; almeno, questo è il principio. Anche una seduzione completa, per l’esteta che non è Kierkegaard, è benvenuta: «Una eccellente ragazza sedotta può diventare una moglie eccellente» (In vino veritas).
Ma Søren non era un esteta, un seduttore. L’amore – infelice per suo volere – era stato il catalizzatore del genio latente. D’ora in poi conosce la sua strada: la solitudine. Søren non diventa anacoreta; vive, invece, in mezzo agli altri, solo. Il primo senso dato al mondo – l’estetico – spinge a un dinamismo plurale e riconfortante. Il senso etico, invece, si traduce così: staticismo duro, individualismo estremista e incomunicabile. L’anima vive da quel momento in una solitudine definitiva; tra sé e le altre anime non può esistere alcun passaggio. L’etico della spiritualità di Kierkegaard non è una semplice formula, non si scopre attraverso la speculazione – bensì attraverso una lunga e dolorosa esperienza.
Tra le due Weltanschauung non vi è nesso causale. L’etico non si ottiene, per evoluzione, dall’estetico, così come il religioso non è un superamento normale dell’etico. Questi tre sensi sono completamente isolati. Ciascuno spirito partecipa sperimentalmente ai valori di uno di quelli. Il passaggio da un senso all’altro si fa attraverso il salto, attraverso una trasfigurazione incompresa, dovuta alle esperienze o a Dio.
Dio interviene nel mondo, nella storia, nella vita individuale – come un paradosso. La religione è inconcepibile, irrazionale, assurda. Il cristianesimo è un paradosso; i veri cristiani sono folli nel rovesciamento dei valori. Eppure il cristianesimo esiste, è vivo e grande, opprime, deprime, annulla. Ma non il cristianesimo della Chiesa. Søren ha consacrato gli ultimi anni di vita a esporre la dottrina cristiana autentica, evangelica. Esigeva esperienza, e non dogma: «essere cristiano (cioè essere trasformato secondo l’immagine di Dio) è per gli uomini una sofferenza, una miseria ed un dolore ancora più grande di ogni altro dolore, è perfino un delitto al cospetto dei contemporanei. E così sarà sempre, fintantoché essere cristiano vuol dire essere il contemporaneo di Cristo» (Esercizio di cristianesimo, 1850).
Søren Kierkegaard non ha conosciuto la dolcezza e la tranquillità di Gesù che per un breve periodo (1847-1848), quando scrisse la serie di lavori coronati dalle Prediche cristiane. Da allora fino alla morte (11 novembre 1855) si tormentò terribilmente, terrorizzato dall’immensità del senso cristiano.
Era così elevato Gesù per i peccati di Søren… che gliene importa dei peccati degli altri, incapaci di odiare e di amare, mediocri e beneducati? «Gli impulsi dei loro animi sono troppo miseri per essere peccaminosi. Un verme potrebbe considerare peccati simili impulsi, ma non un uomo, creato a somiglianza di Dio».
I tormenti gli dilaniavano la coscienza anno dopo anno. Dopo il 1845, in seguito all’attacco di una rivista umoristica, Søren soffrì ancor di più. Non poteva trovare conforto nel cristianesimo e la solitudine lo schiacciava, e il suo povero spirito subì in modo sempre più bruciante la mancanza di amore. Nel 1854, tre anni dopo la morte del vescovo Mynster [sic – in realtà Jacob Peter Mynster morì il 30 gennaio del 1854 e l’eulogia funebre, tenuta da Hans Lassen Martensen, ebbe luogo la domenica successiva il decesso del vescovo primate di Danimarca dal pulpito di Slotskirke (n.d.t.)], il successore gli fece un elogio in cui lo paragonava agli Apostoli. Søren non poté più dominare la propria collera contro la Chiesa, che attribuiva il titolo di santo a un pover’uomo. Gli attacchi furono dirompenti. Tutta la Danimarca lesse «L’istante». Søren diceva: il cristianesimo non esiste più. La chiesa è una funzione stipendiata e i cristiani sono irrimediabilmente mediocri.
Gli attacchi portavano a risoluzione una crisi iniziata da tempo. Søren Kierkegaard, il cristiano che cercava Dio, l’asceta torturato dal volto di Cordelia, Søren il solitario e inasprito dalla sofferenza – mostrava che la maledizione dello Jutland non era stata espiata. Per lui, Dio era a tal punto inaccessibile, da domandarsi se il cristianesimo fosse mai esistito. Erano gli ultimi spasmi dell’agonia spirituale. All’inizio del novembre 1855, lanciò il numero de «L’istante» intitolato: Siate bazzecole – e vedrete, tutte le difficoltà scompariranno! Cadde per strada, e morì all’ospedale l’11 novembre. Attorno a lui, la lotta si abbatté nell’animo di Danimarca. E il tormento di un Dio terribile per la maestà e l’inclemenza dei suoi comandamenti scese nell’anima di Ibsen, anni dopo.
Così nacque la creatura gigantesca e gelida del pastore Brand.
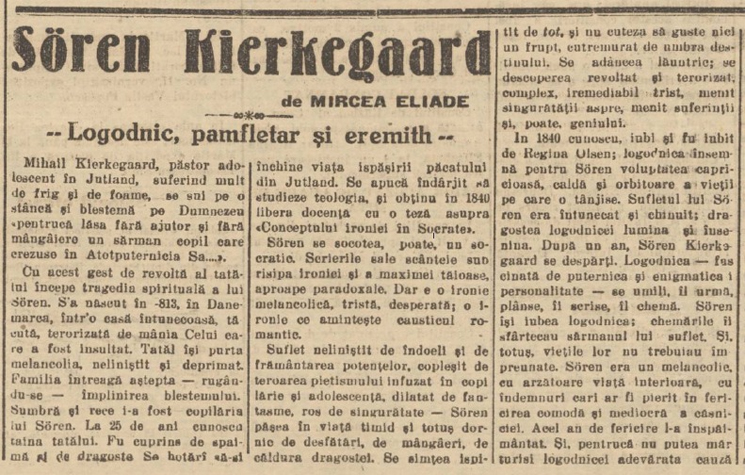
Mircea Eliade
Traduzione a cura di Igor Tavilla
(n. 9, settembre 2025, anno XV)
Avvertenza: la fonte utilizzata per la presente traduzione è l’articolo Mircea Eliade, Sören Kierkegaard. Logodnic, pamfletar și eremith («Cuvântul», IV, n. 103, 4 martie 1928, pp. 1-2), ora in Id., Virilitate și asceză. Scrieri de tinerețe, a cura di M. Handoca, Humanitas, București 2008, con il titolo Logodnic, pamfletar și eremit, pp. 68-72. Sono stati corretti alcuni refusi (per es. Munster anziché Mynster) presenti sia nel testo del 1928 sia nella raccolta curata da Handoca.
NOTE
[1] Per l’edizione italiana Eliade ebbe presente Il diario del seduttore, tr. it. di Luigi Redaelli, Fratelli Bocca, Torino 1910; più difficile stabilire quale testo abbia seguito in lingua tedesca, dato il cospicuo numero di edizioni disponibili sul mercato: Das Tagebuch des Verführers, übertr. M. Dauthendy, Leipzig 1903; Das Tagebuch des Verführers, übers. von R. Meinreis, Berlin 1921; Das Tagebuch des Verführers von S. Kierkegaard, (Deutscher Text und Nachwort von Horst Broichstetten), Berlin [1917]; Aus dem Tagebuch des Verführers, München 1927; Das Tagebuch eines Verführers, bearb. von Edmund Th. Kauer, Berlin [1928]; si devono inoltre tenere in considerazione le edizioni in lingua tedesca di Enten-Eller, che comprende anche Il diario del seduttore, disponibili al tempo in cui Eliade redigeva il suo articolo: Entweder-Oder. Ein Lebens-Fragment, hrsg. Von Victor Eremita, aus dem Dän. von O. Gleiss, Leipzig 1885 [2. Aufl. Dresden & Leipzig 1904]; nonché il primo volume delle Gesammelte Werke, 1-12, Jena 1909-1922 apparso a Jena nel 1911.
[2] Con ogni probabilità qui Eliade segue l’edizione In vino veritas, con l’aggiunta de Il più infelice e Diapsalmata, tr. e prefazione di Knud Ferlov, Carabba, Lanciano 1910, da cui abbiamo tratto i brani citati in questo articolo. A distanza di anni, nel suo Diario portoghese, Eliade scrive: «La prima volta che lo lessi [Kierkegaard] fu nel mio primo anno di facoltà; era Il diario del seduttore in traduzione italiana. Ne fui entusiasta e, siccome all’epoca, nel 1925, K. non era tradotto in francese, e io ancora avevo difficoltà a leggere il tedesco (specie Kierkegaard!), cercai e trovai le altre versioni italiane: L’erotismo musicale e In vino veritas (questa apparve nella collana «La cultura dell’anima», diretta da Papini, e vantava una straordinaria prefazione di Knut [sic] Ferlov, che in seguito tradusse K. in francese). Nel 1926, pubblicai su «Cuvântul» un articolo piuttosto importante, Sören Kierkegaard, fidanzato, pamphlettista ed eremita, che riscosse un certo successo e che fu, presumo, il primo articolo su Kierkegaard apparso in romeno». M. Eliade, Diario portoghese, a cura di R. Scagno, tr. Cristina Fantechi, con postfazione di Sorin Alexandrescu, Jaca Book 2009, p. 204. Florin Țurcanu ha contestato quest’ultima affermazione, attribuendo al filosofo e sociologo Mihail Ralea il primo articolo romeno su Kierkegaard: Sören Kierkegaard, «Viața românească», nn. 6-7, 1927, pp. 457-458 (F. Țurcanu, Erudiție și journalism. Publicistica lui Mircea Eliade în anii 1926-1928, in «Sud-Estul şi contextul European», n. 3, 1995, pp. 87-94, p. 93). L’articolo di Ralea in verità si concentra solo su Enten-Eller e si limita a suggerire un accostamento tra Kierkegaard e il pensatore svizzero Henri-Frédéric Amiel (1821-1881).
|
|