









|
|
Scrivere di Miguel Hernández. Il paesaggio. La famiglia. L’infanzia
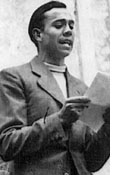 Sarebbe infruttuoso, se non impossibile, scrivere di Miguel Hernández senza dapprima accennare al paesaggio di Orihuela, la piccola cittadina, non distante da Alicante, dove nacque il 10 ottobre del 1910. Orihuela sorge ai piedi di monti aspri e brulli che la proteggono dai venti dell’ovest e si affaccia su una zona ricca di orti, vigne, aranceti e campi di canapa. Per i suoi vicoli, oltre al profumo di zagare, gelsomini, magnolie e acacie, si avvertono odori di vesti, di finissimi paramenti d'altare, di favo delle candele accese, odore di cera trasudata da vecchi ex voto. Lo scrittore alicantino Gabriel Miró così la descrive in un brano del 1908: Sarebbe infruttuoso, se non impossibile, scrivere di Miguel Hernández senza dapprima accennare al paesaggio di Orihuela, la piccola cittadina, non distante da Alicante, dove nacque il 10 ottobre del 1910. Orihuela sorge ai piedi di monti aspri e brulli che la proteggono dai venti dell’ovest e si affaccia su una zona ricca di orti, vigne, aranceti e campi di canapa. Per i suoi vicoli, oltre al profumo di zagare, gelsomini, magnolie e acacie, si avvertono odori di vesti, di finissimi paramenti d'altare, di favo delle candele accese, odore di cera trasudata da vecchi ex voto. Lo scrittore alicantino Gabriel Miró così la descrive in un brano del 1908:
«Il treno stava già attraversando la spianata degli orti di Orihuela. Scivolavano via gli steli della canapa, alti, stretti, oscuri; i folti aranci; i sentieri tra verdi ripe; le capanne di pietrame incalcinato e tetti di giunchi appoggiati su pali non piallati, che avevano ancora la bella ruvidezza degli alberi vivi; le stradette anguste, e lontano la carretta con il suo carico di verdure odorose; all’ombra di un olmo, due vacche con una corteccia di sterco, buttate a terra, che sgranocchiavano tenere canne di granturco; le montagne calve, che con la loro ossatura di roccia viva, arida, penetrano fino all'umido molle dei terrapieni, da cui subito si ritraggono con le gonne insanguinate dai peperoncini messi a seccare; un tratto di fiume con un vecchio mulino circondato di anatre; un folto di pioppi, di gelsi; una palma solitaria; una chiesetta con la sua croce votiva infilata nella cuspide; fumo azzurro di prode bruciate; un ampio stagno; due contadini chiusi nei loro calzoni di pelle, che maciullavano canapa con la gràmola; aranceti, alberi di paníco e, nello sfondo, sulla costa d’un monte, il Seminario, lungo, disteso, bianco, coronato di alti giunchi; mentre sotto, sul declivio, comincia la città, da cui spuntano campanili e cupole rosse, chiare, azzurre, violette, delle chiese, della cattedrale, dei monasteri; […]. Emanava dal paesaggio un odore pesante e caldo di sterco e di stabbio, un odore fresco di irrigazione, un odore acuto, fetido, che proveniva dalle vasche della canapa, e un odore aspro di canapa già secca e assestata in pagliai di forma conica».
Miguel era il terzo dei quattro figli rimasti in vita: due maschi e due femmine. Il padre era allevatore di pecore e capre e tirava avanti la famiglia con il commercio degli agnelli, del latte, delle pelli e della lana, alternando alti e bassi di quei modesti ricavi. Questo spiega perché Miguel ricevette una scarsa istruzione. Ebbe i suoi primi insegnamenti tra il 1915 e il 1916. Completò la sua formazione primaria tra il 1918 e il 1923. Nel 1924 si iscrisse al collegio di «Santo Domingo» di Orihuela tenuto dai padri gesuiti, ma molto presto dovette abbandonarlo a causa del volere del padre, uomo rude e taciturno, che non vide mai di buon occhio la vocazione letteraria di Miguel. Assieme al fratello Vicente, fu così mandato a pascolare le pecore e a distribuire il latte in paese. Pastore fin dall’infanzia, Miguel ebbe come prima scuola di vita la natura, gli animali e le piante. Soy un pastor […] un poquito poeta, scriverà in una lettera del '31 indirizzata a Juan Ramón Jiménez. E tale conoscenza del mondo naturale lo compenetrò a tal punto che sapeva riconoscere l’arrivo dell’autunno dall’umidità dell’aria e della terra o dalla linfa che si debilita nel ramoscello e nelle venature delle foglie. Oppure sapeva come i becchi si orinano nel pelo perché l’odore di orina risveglia gli appetiti erotici delle capre. Intanto, mentre accudisce il gregge, Miguel legge con avidità tutti i classici spagnoli – Gabriel Miró, Garcilaso de la Vega, Calderón de la Barca o Luis de Góngora, tra gli altri - e attorno ai sedici anni comincia a scrivere le sue prime poesie con una facilità che gli proveniva dal suo naturale dono d’osservazione minuta: Aperti, dolci sessi femminili, / o neri, o verdacchi; / minuti otri di vini violetti, / rinchiusi: genitali / e insieme ore funebri e uguali (Ode al fico). All’età di 20 anni, ricevette il Premio della Società Artistica dell’Orfeón llicitano per Canta a Valencia, una poesia di 138 versi sulla gente e il paesaggio della costa levantina.
Primo viaggio a Madrid
Sul finire del 1931 Miguel, raggranellati un po’ di soldi, parte per Madrid. È per lui una grande avventura, un atto di coraggio nel quale ripone le sue improbabili speranze, ma soprattutto l’evasione da un mondo provinciale che gli era ormai stretto. Ma l’ambiente letterario e intellettuale della capitale lo accolse con indifferenza, o meglio come una specie di poeta naïf, più pastore-poeta che poeta-pastore. E come poeta naïf lo presenta al pubblico nel gennaio del 1932 il direttore di «La Gaceta literaria», Ernesto Giménez Caballero. Trascorreva il tempo e Miguel a Madrid non trovava né gloria né lavoro, esaurendo oltretutto le sue scarse risorse economiche. Il ritorno a casa, dopo soli cinque mesi, era inevitabile. In questo lo aiutarono gli amici di Orihuela, fornendogli i mezzi economici per il biglietto ferroviario. Miguel prende il treno per il suo paese. Si sente sconfitto. In treno, per di più, gli capita un incidente spiacevole, che gli farà provare per la prima volta il sapore del carcere. Ad Alcázar de San Juan la Guardia Civil lo arresta per un giorno avendolo trovato con un documento d’identità non suo.
È in questo periodo che Miguel, impiegatosi frattanto presso un notaio di Orihuela, s’innamora, a ventiquattro anni, di una giovane ragazza di nome Josefina e che fa la sarta, incontrata più volte per strada, lungo il tragitto da casa all’ufficio. Lo colpì il suo pallore, nonché i suoi occhi e i suoi capelli nerissimi. Fa in modo di passare davanti al laboratorio, che stava al pianterreno. Finché un giorno decide di fermarla all’uscita del lavoro, chiedendole il suo nome perché voleva scriverle una poesia. Ma Josefina lo ignorava e non gli disse il suo nome. Pochi giorni dopo le consegnò una poesia che cominciava: Ser onda, oficio, niña, es de tu pelo, / nacida ya para el marero oficio; / ser graciosa y morena tu ejercicio / y tu virtud más ejemplar ser cielo. Fra i due nacque un tenero e tenace vincolo che non si sarebbe dovuto spezzare mai più (la sposerà il 9 marzo del 1937, nel mezzo della guerra civile). In questo periodo inizia la scrittura di Perito en lunas (Esperto della luna), il suo primo libro, che vede la luce il 20 gennaio del 1933.
Secondo viaggio a Madrid
Nel marzo del 1934, Miguel riparte nuovamente per Madrid, trovandovi questa volta un’occupazione abbastanza stabile all'enciclopedia taurina che uscirà in tre volumi presso la España-Calpe. Lui e Josefina potranno vedersi solo a brevi tratti, durante le fugaci visite del poeta a Orihuela. La loro storia d'amore proseguirà, quindi, per lo più, con un fitto rapporto epistolare. Le tue lettere sono un vino / che mi sconvolge e sono / l’unico alimento / per il mio cuore… E tra una lettera e l'altra, Miguel trova anche il modo di riconciliarsi con Madrid e i madrileni. Pubblica una raccolta delle sue opere. Il libro ebbe un tale successo che fu addirittura invitato a parlare all’Università di Cartagena. Nella capitale Miguel fa conoscenze importanti nell’ambiente intellettuale, i suoi versi cominciano a essere apprezzati e stringe amicizia con Vicente Aleixandre, García Lorca e Pablo Neruda, con il quale instaurerà un profondissimo legame. Con loro, Miguel, oltre alla creatività letteraria, lo univa il desiderio di combattere l’ingiustizia sociale. Egli, infatti, conosceva bene le difficoltà della vita dei poveri, quindi si avvicinò alle idee comuniste, che in seguito approvò, facendole proprie. Ma non ebbe fretta di unirsi al partito. Insieme ai suoi amici e collaboratori, già durante la guerra visitò Mosca, la capitale del primo stato socialista. Una sentimentale conoscenza con la pittrice Maruja Mallo, lo spinse a scrivere molti dei sonetti di El rayo que no cesa (Il fulmine che non si ferma mai) del 1936.
La guerra civile (1936 – 1939)
Allo scoppio della guerra civile Miguel si arruola come volontario nel 5° reggimento delle Milizie Popolari repubblichine. Ma non amò mai la guerra. Questa lo colpì negli affetti, nelle sue radici, nella terra che considerava il suo grembo, nel suo popolo sventurato quanto fiero e coraggioso. Gli portò via tragicamente molti dei suoi amici, altri ne disperse. Gli strappò umanità, gioventù, speranze, futuro. Nei tre anni di guerra, nonostante la fatica di scavare trincee, lavorò e produsse moltissimo: due raccolte di versi, quattro atti unici, articoli, abbozzi, interventi alla radio. La consapevole adesione ai principî rivoluzionari e socialisti non poteva mai essere separata dal suo impegno culturale. Viento del pueblo, raccolta di poesie, canti, odi ed elegie, fu scritto in trincea, tra un’operazione militare e una pausa dopo i combattimenti, talvolta con il sottofondo di fragore e fumo dei bombardamenti, di cui ogni verso è intriso. Un vento di passione e d’amore spinge il poeta a cantare le ansie, i dolori, le grida di rivolta, i lamenti, le lacrime della gente. Il contadino, prima e più del proletario, evidenzia con la sua costante presenza una storia universale di terra e di uomini. L'altra raccolta è El hombre acecha, composta tra il '37 e il '39, quando lo spettacolo quotidiano del dolore, i presagi per la sconfitta, l'incrudelirsi della guerra avevano scavato un profondo solco nel suo cuore. In mezzo, la morte prematura del primo figlio Manuel Ramón e la nascita di Manuel Miguel, che solo in parte compensò il trauma di quella perdita. Colpisce in quest’ultima raccolta la coscienza del dramma umano e famigliare del poeta, che lo vede proiettato in quello collettivo in forma sempre più tragica, disperante. Non c’è rinuncia o sfiducia per l’ideale politico, pentimento per le scelte fatte. Si avvertono, tuttavia, note più dolenti, un attenuarsi dell’ottimismo, dell'impeto guerresco che aveva contrassegnato la precedente raccolta.
Il carcere e la morte
Il 29 marzo del 1939, con l'entrata della truppe franchiste a Madrid, ha praticamente termine la guerra spagnola. In tutta la Spagna si estesero le terribili persecuzioni contro i “rossi”, in sostanza contro tutti i soldati repubblicani. Cessato il conflitto, Miguel provò di raggiungere il Portogallo, dopo aver tentato vari spostamenti interni alla Spagna, compreso Orihuela. Il 29 aprile, da Huelva, città vicina al confine portoghese, scrisse a Josefina di tenersi pronta a partire, egli l’avrebbe chiamata non appena fosse stato possibile ricongiungersi. Da solo riuscì ad attraversare il confine portoghese. Si accingeva a salire su un treno per Lisbona, quando la polizia portoghese l’arrestò e lo consegnò alle guardie civili della vicina Rosal de la Frontera. Pare che Miguel avesse commesso l’ingenuità di vendere a un portoghese la sua tuta turchina dei miliziani. La guardia civile spagnola lo trattenne otto giorni a Rosal bastonandolo di continuo. Comincia la prima parte della sua odissea carceraria: anzitutto a Siviglia, poi alla prigione di Torrijos di Madrid (dal 18 maggio).
Le carceri si trascinano l’umidità del mondo,
vanno per la tenebrosa strada dei tribunali:
cercano un uomo, cercano un popolo, lo perseguitano,
lo assorbono, lo ingoiano.
[…]
Scrive a Josefina raccontando la sua vita di prigioniero: Ho veduto la gente attorno a me disperarsi e ho imparato a non disperarmi io stesso, ma soprattutto, manifestando le sue preoccupazioni per il figlio, la moglie e i famigliari tutti. Improvvisamente, verso la metà di settembre, Miguel esce di prigione, in libertà provvisoria. Per quale misteriosa ragione viene scarcerato? C’è chi dice per un errore burocratico; c’è chi dice in seguito a un decreto governativo che ordinava di ratificare le condanne dei detenuti già processati e di rimettere in libertà quelli ancora non condannati; c’è, infine, chi asserisce che la scarcerazione sia da attribuirsi a un intervento del cardinale Baudrillart presso Franco, dietro pressione di Neruda. Di quest’ultima tesi esistono varie documentazioni epistolari. Appena uscito dal carcere, Miguel si reca all’ Ambasciata cilena per chiedere asilo politico per poi emigrare nel paese sudamericano. Ma, sorprendentemente, l’asilo politico col relativo visto gli fu negato, forse perché Miguel «aveva scritto poesie ingiuriose contro il generale Franco» (Neruda) o, quasi certamente, perché si trattava di un personaggio più noto e «compromesso» degli altri. Non dando ascolto al consiglio di amici e parenti, Miguel fa ritorno nella sua Orihuela: errore fatale, perché il 29 settembre del '39 viene nuovamente arrestato e rinchiuso nel Seminario di Orihuela, trasformato in prigione. Passerà giorni durissimi, soffrendo la fame. In preda alla disperazione, in una lettera indirizzata alla moglie, le chiede di non venire a visitarlo col figlio, perché nel parlatorio sarebbero stati come “due cani che si abbaiano uno contro l’altro, senza comprendersi”. Fu trasferito poi a Madrid, dove il 18 gennaio del '40, con un processo privo di garanzia giuridica, fu condannato a morte da un Consiglio di Guerra. Ma a luglio la pena di morte gli viene commutata a trent’anni di reclusione. Viene trasferito in più prigioni, fino ad approdare nel giugno del 1941 riformatorio de Adultos di Alicante. In dicembre si manifesta una grave affezione polmonare che si complica in tubercolosi. Le sue condizioni sono aggravate ulteriormente dalla denutrizione, dalla carenza di cure e dal fisico sempre più debilitato per gli stenti. Il 4 marzo del 1942, sposa la sua Josefina con rito religioso. Il 28 marzo di quello stesso anno, Miguel Hernández, a 32 anni, esala il suo ultimo respiro. Neruda ne provò un grande dolore, testimoniato da questi versi di una poesia dedicata all’amico poeta “assassinato”: Sappiano quelli che ti uccisero che pagheranno col sangue. / Sappiano quelli che ti torturarono che mi vedranno un giorno. / Sappiano i maledetti che oggi includono il tuo nome / nei loro libri, i Dámasi, i Gerardi, i figli / di cane, complici silenziosi del carnefice, / che non sarà cancellato il tuo martirio, e la tua morte / cadrà su tutta la loro luna di vigliacchi.
Riportiamo qui di seguito alcuni dei suoi versi più significativi.
I venti del popolo mi portano
[…]
Se muoio, ch’io muoia
con la fronte molto alta.
Morto e venti volte morto,
la bocca contro la gramigna,
terrò i denti stretti
e barba risoluta.
Cantando attendo la morte,
poiché ci sono usignoli che cantano
in bocca ai fucili
e in mezzo alle battaglie.
(da: Viento del pueblo)
Il fulmine che non si ferma mai
Non cesserà questo raggio che mi abita
Il cuore delle bestie esasperate
e di fucine e fabbri adirati
dove appassisce il metallo più freddo?
Questa stalattite ostinata non cesserà
per coltivare i loro capelli duri
come spade e rigidi falò
verso il mio cuore che geme e urla?
[…]
(da: El rayo que no cesa)
Mani
Due specie di mani si affrontano nella vita,
spuntano dal cuore, irrompono per le braccia,
balzano, e sbocciano sul giorno ferito
a colpi, a unghiate.
La mano è l'attrezzo dell’anima, il suo messaggio,
e il corpo ha in essa la sua stirpe guerriera.
Alzate, muovete le mani in un grande mareggio,
uomini della mia semenza.
[…]
(da: Viento del pueblo)
Braccianti
Braccianti che avete riscosso in piombo
Patimenti, fatiche e denari.
Corpi di sottomesse e nobili schiene:
braccianti.
Spagnoli che avete guadagnato la Spagna
Lavorandola tra piogge e canicole.
Capipastore della fame e dell'aratro:
spagnoli.
[…]
(da: Viento del pueblo)
Popolo
Ma cosa sono le armi: chi ha detto che possono?
Sono segno di codardìa: le armi migliori
sono quelle con proiettile d’osso.
Guàrdati le mani.
Le mitragliatrici, gli aeroplani, o popolo:
tutti gli armamenti sono niente se schierati
dinanzi all'ostinata fierezza che spira
nel tuo scheletro saldo.
[…]
(da: El hombre acecha)
Canzone ultima
Dipinta, non vuota:
dipinta è la mia casa
col colore delle grandi
passioni e sventure.
Ritornerà dal pianto
dove fu portata
con la sua deserta mensa,
con il suo letto disgraziato.
Fioriranno i baci
sopra i guanciali.
E intorno ai corpi
solleverà il lenzuolo
la sua campanula penetrante
notturna, profumata.
L'odio s'acqueta
dietro la finestra.
Si ammansirà l'artiglio.
Lasciatemi la speranza.
(da: El hombre acecha)
Giovanni Abbate
(n. 2, febbraio 2022, anno XII) |
|

