









|
|
«Le non parole» e l'arte poetica di Nichita Stănescu
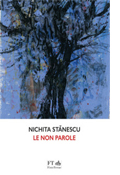 Per il «Focus libri romeni in italiano» dedicato alle uscite editoriali di letteratura romena che sfileranno con i loro protagonisti allo stand della Romania nell'ambito del XXXVII Salone Internazionale del Libro di Torino 2025 (15-19 maggio), presentiamo il volume Le non parole di Nichita Stănescu (1933-1983), nella traduzione curata da Dan O. Cepraga, edito da Finis Terrae-Ibis (Como-Pavia, 2024). Pubblichiamo qui alcune poesie e la postfazione per gentile concessione del traduttore e dell’editore, un invito a immergersi nel turbinio dei versi del mitico Nichita Per il «Focus libri romeni in italiano» dedicato alle uscite editoriali di letteratura romena che sfileranno con i loro protagonisti allo stand della Romania nell'ambito del XXXVII Salone Internazionale del Libro di Torino 2025 (15-19 maggio), presentiamo il volume Le non parole di Nichita Stănescu (1933-1983), nella traduzione curata da Dan O. Cepraga, edito da Finis Terrae-Ibis (Como-Pavia, 2024). Pubblichiamo qui alcune poesie e la postfazione per gentile concessione del traduttore e dell’editore, un invito a immergersi nel turbinio dei versi del mitico Nichita
Guarda le tue mani e rallegrati, poiché esse sono assurde
Quando, nel marzo del 1957, il giovane Nichita Stănescu, neppure ventiquattrenne, debutta con i suoi primi versi in alcune riviste dell’epoca, i carri armati dell’armata sovietica erano ancora sul territorio della Romania (si sarebbero ritirati soltanto l’anno successivo) ed erano ancora in pieno svolgimento le repressioni, gli arresti, i processi politici per mezzo dei quali il Partito comunista romeno aveva instaurato e consolidato il proprio potere nel corso del suo primo, terribile, decennio stalinista. In letteratura vigeva il dogma del realismo socialista, che imponeva i contenuti, lo stile, i temi, le parole d’ordine, mentre un sistema capillare di controllo e censura vigilava che ogni pubblicazione letteraria avesse, come si diceva all’epoca, il “visto della polizia” (viza poliției), che non si discostasse cioè dalla linea ideologica del regime. I tempi, tuttavia, stavano cambiando rapidamente e già a partire dai primissimi anni Sessanta, e con sempre più forza dopo il 1964, si sarebbe aperto un clima diverso nei rapporti tra gli apparati della politica e il mondo culturale e letterario. All’interno di complicati equilibri e stratagemmi, che avevano come protagonisti da una parte gli autori, dall’altra la censura politica assieme ad importanti figure di intermediari, come i direttori delle case editrici e delle riviste culturali, iniziano ad esserci spazi per rinegoziare i margini di una certa libertà di espressione, di ciò che si poteva e di ciò che non si poteva pubblicare. A volte bastavano poche dichiarazioni di fedeltà alla linea del Partito, qualche citazione dei temi preferiti della propaganda, tipicamente inserite all’inizio dei libri, per essere poi liberi di dare alle stampe contenuti artistici completamente immuni dalle imposizioni ideologiche.
Nel primo volume di poesie di Nichita Stănescu, uscito nel 1960 e intitolato Sensul iubirii (“Il senso dell’amore”), soltanto pochi testi pagano ancora un tributo, spesso superficiale ed obliquo, ai temi imposti dalla politica (il partito, le lotte contadine, la pace, Lenin), nella maggior parte delle poesie si respira invece un’aria di inedita e inebriante libertà creativa. La medesima libertà creativa che si respirava nelle opere di tutta una nuova generazione di poeti, come Ana Blandiana, Marin Sorescu, Ileana Mălăncioiu e altri, che in quegli anni si affacciava sulla scena e si prendeva nuovi spazi per la propria creazione, impensabili poco tempo addietro. Nichita è la figura centrale, più originale e carismatica, di questa generazione di poeti, che ha ridisegnato il volto della lirica romena del Dopoguerra, riannodando i legami spezzati con la grande tradizione del modernismo interbellico e imponendo la voce di una poesia nuova, libera e fieramente soggettiva, impermeabile alla retorica della propaganda. Nichita è anche l’autore che, fra tutti, ha saputo riaffermare, nella maniera più radicale e decisa, l’assoluta autonomia del discorso poetico, il suo diritto a restare fedele unicamente a sé stesso. Nella sua terza raccolta poetica, del 1965, Dreptul la timp (“Il diritto al tempo”), viene inserito un testo che stava nel cassetto fin dagli esordi, ma che solo ora evidentemente poteva essere pubblicato, l’intenso poema Enghidu, che si apre con un verso che ha fatto storia: Privește-ți mâinile și bucură-te, căci ele sunt absurde (“Guarda le tue mani e rallegrati, poiché esse sono assurde”): è, se vogliamo, la pietra tombale del realismo socialista, dal quale, proprio in quegli anni, la letteratura romena si distaccherà in modo netto ed irreversibile. Le mani, lo strumento principale del lavoro proletario e contadino, cantate nei poemi dedicati all’uomo nuovo plasmato dal Partito, diventano ora assurde, trasfigurate, dalla pura forza poetica, in una nuova dimensione cognitiva. L’anno seguente, il 1966, sarà la volta del volume 11 Elegii (“11 Elegie”), uno dei vertici della creazione stănesciana, che viene unanimemente considerato uno spartiacque della poesia romena del secondo Novecento. Al suo interno una straordinaria vena lirica e riflessiva spazia ormai libera da qualsiasi costrizione e contingenza, all’interno di un discorso poetico la cui oltranza e originalità non ha mai smesso di sorprendere i suoi lettori. È anche il libro che segna, potremmo dire, la consacrazione pubblica del suo autore e l’affermazione di uno dei più duraturi e fortunati miti letterari della cultura romena.
In Romania, infatti, per parlare di Nichita basta il solo nome di battesimo, a testimonianza di una notorietà e di una fortuna incontrastate, che assumono i contorni di un vero e proprio culto, insieme intellettuale e popolare, nato già in vita, durante il periodo comunista, e tuttora vivissimo, a più di quarant’anni dalla scomparsa del poeta. L’aura quasi eroica che circonda la figura di Nichita si comprende meglio se la si proietta sullo sfondo del particolare periodo storico in cui si è svolta l’intera parabola biografica e creativa del poeta, sulla difficile e complessa condizione degli scrittori sotto il regime comunista. Sono esistiti certamente gli scrittori di regime, che hanno goduto di vergognosi privilegi, ricambiandoli con la subordinazione alle direttive del Partito e con la bieca adulazione del Potere. Tuttavia, molti, se non la maggior parte degli scrittori romeni sotto il comunismo hanno semplicemente e strenuamente resistito, hanno opposto alla ideologia del regime la propria dignità di letterati, scendendo a compromessi minimi, indispensabili per la sopravvivenza, e soprattutto continuando a produrre, in molti casi, letteratura grande e vera. Tra le diverse modalità e gradazioni di resistenza e di sopravvivenza, la scelta di Nichita è insieme semplice e tragica, e consiste nel far coincidere il più possibile vita e poesia, anzi nel dissolvere completamente la vita nell’atto poetico. Come dirà in un suo memorabile verso, “il poeta come il soldato, non ha vita personale”. In questo senso, il soldato è forse una delle ipostasi più ricorrenti e rivelatrici dell’opera stănesciana, non solo immagine della fedeltà assoluta e dell’onore che il poeta rende alla Poesia, ma anche personaggio che meglio di ogni altro incarna lo stile di tutta l’opera: il suo spirito agonistico, la temerarietà, l’impetuosa spavalderia, il furor compositivo, persino le sue pulsioni autodistruttive. L’onore poetico, potremmo dire, inteso come la consapevolezza radicata della propria dignità di poeta e la volontà di mantenerla intatta, ha assicurato all’opera e alla figura pubblica di Nichita Stănescu un numero altissimo di ammiratori e di lettori, pur in presenza di una poesia tutt’altro che facile e compiacente, che anzi richiede una disposizione quasi iniziatica ad accettare un mondo poetico e immaginario del tutto autosufficiente.
Un esempio luminoso della libertà creativa, conquistata dal poeta soldato sul campo di battaglia, è anche il volume Necuvintele (“Le non-parole”), pubblicato nel 1969 e qui tradotto integralmente in italiano. Si tratta ancora una volta di un grande libro, eccessivo e corrusco, che chiude, con modalità ricapitolative, la mirabile, irripetibile stagione degli anni Sessanta. In esso, si ritrovano, in maniera quasi programmatica, tutte le dimensioni e le modalità retoriche della poesia stănesciana, dispiegate in tutta la loro sconcertante originalità e novità di dizione. Ci sono i testi di registro oracolare e sublime, scritti in uno stile assertivo e disadorno, di solennità biblica, che avevano trovato la loro formulazione più alta nelle 11 Elegie e che qui sono rappresentati dall’esordiale Peana, dedicato alla prima lettera dell’alfabeto, oppure dalla radicale anti-filosofia di testi come Che cos’è l’uomo? Quale è la sua origine? Che tipo di destino ha?. Ci sono i componimenti, così frequenti in tutta la sua produzione, di impianto drammatico e dialogico, che mettono in scena un grande Teatro della Mente, in cui, come nei contrasti medievali, disputano stranianti allegorie, come ad esempio, nella straordinaria Lotta di Giacobbe con l’angelo o dell’idea di “tu”. C’è, infine, l’epica enigmatica e concitata di un testo come La lotta con cinque elementi antiterrestri, non a caso di ambientazione militare, in cui Nichita realizza, come in molte altre occasioni, un’inquietante narrativizzazione del discorso lirico.
Nel volume, inoltre, trovano ampio spazio anche testi di registro apparentemente più leggero e cantabile, dove il tessuto delle rime e delle forme gioca un ruolo fondamentale e strutturante. Nella maggior parte dei casi, sono l’occasione per dare libero corso ad una inesauribile vena immaginifica, tra le più ricche e stupefacenti della poesia romena, in cui l’immanenza più viscerale e radicale va di pari passo con un’astrazione visionaria, che sembra voler rinegoziare ogni volta i confini e le possibilità del Reale. Tra le tante poesie che si potrebbero citare, si veda la mirabile Arte poetica oppure un testo come Canto per due, in cui compare quella che forse è la più celebre parola inventata della lingua romena, trimbulinzi (“Noi non vogliamo essere geniali, / noi vogliamo essere trimboletti…”). Aleggia in molti versi di Necuvintele una feroce e giocosa allegria, che attraverso il gioco verbale punta alla dissoluzione del senso e della significazione: si veda, ad esempio, la presenza insistente come attori sulla scena del testo delle lettere dell’alfabeto (la già citata Peana, la poesia intitolata propriamente Ö), le farciture in lingue inventate (“Halerib, Khaa / Halerib, Khii… / Heoro, loro, oro”), le scomposizioni ludiche delle parole (“mi tira per il braccio, per la spalla, per l’ombra / per l’arrivederci, per l’ar, per il ri,/ per il ve, per il der, per il ci…”), gli inserti stranianti dei ritornelli dei canti popolari, come il Lerui ler che si ripete alla fine di Miraj e che proviene dalle colinde, i canti rituali romeni del solstizio invernale. A tutto ciò si aggiunga la spiccata tendenza a forzare, a volte propriamente a reinventare i limiti della norma grammaticale, in una calcolata e arguta pratica del solecismo, dello scarto sintattico e morfologico.
Si tratta, in realtà, di sintomi collaterali di un fenomeno originario più profondo, che attraversa tutti i testi e che costituisce probabilmente il movente principale, nonché il centro di gravità del fare poetico stănesciano, vale a dire l’incessante lotta della poesia con la lingua, la tragica tensione scaturita dal tentativo di armonizzare i due poli della visione e del linguaggio all’interno di una sintesi nuova e unitaria, che attinga ad una dimensione cognitiva più alta. In questa prospettiva, Nichita Stănescu è il punto di arrivo di una lunga tradizione lirica che risale alle origini della lingua poetica romena moderna, formatasi nell’Ottocento sull’impulso di istanze fortemente sperimentali, con la vocazione alla omnieffabilità e il gusto per la novità, l’artificio, l’utopia onomaturgica. Si giocano su questo terreno anche i rapporti di Nichita con quello che è il suo più importante modello poetico, l’unico imprescindibile per un autore che del resto è così poco incline all’erudizione e alla filologia e in cui l’intertestualità gioca un ruolo tutto sommato di scarso rilievo. Ci riferiamo, ovviamente, ad Eminescu, il grande classico romeno di fine Ottocento e il punto di svolta dell’intera tradizione lirica nazionale. Non è un caso, infatti, che l’unica esplicita citazione intertestuale di Necuvintele sia un celebre verso di Eminescu: Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată, incipit della ineffabile Ode in metro antico, che chiude in modo suggestivo e apodittico la riflessione di Ce este omul?. Nel contesto culturale del secondo Novecento, Nichita è l’erede più coerente della poetica emineschiana proprio per aver portato avanti, mutandone gli intenti originari, la lotta della poesia con la lingua. Una lotta allo stesso tempo ludica e serissima, giubilante e dolorosa, che questa volta non desidera soltanto ampliare e perfezionare le possibilità della lingua poetica, portandola in zone inesplorate, bensì, in modo più radicale e in linea con le esperienze più avanzate della modernità europea, vuole ribaltare una volta per tutte il rapporto tra le Parole e le Cose.
Nonostante siano disponibili traduzioni della sua poesia nelle maggiori lingue di circolazione occidentale (due importanti volumi italiani, ad esempio, nonché una bella e recente antologia inglese pubblicata negli Stati Uniti), Nichita Stănescu è quasi del tutto sconosciuto fuori dai confini della Romania e, come molti altri autori dell’Europa dell’Est, che sono vissuti e hanno scritto sotto la cappa dei regimi totalitari, attende ancora di essere recuperato e integrato a pieno titolo nel canone della poesia europea novecentesca. La sua assenza dal nostro comune orizzonte intellettuale e spirituale appare ancora più grave se consideriamo l’altezza e l’originalità della sua esperienza poetica, che ha saputo, come poche altre nel Dopoguerra, riannodare i fili e riformulare le poste in gioco ultime del discorso lirico europeo. Se volessimo trovare un’etichetta sotto la quale collocare l’intera poesia stănesciana, dovremmo forse pensare al concetto di “metafisica concreta” coniato dal grande pensatore russo Pavel Florenskij, ucciso nell’osceno tritacarne staliniano nel 1937. Quella di Nichita è, in ultima istanza, una poesia sulla Conoscenza del Mondo e sul soggetto che intende conoscerlo conoscendo sé stesso, attraverso gli strumenti concreti e umani della poesia: un soggetto che guarda le proprie mani e si rallegra, poiché esse sono finalmente assurde.
Nichita Stănescu, Necuvintele
Arta poetică
Sunt așteptat de către o ventuză
m-așteaptă dintele cel alb rânjit
cel al leoaicei, stând lehuză,
cu foamea transformată-n mârâit.
Sunt așteptat de șarpele cel mare
care întins în sus se dă
cântării de hindus, și oarecare,
sunt așteptat de tu, de mă...
Sunt așteptat de un smarald, de perlă,
de boala scoicilor sunt așteptat,
de cântecul pițigăiat de mierlă
de răgetul de taur cornorat.
Sunt așteptat de îngerul cu carte,
sunt așteptat de cifra patru mii
și de întreg sunt așteptat, de parte,
de ieniceri și de spahii.
Sunt așteptat de ghilotină
de frânghia lucindă de săpun,
de întuneric așteptat și de lumină
de-alaltăieri, de ieri, de-acum…
Sunt așteptat cu masa-ntinsă
cu sângele întins, și câmpu-ntins,
cu plaga cea de boală linsă,
cu focul cel de apă stins
Sunt așteptat cu patru ochi în frunte
cu șase mâini la umărul cel drept,
cu peștera ecoului din munte
cu mintea celui înțelept.
Să mi se dea: ciupercă otrăvită
plaur, omag și lapte de cucută
Să mi se dea din puroi pepită
gură cu limbă smulsă, mută.
Să mi se dea la subțioară
cârjă din osul maică-mi,
să mi se dea, inteligibilă ocară,
vioară doar cu coarda “mi”.
Să mi se dea dreptul la jeg,
dreptul la porc, dreptul la câine,
să mi se dea cadavru-ntreg
al zilei cea de ieri numită mâine.
Să mi se dea mațul de zeu
umplut cu rău miros, duhoare
să mi se spună că sunt eu
tot ceea ce în lucruri doare…
Sunt așteptat, dar eu nu vin
mai stau, o, mai rămân o clipă,
miros și gust, verde venin
la tine doamne, sub aripă.
Era o muzică presată
Era o muzică presată
curgând pe jos, pe lângă glezne.
Era o indiferență vastă
de care-mi rezemam inima.
Era privirea trecând prin somn
ca printr-un inel de fier.
În ușă, portarul cu epoleți
ajuta elegant să se dezbrace
șarpele, de piele,
pietrele, de ele însele.
Vinul era destul de bun.
Moartea era agreabilă.
Prin aer plonjau
unul după altul, schiori celebri,
împroșcându-mă cu zăpadă.
Cântec în doi
Noi nu vrem să fim geniali,
noi vrem să fim trimbulinzi,
între nori, de sus în jos
lungiți, ori scurtați prin oglinzi.
Noi vrem să ne strângem în brațe
toată ziua, toată luna pătrată,
prin acel aer cu picioare verzi,
intimidându-l o dată.
Și încă o dată, și încă o dată,
noi nu vrem să fim geniali,
noi vrem să fim trimbulinzi –
triști, palizi și grei generali
mari, lungi, ascuțiți, decorați,
morți, duși, rătăciți, seculari
și pe deasupra de toate, uitați.
Noi nu vrem să fim geniali,
noi vrem să fim trimbulinzi,
legați cu o tremurată culoare
în față, la volan, de oglinzi,
mereu balansând spre-un adânc
și el mereu în mutare,
gonind pe șoseaua substantivelor
din declinare în declinare.
Noi nu vrem să fim geniali,
noi vrem să fim trimbulinzi,
asemenea generalilor mari,
schimbând lumina ce-o aprinzi
în alta, în altul, în cu totul altcineva,
asemenea generalilor mari
lungi, înalți, decorați, portocalii,
grei, goi, osoși, suferinzi,
noi nu vrem să fim geniali,
noi vrem să fim trimbulinzi.
Cântec
Trei pomi verzi erau, la rând
rude între ei, și neamuri
veri erau, frați în curând
ah, absurdul are ramuri.
Ramură, steag viu în vânt,
ramură – privighetoare,
ramură de dor de gând,
ramură spânzurătoare.
Trei pomi verzi în palma mea,
unul de piele, altul
de tăceri. De apă grea,
cellalt, înverzind înaltul.
Înălțime pentru nori,
pentru clătinat văzduhul
ca să ai unde să mori;
ciugulit de pliscuri, duhul,
– unde, în ce guri zburând? –
să se facă hrană fină
păsări de piatră, stând
pe columna ta, latină.
Jertfa și arderea de tot
Iau mielul și îi frâng șira spinării,
ochii-i scot cu degetul cel gros.
Îi rup copita și mirosul nării,
ficatul și rinichiul unsuros.
Și gelatina creierului smuls, în palmă
o țin atent ca să nu-mi curgă
cu viziunea ei de miel, prea calmă,
peste tunica mea cea demiurgă.
Îl ard ca să-ți miroasă dulce, Doamne,
e-o ardere de tot, pentru păcat,
și voi izbi și tauru-ntre coarne
și iedu-n jugulară, ca să fiu iertat.
Voi rupe în bucate orice animal
și îl voi arde, ca să-ți placă ție,
și toate astea fi-vor un semnal
că tu și eu suntem ca ei. Făclie
voi arde tot ce vrei, carnea pe os,
plămânul îl voi scoate la vedere
căci Doamne, tu, ești marele miros,
nară a timpului, nară de ere.
Dar, n-am să rup nicicând o floare,
n-am să strivesc nicicând un crin,
nicicând eu nu voi smulge sexul de splendoare
al trupului verdeții, și sublim.
Noi ce avem un trup de animale
și fără rădăcină ne mișcăm.
Noi, la suava florilor splendoare,
unii pe alții ne mâncăm.
Ca să fim gustoasă hrană
lumii înfipte în pământ,
a pomilor, și-a ierburilor vamă
pe care ele-o dau, când sunt.
Noi numai tălpi avem, iar ele
au rădăcini în mit,
noi numai stele-avem pe cer, doar stele,
când ele au adâncul lor de timp oprit.
Tragedii în timp de pace
Eram închis în propria mea capsulă.
Inima îmi funcționa bine și adeseori
mi-ar fi plăcut s-adorm înapoia ei
obișnuit cu bubuiturile neregulate
ale timpului interior.
Dar, fiecare secundă îmi era drămuită,
și n-aveam răgaz
nici atât
cât mi-ar fi trebuit să scriu o literă.
Dacă muream, eram bun mort,
chiar erou.
Tot ce făceam se balansa
în bătaia liniștită a stelelor.
Atârnam de un cârlig al destinului.
Zilele roșii îmi picurau din beregată…
Dar iată, ei au venit
și m-au scos din capsulă.
Mi-au invitat sufletul să petreacă
oriunde, numai în trupul meu, nu.
Și sufletul eliberat, deodată
a avut timp,
a scos pomul cu păsări la iveală,
s-a albit de lună.
Ar fi vrut să fie el însuși o sferă,
iar spre propriu-i trup privea scârbit
ca la urât mirositoarea arcă a lui Noe.
A-nceput să se lenevească, să aibă îngeri,
să se-ndoiască de existența destinului.
O, trist caracter!
Mai bine ai fi stat acolo-n mit
sub cheia întâmplărilor
și-ai fi rămas pentru tine, numai atât
cât să poți adormi și visa
nedeslușita lumină a nașterii tale.
|
L’arte poetica
Sono atteso da una qualche ventosa,
mi attende con i canini acuminati
la leonessa gravida e ringhiosa
con la fame che si trasforma in latrati.
C’è l’ehi, c’è il tu che mi attende,
c’è, tutto proteso, il grande serpente,
che si offre, allungandosi all’insù
al canto di un qualsiasi indù...
Sono atteso dallo smeraldo e dalla perla,
dal male dell’ostrica sono aspettato,
dal canto sottile della merla,
dal ruglio del toro incoronato.
Sono atteso dall’angelo col libro in mano,
sono atteso dal quattro e dallo zero,
dalla parte sono atteso e dall’intero,
dal giannizzero e dal miliziano.
Mi attendono la ghigliottina
e la lucida corda insaponata,
il buio della notte e la luce della mattina,
l’ora di adesso e quella appena passata.
Mi attendono con la tavola imbandita,
col sangue imbandito e il campo imbandito,
con la piaga dal male leccata,
col fuoco che dall’acqua è estinto.
Sono atteso con quattro occhi in fronte
con sei mani sulla spalla destra,
con l’eco della spelonca sopra il monte,
con la mente di chi ha sapienza.
Che mi sia data: l’amanita,
la cuora, l’aconito, il latte di cicuta,
del pus che mi sia data la pepita,
la lingua strappata dalla bocca, muta.
Che mi sia data sotto l’ascella,
dell’osso materno la stampella,
che mi sia dato, come ad un idiota,
un violino con una sola nota.
Che mi sia dato il diritto alla sozzura,
il diritto ai porci, il diritto ai cani,
che mi sia data la carogna intera
del giorno di ieri chiamato domani.
Che mi siano date le budella del dio,
farcite di miasmi e di fetore,
che mi si dica che sono proprio io
tutto ciò che nelle cose è dolore...
Sono atteso, ma io non vengo,
rimango, oh, un attimo ancora,
odoro e gusto il verde veleno che esala,
presso di te, signore, sotto la tua ala.
Era una musica compressa
Era una musica compressa
che scorreva per terra, intorno alle caviglie.
Era un’indifferenza vasta
su cui appoggiavo il mio cuore.
Era lo sguardo che attraversava il sonno
come un anello di ferro.
Sulla porta, l’usciere in uniforme,
aiutava con eleganza a svestirsi,
il serpente, della propria pelle,
le pietre, da loro stesse.
Il vino era discreto.
La morte piacevole.
Nell’aria si slanciavano
uno dietro l’altro, sciatori famosi,
schizzandomi di neve.
Canto per due
Noi non vogliamo essere geniali,
noi vogliamo essere trimboletti
tra le nuvole, dall’alto in basso
distesi, o scorciati negli specchi.
Noi vogliamo tenerci stretti
tutto il giorno, tutta la luna quadrata,
in quell’aria con i piedi verdi,
intimorendola una buona volta.
E ancora una volta, e ancora una volta,
noi non vogliamo essere geniali,
noi vogliamo essere trimboletti –
tristi, pallidi e pesanti generali,
grandi, lunghi, acuminati, decorati,
morti, andati, smarriti, secolari
e più di ogni altra cosa, dimenticati.
Noi non vogliamo essere geniali,
noi vogliamo essere trimboletti,
legati con un colore tremolato
davanti, al volante, agli specchi,
sempre sbilanciati verso un profondo,
anch’esso in continua trasformazione,
mentre corriamo sull’autostrada dei nomi
di declinazione in declinazione.
Noi non vogliamo essere geniali,
noi vogliamo essere trimboletti,
simili ai grandi generali,
cambiando la luce che accendi
in un’altra, in un altro, del tutto diverso,
simili ai grandi generali,
lunghi, slanciati, decorati, arancioni,
pesanti, nudi, ossuti, afflitti,
noi non vogliamo essere geniali,
noi vogliamo essere trimboletti.
Canzone
Tre alberi verdi tra loro parenti,
tra loro cugini, già quasi germani,
ben presto fratelli,
ah, l’assurdo ha i rami.
Ramo, nel vento viva bandiera,
ramo – usignolo,
ramo di desiderio di pensiero,
ramo per impiccarsi da solo.
Tre alberi verdi tra le mie dita,
uno di pelle, un altro
di silenzi. D’acqua pesante, infinita,
il terzo, che rinverdisce l’alto.
Per le nuvole altezza,
per scuotere la brezza,
un luogo avvenire,
dove poter morire;
lo spirito, dai becchi mangiato,
dove? in quali bocche è volato? –
per farsi cibo di grana fina,
uccello di pietra appollaiato
sulla tua colonna, latina.
Il sacrificio e l’olocausto
Prendo l’agnello e gli spezzo il collo,
gli cavo gli occhi con il dito grosso,
gli spezzo lo zoccolo e nelle nari l’olfatto,
il fegato e il rognone grasso.
La gelatina strappata del cervello
tengo sul palmo, attento che non unga
con la sua visione calma, da agnello,
la mia tunica demiurga.
Lo brucio, Signore, come un dono,
perché i dolci miasmi tu possa annusare,
è un olocausto, per il mio peccato,
e colpirò anche il toro fra le corna,
e il capretto alla giugulare,
per il tuo perdono.
Farò a pezzi qualsiasi animale,
bruciandolo, per farti un piacere,
e tutto questo sarà un segnale
che tu ed io siamo come loro. Braciere,
brucerò ciò che vuoi, la carne, il cuore,
il polmone che potrai vedere,
perché, Signore, tu sei il grande odore,
narice del tempo, narice delle ere.
Ma neanche una volta strapperò un fiore,
neanche una volta calpesterò un biancospino,
mai strapperò il sesso di splendore
del corpo vegetale, e divino.
Noi che abbiamo corpi da animale
anche senza radici ci muoviamo.
Noi, presso il soave splendore floreale,
gli uni con gli altri ci mangiamo.
Noi gustoso alimento
per il mondo piantato nel suolo
degli alberi, delle erbe dogana
che loro ci donano, quando ci sono.
Noi abbiamo solo i nostri piedi, ma quelle
hanno radici nel mito,
noi solo stelle abbiamo in cielo, solo stelle,
ma quelle hanno il loro abisso di tempo impietrito.
Tragedie in tempo di pace
Ero chiuso nella mia propria capsula.
Il mio cuore funzionava bene e sovente
mi sarebbe piaciuto addormentarmi alle sue spalle
abituato con i rimbombi irregolari
del tempo interiore.
Ma ogni mio secondo era contato,
e non avevo un attimo di pace,
neppure quel tanto
che mi sarebbe bastato a scrivere una sola lettera.
Se fossi morto, sarei morto per bene,
persino eroe.
Tutto ciò che facevo si bilanciava
nel tranquillo battito di luce delle stelle.
Stavo appeso ad un gancio del destino.
Le rosse giornate mi gocciolavano giù dalla carotide…
Ma ecco, loro sono arrivati
e mi hanno tirato fuori dalla capsula.
Hanno invitato la mia anima a spassarsela
ovunque volesse, ma non nel mio corpo.
E l’anima liberata, improvvisamente
ha avuto a disposizione del tempo,
ha tirato fuori l’albero con gli uccelli,
si è imbiancata di luna.
Avrebbe voluto essere lei stessa una sfera,
e guardava al proprio corpo con disgusto
come verso la maleodorante arca di Noè.
Ha iniziato a impigrirsi, ad avere angeli,
a dubitare dell’esistenza del destino.
Oh, quale triste carattere!
Saresti stato meglio laggiù nel mito
sotto la chiave degli accadimenti
e saresti rimasto per te, quel tanto che
fosse bastato per addormentarti e sognare
l’incerta luce della tua nascita. |
Presentazione e traduzione a cura di Dan Octavian Cepraga
(n. 5, maggio 2025, anno XV)
|
|

