









|
|
Vivo abbracciando il mondo intero
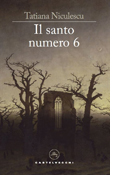 Sono passati quasi vent’anni da quando Tatiana Niculescu debuttava con Spovedanie la Tanacu (2006) [1], ma il passare del tempo non sembra avere rallentato questa scrittrice speciale nel panorama romeno contemporaneo. Al contrario. Quasi ogni anno ha aggiunto esplorazioni dei mondi noti e ignoti vicini a noi, con acribia, generosità, serietà e dedizione alla ricerca, alla comprensione o, al bisogno, all’immaginazione di connessioni e contesti che mettano in luce aspetti della storia in corso che sono stati ignorati, dimenticati, trascurati o occultati di proposito. Tatiana Niculescu trova la propria ispirazione prevalentemente nella (ir)realtà immediata, con le sue figure, i discorsi, i tornanti e i meandri inevitabili e riconoscibili. La creatività, la sensibilità, l’intuizione sono ciò che le permette di riempire i vuoti di conoscenza o interesse, di abbozzare monografie affascinanti per dettaglio e immediatezza, di far rivivere nella memoria delle comunità di lettori circostanze, epoche, avvenimenti che modellano non solo il passato, ma anche il presente e le modalità in cui esso è inteso da coloro che lo vivono. Sono passati quasi vent’anni da quando Tatiana Niculescu debuttava con Spovedanie la Tanacu (2006) [1], ma il passare del tempo non sembra avere rallentato questa scrittrice speciale nel panorama romeno contemporaneo. Al contrario. Quasi ogni anno ha aggiunto esplorazioni dei mondi noti e ignoti vicini a noi, con acribia, generosità, serietà e dedizione alla ricerca, alla comprensione o, al bisogno, all’immaginazione di connessioni e contesti che mettano in luce aspetti della storia in corso che sono stati ignorati, dimenticati, trascurati o occultati di proposito. Tatiana Niculescu trova la propria ispirazione prevalentemente nella (ir)realtà immediata, con le sue figure, i discorsi, i tornanti e i meandri inevitabili e riconoscibili. La creatività, la sensibilità, l’intuizione sono ciò che le permette di riempire i vuoti di conoscenza o interesse, di abbozzare monografie affascinanti per dettaglio e immediatezza, di far rivivere nella memoria delle comunità di lettori circostanze, epoche, avvenimenti che modellano non solo il passato, ma anche il presente e le modalità in cui esso è inteso da coloro che lo vivono.
Il recupero di epoche e personalità del passato avviene spesso nell’ambito di studi di divulgazione delle esistenze complicate cui si dedica, nei quali il sapere dello studioso e del giornalista di alto livello si accompagna alla volubilità e al desiderio di una comunicazione naturale e accattivante per diverse categorie di lettori. Questa volta, però, Tatiana Niculescu devia dal tracciato più volte battuto con successo. Il suo volume più recente, Sfântul nr. 6 [2], vira dal genere impegnativo e ibrido della biografia critica per approdare alla narrazione romanzata. L’autrice non ricama con cura e rigore a margine di avvenimenti noti, bensì lascia che sia una figura importante della nazione a guidare un esercizio di inventiva su un tema dato.
Rifiutandosi programmaticamente di menzionare il nome del modello utilizzato per il protagonista, così da collocare senza dubbio il suo scritto nell’ambito della finzione e non del documentario, l’autrice aggiunge tuttavia alla fine una nota che ne consente l’identificazione: «Questo romanzo è ispirato alle memorie del primo cardinale romeno (1885-1970), martire del regime comunista, beatificato da Papa Francesco nel 2019, assieme ad altri sei vescovi della Chiesa greco-cattolica, sciolta nel 1948 e restaurata nei suoi diritti nel dicembre 1989».
Chiudendo il cerchio delle speculazioni, l’ultima pagina offre anche la chiave del manoscritto: al centro della storia c’è Iuliu Hossu, la cui evoluzione può essere scoperta, in sostanza, nella presentazione offerta dalla diocesi greco-cattolica di Cluj-Gherla, la cui stessa traiettoria nel XX secolo si intreccia col suo destino. Il libro di Tatiana Niculescu non intende né glorificare l’individuo, né soddisfare quel tipo di slancio mistico che alimenta purtroppo alcune delle derive (ideo)logiche del momento. Al contrario, seguendo le orme di una figura luminosa dell’Unione del 1918, sottoposta al calvario, alle umiliazioni, alle sinistre beffe da parte del regime comunista di origine sovietica, la scrittrice offre ai lettori l’occasione di calarsi nei panni di un martire, di guardare il mondo con stupore, tenerezza e fede smisurate, di comprendere con la forza dell’esempio l’importanza dei valori e delle convinzioni autentiche, tanto più in tempi turbolenti, privi di fondamenti e di fari.
Tatiana Niculescu sottrae l’eroe emblematico (per determinazione, comportamento e quella che la terminologia attuale definirebbe, con un termine preso in prestito dalla psicologia, resilienza) alla sfera degli scritti ecclesiastici specializzati, con limitata circolazione presso generazioni poco familiari con le sottigliezze della storia e le sfumature della religione. L’autrice scrive un romanzo volto a fungere anche da atto di civismo. Servendosi del numero di letto assegnato al prigioniero nel carcere di Sighet, essa presenta il “santo n. 6”, metodico, composto, dotato di pazienza, senso contemplativo, umorismo bonario a una calma quasi paradossale di fronte alle ingiustizie, alle crudeltà, alle ipocrisie dei tempi che ha attraversato e a coloro che hanno deciso la sua via in essi.
Non solo il tono e l’atteggiamento sono adeguati: liberata dai rigori del biografismo classico, l’autrice dimostra ancora una volta di essere un’eccellente conoscitrice della malleabilità del linguaggio, della potenza conquistatrice e non raramente salvifica delle immagini evocate, della forza devastante o confortante della metafora e dello strumentario simbolico.
«Grosse sbarre di ferro tagliavano a scacchiera il firmamento»; da qui, «al confine con l’Orso, sulla riva sinistra del Tibisco», durante la passeggiata nel cortile angusto, sorvegliato dai soldati, il n. 6 inizia il suo viaggio nella coscienza (e nella coscienza attiva) del lettore. «Al di là del muro alto che li teneva nella stretta di un tempo impietrito, spuntavano delle corone di prugni. D’inverno, parevano reggere il cielo carico di neve affinché non crollasse sul mondo. Fiorivano ogni anno, e il suo passatempo segreto era quello di osservare come scrollassero da sopra il muro una parte dei fiori».
Sulla meditazione, la fantasticheria e l’armonia interiore con i ritmi della natura, incomparabilmente più onesti e prevedibili dell’uomo, si basa gran parte della resistenza del personaggio. La prosatrice si affida all’empatia, alla finezza, alla combinazione minimalista di emozione e moderazione. Il testo oltrepassa lo sguardo allenato di chi scartabella per archivi, desideroso di far rivivere in modo plausibile individui e situazioni. La penna di Tatiana Niculescu padroneggia con disinvoltura la forma che incornicia lo sfondo e lo mette in risalto, affiancando le allusioni esplicite o i riferimenti al contesto storico con la delicatezza ineffabile di uno spirito nobile, elegante, superiore di fronte alle provocazioni e alle bassezze quotidiane.
Gli interrogativi retorici alimentano il meccanismo profondo del testo. Rimasto a lungo solo con se stesso, il n. 6 è fedele e saggio interlocutore di se stesso. Mantiene sé e gli altri in vita attraverso la curiosità, l’interrogazione perpetua, l’insistenza di trovare risposte e soluzioni in condizioni apparentemente senza via d’uscita (da quelle di natura pratica, di sopravvivenza fisica, spesso difficili da sopportare o confessare, sino a quelle complesse e tormentose, che implicano e sconvolgono lo spirito). La fame, l’involuzione, le torture (di tipo rudimentale o concepite dal sadismo allo stato puro) sono rivisitate con il distacco filosofico di chi si rifiuta di abbruttirsi, di animalizzarsi, di tradire il proprio credo. Attraverso il filtro immaginario della mente indagatrice, la scrittrice formula i propri commenti, guidando la lettura in profondità: «In quegli anni, tutto era divenuto politico: aut-aut! Loro si trovavano là per la fede, ma anche la fede era considerata una sorta di politica, ancor più pericolosa, perché imbrigliava le menti delle persone e produceva coraggio da folli. La loro situazione era aggravata dalle relazioni con l’estero. Si imponeva un regime di sterminio lento, ma senza requie».
La resistenza alla pressione, attraverso la riflessione e l’immersione in una memoria che si rifiuta di anchilosarsi e cedere, sono i metodi praticati dal protagonista del racconto: «Ma il tempo si era interrotto e il corso del fiume era stato arrestato da una diga»: ecco come la scrittrice contrassegna i momenti di svolta che scandiscono un percorso individuale (e collettivo) che un tempo si annunciava brillante. Racconta del disprezzo della differenza, della demonizzazione dell’altro/ dello straniero/ dello sconosciuto, di intolleranza, violenza, persecuzione, di sospetto e sfiducia portati fino alla paranoia, di oscurantismo e di una grossolana mancanza di cultura, ma, a tratti, anche dell’aura indelebile di momenti come la Grande Unione e della meschinità perdente di molti che ne seguirono la storia che si dipana attraverso il protagonista. Nel discorso indiretto, vengono resi i numerosi interrogativi che illustrano la cecità, l’autosufficienza e la meschinità dei successivi regimi in cui l’interesse personale veniva anteposto agli altri, nonché la stupefacente transizione dalla condizione di eroe a quella di nemico del popolo.
La perseveranza nella civiltà, nella cortesia, nella discrezione, nella moderazione e nel buon senso sono al centro del confronto del chierico con l’assurdità, che egli percepisce come l’ennesima prova mondana. Tra parentesi, precisazioni, messe in scena o frasi, il lettore sentirà il respiro dello scrittore dietro il profilo cartaceo, che anima al di là delle informazioni schematiche e che proietta in una contemporaneità facilmente comprensibile, anche senza penetrarne gli sfondi multistratificati: «Il Numero 6 avrebbe potuto aggiungere che si trovava lì perché gli si offriva il privilegio di mettere in pratica la sua fede e di vivere tutto quello che aveva predicato. Ancora un passo e avrebbe ringraziato il compagno che faceva le domande perché la Securitate lo conduceva più vicino a Dio. Il securista brizzolato non avrebbe capito». Il protagonista di Tatiana Niculescu colpisce per una ribellione particolare: di pacifismo reale, non dichiarativo, di costanza e contrasto alle istigazioni, alle manipolazioni, alle aggressioni con la chiarezza e l’umiltà.
Il greco-cattolicesimo e il rifiuto di rinunciarvi, l’educazione equilibrata e aperta, lo studio approfondito in patria e all’estero, la conoscenza di diverse lingue straniere, ma l’incrollabile desiderio di non abbandonare la propria fede e i credenti per amore di glorie lontane, delineano la figura di un leader cosmopolita avant-la-lettre, non inghiottito dalle onde oscure dell’ottusità ideologica. La modestia, l’insicurezza di fronte al giudizio altrui determinano l’inclinazione ai dettagli di cui Niculescu lo investe generosamente: «Solo adesso cominciava a notare cose che, in precedenza, non solo aveva trascurato, ma nemmeno aveva formulato mentalmente. Quando aveva dimenticato di meravigliarsi dinanzi alla Vita?». Il santo n. 6 è un luogo d’incontro tra vita e morte, illuminazione e penombra, speranza, delusione e accettazione, una finzione storica pensata per catturare l’interesse e la simpatia del pubblico, ma anche per risvegliarne le ansie e gli strati sopiti della coscienza.
Attraverso la graduale evoluzione del personaggio che scopre se stesso e incontra l’abisso su cui si erge, Tatiana Niculescu costruisce anche un persuasivo monologo interiore di chi sovrappone gli insegnamenti di un’esistenza drammatica (scomunica, arresto, prigionia, residenza forzata) all’educazione formale.
Quel che impara, il Numero 6 lo condivide: «ogni disgrazia, grande o piccola, alla quale si è sopravvissuti, ogni disastro imprevisto, ogni tristezza, afflizione e tormento, una volta diramati dalla mente in tutte le cellule del corpo e dall’esterno all’interno, nascondono un seme di stupore e di esaltazione mediante il quale ci si può sollevare anche dalla disperazione più profonda». Non si deve intendere che l’autrice pratichi un didatticismo o un conciliatorismo volto ad addolcire l’oscurità di un passato riprovevole. Il volume non fa concessioni, non (si) nasconde, non addolcisce per amor di prosa le pillole avvelenate delle realtà che hanno sfigurato il volto del mondo. Non predica, non converte.
Meticolosamente documentato, con suspense da thriller, accenti da indagine psicologica ed esplorazione (post)moderna, si impegna a trasporre in finzione di buona qualità, con talento, facilità e una bellezza interiore di scrittura difficile da ignorare, un caso di studio sulla verticalità e la fermezza. Senza staccarsi completamente dal biografismo colto, raffinato che l’autrice ha imposto e consacrato negli ultimi anni, l’esperimento riesce, regalando al lettore un incontro ispirato (e ispirante) con la letteratura come arte della parola.
Cristina Chevereșan
Traduzione a cura di Igor Tavilla
(n. 11, novembre 2025, anno XV)
* La recensione qui riprodotta è apparsa sulla rivista romena «Orizontul», n. 4 (aprile), 2025, anno XXXVII, p. 10. Le note bibliografiche sono del traduttore.
NOTE
[1] Tatiana Niculescu Bran, Confessione a Tanacu, trad. it. di Anita Natascia Bernacchia, Hacca, Matelica 2013.
[2] Tatiana Niculescu, Sfântul nr. 6, Humanitas, București 2024. Edizione italiana: Il santo n. 6, trad. it. di Horia Corneliu Cicortaș e Igor Tavilla, Castelvecchi, Roma 2025; presso Castelvecchi della stessa autrice, a cura degli stessi traduttori, è uscita nel 2021 la biografia Nae Ionescu. Il seduttore di una generazione.
| |

