









|
|
Pier Paolo Pasolini, nella contraddizione tra passione e ideologia
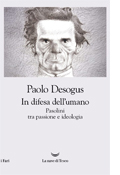 Su Pier Paolo Pasolini esiste ormai una bibliografia sterminata, per cui il lettore comune fa difficoltà ad orientarsi. Ma il libro di Paolo Desogus (Maȋtre de conférences alla Sorbona di Parigi) In difesa dell’umano. Pier Paolo Pasolini tra passione e ideologia (La Nave di Teseo, Milano 2025, pp. 494) getta una nuova luce sul poeta, regista e intellettuale bolognese. Come scrive l’autore nella presentazione, «La premessa che ha guidato questo studio è che tra attività artistica e vita sociale vi è sempre un nesso che l’indagine critica deve sforzarsi di spiegare […]. Nella sua opera anche la più banale effrazione metrica, anche il più semplice innesto dialettale o la più elementare inquadratura svolge una funzione politica». Su Pier Paolo Pasolini esiste ormai una bibliografia sterminata, per cui il lettore comune fa difficoltà ad orientarsi. Ma il libro di Paolo Desogus (Maȋtre de conférences alla Sorbona di Parigi) In difesa dell’umano. Pier Paolo Pasolini tra passione e ideologia (La Nave di Teseo, Milano 2025, pp. 494) getta una nuova luce sul poeta, regista e intellettuale bolognese. Come scrive l’autore nella presentazione, «La premessa che ha guidato questo studio è che tra attività artistica e vita sociale vi è sempre un nesso che l’indagine critica deve sforzarsi di spiegare […]. Nella sua opera anche la più banale effrazione metrica, anche il più semplice innesto dialettale o la più elementare inquadratura svolge una funzione politica».
Partendo da queste premesse di carattere critico e teorico-politico Desogus ricostruisce e analizza le tappe più importanti dell’iter umano e artistico di Pasolini e fissa nella contraddizione «tra passione e ideologia» («con te e contro te») il fulcro della sua poetica. Il libro è il risultato di una ricerca che dura da molti anni e che aggiunge tanti nuovi tasselli: innanzitutto le pagine dedicate a Pasolini studente della Facoltà di Filosofia di Bologna, a cui si è iscritto nel 1945 (percorso di studi mai portato a termine), dopo la laurea in Lettere, in cui si sottolinea l’influenza che ha avuto l’esistenzialismo sulla sua formazione. Successivamente analizza approfonditamente il rapporto di Pasolini con il pensiero di Antonio Gramsci, avviato sin dal primo dopoguerra, con l’antropologo Ernesto De Martino, con l’opera di Dante, di Leopardi e dei Classici, e la sua amicizia e il suo contrasto politico con Franco Fortini. In definitiva, in questo saggio Paolo Desogus con un discorso teorico e critico serrato e lucidissimo fa giustizia di molti luoghi comuni e ci consegna la figura controversa e tormentata di uno dei maggiori e più complessi poeti politici e cineasti italiani, di un intellettuale eterodosso, anticonformista ed eretico, fuori dagli schemi e unico. Egli da marxista gramsciano è rimasto legato per tutta la vita, anche se in maniera contraddittoria, al Partito Comunista, ma non è stato un «intellettuale organico» in quanto con le sue prese di posizione e le sue scelte esistenziali, artistiche e politiche ha spesso suscitato scandali, polemiche e denunce persecutorie. Dalla metà degli anni Cinquanta egli si è affermato come uno dei principali protagonisti del dibattito letterario e politico italiano e della cultura di sinistra. Con la pubblicazione dei suoi due capolavori letterari Ragazzi di vita (1955) e Le ceneri di Gramsci (1957) ha provocato le dure polemiche degli intellettuali del PCI, Carlo Salinari e Mario Alicata in testa, che Desogus discute polemicamente, così come critica la posizione di Alberto Asor Rosa che nel suo libro molto fortunato Scrittori e popolo (1965) effettua un’interpretazione riduttiva dell’opera di Pasolini etichettandolo come scrittore populista.
Più di recente Pier Vincenzo Mengaldo ha scritto che Pasolini è un autore senza filosofia e Walter Siti che Pasolini non può essere considerato un romanziere: Desogus smonta, con adeguate argomentazioni, anche queste due tesi. Amico fraterno di Alberto Moravia e di Elsa Morante, Pasolini negli anni Sessanta con l’inizio della sua carriera di regista diventa sempre di più un «personaggio pubblico» collocandosi al centro della vita culturale romana, nazionale e internazionale. E proprio all’inizio del nuovo decennio egli produce alcuni capolavori cinematografici (Accattone, Mamma Roma, La ricotta, il documentario Comizi d’amore e Uccellacci e uccellini) avviando contemporaneamente la rubrica di interventi giornalistici sul settimanale «Vie Nuove», in un dialogo serrato con i militanti comunisti e le giovani generazioni sui problemi più scottanti che allora l’Italia stava vivendo.
È di quel periodo anche il contrasto con il gruppo dei «Quaderni piacentini» e con la Nuova sinistra e nel ’68 pubblica la poesia-pamplhet Il Pci ai giovani!!, schierandosi dalla parte dei poliziotti e polemizzando con la contestazione studentesca, suscitando le riserve dello stesso Moravia e l’ira di Fortini e attirandosi l’odio dei leader del movimento studentesco. Nell’ultima fase della sua vita (ed è quella che i giovani sentono più viva e più vicina e che ancora oggi fa tanto discutere) resta proverbiale il suo grido di rivolta sul processo di omologazione del neocapitalismo e dell’industria culturale e sul suo volto autoritario, sulla «rivoluzione antropologica» degli Italiani e la fine del mondo contadino e popolare, sul neofascismo e la sua lotta contro il «Palazzo» del Potere, fissati negli Scritti corsari, nelle Lettere luterane, nel film Salò e nel romanzo postumo Petrolio, dove si avverte l’eco dei pensatori della Scuola di Francoforte. In sostanza, egli ha saputo captare e interpretare come pochi e con grande lucidità i tabù, l’arretratezza e i cambiamenti della società del suo tempo e con la sua multiforme attività ha agito per la sua radicale trasformazione scegliendo come protagonisti delle sue opere le classi subalterne e i dimenticati e partecipando alle grandi battaglie civili e politiche in difesa dell’umano. Così è stato tipico della sua posizione quello di vivere e operare dentro il suo tempo e contro il suo tempo, e quindi di vivere fino in fondo i suoi conflitti e le sue contraddizioni, e per tutta la vita ha lottato contro la solitudine e ha amato in maniera viscerale i giovani.
A volte si sente dire: chi sa cosa avrebbe pensato e scritto Pasolini su questa questione? Mi sembra una domanda fuori luogo, in quanto io non credo nell’attualità della figura di intellettuale da lui incarnata. Egli ha operato in una stagione particolare (dal fascismo agli anni Settanta) della storia del nostro paese e del mondo, di grande partecipazione politica e civile e di profondi cambiamenti, ma ormai superata, in un tempo in cui il marxismo e la sinistra, nelle loro varie forme e articolazioni, hanno svolto un ruolo fondamentale dal punto di vista politico e culturale, come patrimonio di grandi masse di cittadini e di militanti.
Da allora è cambiato tutto, e sono cambiate pure la condizione e la collocazione degli intellettuali, la cui maggioranza è ben integrata nel sistema e gode dei suoi privilegi. Per molti della mia generazione il ricordo di Pasolini è ancora molto vivo, e la sua morte una ferita insanabile, ma Desogus si è pronunciato anche contro il suo mito e le strumentalizzazioni a cui viene sottoposto continuamente. E il suo libro non solo ci aiuta a capire meglio la personalità e l’opera di uno dei maggiori intellettuali del Novecento, ma anche la storia del suo tempo.
Giuseppe Muraca
(n. 7-8, luglio-agosto 2025, anno XV)
| |

