









|
|
Linguistica niculesciana. Isole e isolamenti di lingua nella storia del rumeno
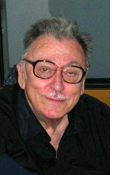 In un convegno sulle isole linguistiche, anche se ciò può sorprendere, la lingua rumena ha un posto privilegiato. Perché la storia della lingua rumena non è altro che storia di comunità linguistiche del continuum romanicum che hanno saputo conservare – al di là del limes e senza l'aiuto della romanità – il loro idioma romanzo, il loro parlar latino... I Francesi hanno preso l'abitudine di chiamarlo «un ilôt latin dans une mer slave»; gli storici (Ferdinand Lot, G. Brătianu) parlano del rumeno, come di un miracolo della storia (che ha permesso di salvare le strutture latino-romanze in un mondo latino scomparso l'unico sopravvivente di un impero sommerso dalla slavità). È un'isola latina, perché l'idioma che si parla oggi nella Romania e al di là delle sue frontiere – in Bessarabia, in Transnistria nella pianura della Tisa e nel Banato serbo – rappresenta una lingua nazionale unitaria (le varianti regionali, in rumeno, sono molto somiglianti l'una all'altra), costituita dall'estensione di un nucleo daco-romano. Ma un'isola che è in relazione con altre isole rumene a sud del Danubio – gli idiomi sud-danubiani, l'arumeno, soprattutto, poi il meglenorumeno – isolate anch'esse e sperdute nella Penisola Balcanica. Se il rumeno nord-danubiano è una lingua qui a réussit – una lingua nazionale – gli idiomi sud-danubiani sono anche oggi (come abbiamo visto dagli interventi fatti in questa sede) in cerca della loro individualità unitaria – sovradialettale - e – last but not least – del riconoscimento che essi meritano. In un convegno sulle isole linguistiche, anche se ciò può sorprendere, la lingua rumena ha un posto privilegiato. Perché la storia della lingua rumena non è altro che storia di comunità linguistiche del continuum romanicum che hanno saputo conservare – al di là del limes e senza l'aiuto della romanità – il loro idioma romanzo, il loro parlar latino... I Francesi hanno preso l'abitudine di chiamarlo «un ilôt latin dans une mer slave»; gli storici (Ferdinand Lot, G. Brătianu) parlano del rumeno, come di un miracolo della storia (che ha permesso di salvare le strutture latino-romanze in un mondo latino scomparso l'unico sopravvivente di un impero sommerso dalla slavità). È un'isola latina, perché l'idioma che si parla oggi nella Romania e al di là delle sue frontiere – in Bessarabia, in Transnistria nella pianura della Tisa e nel Banato serbo – rappresenta una lingua nazionale unitaria (le varianti regionali, in rumeno, sono molto somiglianti l'una all'altra), costituita dall'estensione di un nucleo daco-romano. Ma un'isola che è in relazione con altre isole rumene a sud del Danubio – gli idiomi sud-danubiani, l'arumeno, soprattutto, poi il meglenorumeno – isolate anch'esse e sperdute nella Penisola Balcanica. Se il rumeno nord-danubiano è una lingua qui a réussit – una lingua nazionale – gli idiomi sud-danubiani sono anche oggi (come abbiamo visto dagli interventi fatti in questa sede) in cerca della loro individualità unitaria – sovradialettale - e – last but not least – del riconoscimento che essi meritano.
Si deve dunque concepire il rumeno come un conglomerato d'isolamento e di isole sparpagliate a nord e a sud del Danubio: una zona daco-rumena, oggi un continuum, a nord del Danubio – il daco-rumeno diventa il rumeno – lingua nazionale della Romania e delle regioni vicine alle sue frontiere – isolato tra le lingue slave dell'est, del nord e del nord-ovest, del sud e del sud-ovest (a ovest c’è l’Ungheria) – ma anche il rumeno della Penisola Balcanica (greco-slavo-albanese) come ben dice il nostro colloquio «lingue minoritarie all'interno delle culture minoritarie».
1. Proviamo a esaminare il rumeno in questa prospettiva. Dobbiamo dunque fare – prima di tutto – una distinzione teorica (all'interno della storia del rumeno); I. l'isolamento delle comunità linguistiche, dovute ad un movimento di chiusura, di ripiegamento su se stesse e II. isole linguistiche tout court, dovute all'accerchiamento delle comunità. Il daco-rumeno è, prima, un isolamento linguistico latino-resistente all'interno delle non-romanità; i dialetti sud-danubiani sono isole linguistiche, di comunità più grandi o più piccole sparse nelle zone bulgare-greche-albanesi. L'isolamento precede lo stato di isola linguistica.
2. Anche l'isolamento daco-rumeno, nello spazio carpato-danubiano- pontico (Mar Nero = Pontus Euxinus) ha una sua storia, la storia del suo costituirsi che non è altro che un raggrupparsi di comunità linguistiche sparse territorialmente.
Le scoperte archeologiche e sociopolitiche recenti hanno provato l'esistenza ininterrotta di comunità rurali (communautés villageoises) con un carattere «confederativo e guerriero»: le comunità erano capaci di azioni militari avendo una organizzazione di tipo federale, con una categoria sociale dei capi (gli judices) che potevano resistere agli invasori (H.H. Stahl, 1974), perché avevano degli «obblighi militari». Questi «obblighi» erano fissati dall'Imperator di Bisanzio, dal quale esse dipendevano. È perciò che il lat. imperator si è conservato, oralmente, in rumeno: împărat (e anche in albanese: mbrët) (Niculescu, 1985). Nicolae Iorga, il grande storico rumeno, chiamava romanie (a sud del Danubio, ci sono le vlachie) queste comunità popolari assolutamente autonome l’una dall'altra che potevano, al bisogno, comunicare e unirsi sotto un'autorità ecclesiastica, per difendersi (come fu il caso nel sec. V-VI). Quando Bisanzio volle riconquistare le regioni a nord del Danubio – la reconquista del limes – trovò nella zona danubiana una serie di fossatum (rum. antico fsat, alb. fshat «village»), di terre (rum. țară-țări) – si citano due tra le altre: Fossatum Caput Bovis – che erano delle organizzazioni politico militari – le romanie popolari – dei Rumeni. Queste isole romanofone si trovano all'interno di zone alloglotte o vuote. Eugenia Zaharia 1977 ha descritto la situazione delle comunità rumene libere in Transilvania dei secoli VII-VIII.
«Ces communités territoriales sociales-économiques étaient libres: elles ne se soumettaient pas aux seigneurs locaux, leurs membres dépendaient directement de l'Empereur, de l'État central, sans aucune ingérence de la part des souverains et des pouvoirs environnants. L'Empereur les employait pour défendre - au limes - l'Empire Byzantin. La défense de l'Empire mettait en relation directe ces paysans libres des communes rurales libres avec l'Empereur de Byzance, ils appartenaient a l'Empire, avec leur seule obbligation de prendre les armes, au cas échéant, et arrêter, freiner ou réprimer les invasions extra-limites. L'Empereur même savait les manipuler contre les seigneurs locaux ou contre les nobles d'ailleurs, dans des luttes intestines. Ce type de communes rurales libres (propriété privée et héréditaire, droit de «protimisis», solidarité des impôts) existait un peu partout dans l'Empire avec les mêmes structures juridiques: il était une défense contre l'aristocratie, c'est pour cela que les nobles voulaient les éliminer tandis que l'Empereur désirait les maintenir. Ces communes ont été d'ailleurs la base de la féodalisation de l'Empire». (Niculescu, 1985, p. 418).
Abbiamo accennato anche noi (Niculescu, 1984) al rum. ţară (lat. terra), sottolineando il semantismo «regione, paese», che il lat. terra prende nelle zone rumene (tară-ţăran «contadino»). Le comunità di ţară, sat con le sue strutture social-politiche e militari autonome stanno all'origine della romanità rumena (il principe Demetrio Cantemir le considerava «repubbliche contadine» e ne individuava nei dintorni a Tigheci, «qui aurait pu mobiliser 8000 combatants!»)
3. In questa struttura social-politica frammentata, divisa (in un conglomerato di comunità) sono arrivati gli Slavi. L'invasione degli Slavi trasforma completamente la fisionomia linguistica della Penisola Balcanica. Gli Slavi non sono invasori passeggeri, che arrivano e se ne vanno – come i Goti, come i Gepidi o come gli Unni – ma sono «Barbari» che cercano una patria, in cerca di insediamenti. L'invasione degli Slavi è una penetrazione preparata lentamente: scende dal Nord dei Carpazi e si avvicina al Danubio, traversandolo, nel sec. V. «Au cours de ce dernier siècle leur afflux vers le sud devient de plus en plus considérable» (Densusianu, 1901). Gli Slavi costituiscono «colonie isolate», des enclaves, comunità (enclave) «à peine perceptible» in mezzo alla popolazione romana. È allora che gli Slavi si precipitano verso l'Impero bizantino, diventano padroni della Moesia, della Thracia, della Macedonia. Dopo questo, si dirigono verso Ovest, occupando l'Illiria e la Dalmazia. Nella prima metà del sec. VII tutta la Penisola Balcanica si trovava nelle loro mani. Dopo la conquista romana, la penetrazione slava fu l'avvenimento più importante nella storia della Penisola Balcanica. Per l'elemento romanzo dei Balcani l'invasione ebbe conseguenze importanti: la romanità perde una grande parte del suo territorio; hanno luogo separazioni e dislocazioni di popolazioni romanze; Densusianu 1901, pp. 238-240.
L'invasione slava non separava solo zone balcaniche le une dalle altre, ma separa ancora l'Europa occidentale dalle province orientali. I legami che c'erano tra l'Italia e l'elemento romanzo danubiano si rompono. Le colonie slave installate sul Danubio medio e nelle regioni della Sava e della Drava si interpongono tra l'Italia e la Dalmazia e la Romania carpato-danubiana. L'elemento romanzo dell'Oriente è separato per sempre da quello dell'Occidente – e così si costituisce nel sec. VII, l'isolamento dell'area rumena della romanità.
Per il rumeno, l'invasione slava ebbe un'altra importanza: essa spinse verso il sud, verso le montagne del Pindo, nel sud della Penisola Balcanica una parte delle comunità rumene danubiane: il tronco rumeno si separa in due aree – una nel Nord, l'altra nel Sud – e la conseguenza è la creazione della variante dialettale dell'arumeno. Tra il VII-X secolo questa rottura è un fatto compiuto.
Alcune tribù slave sono passate sul territorio nord-danubiano-dacorumeno (sec. VII, passato, poi, nel VII sec. nel sud-Danubio). Altre tribù, (quelle della Transilvania sono invece rimaste sul posto, stabili), entreranno in contatto con le comunità rumene. Anche le tribù che hanno attraversato il Danubio hanno trovato, nella Moesia (Bulgaria di oggi) comunità romanofone con le quali sono entrate in contatto.
Cosa significa «entrare in contatto»? Una influenza reciproca delle isole comunitarie: (1) Slavi che subiscono influssi daco-romani, introducendo nel loro parlar slavo, elementi rumeni,(2) Daco-romani che, nel loro romanzo, introducono elementi slavi. Questo «contatto» finisce in una «assimilazione»: le comunità più forti e più grandi s'impongono a nord e a sud del Danubio. Gli Slavi s'impongono – numericamente e, forse, anche culturalmente – a sud del Danubio, i Daco-romani a nord. Questi avvenimenti sarebbero del VII secolo: l'influsso slavo sulla lingua dei Rumeni potrebbe essere datato dal VII sec. - VIII sec.
Gli elementi slavi penetravano nel daco-romanzo che diventava rumeno nei secoli VI-VII. Ce ne sono alcuni che sono penetrati prima – forse nel V-VI secolo, e presentano le caratteristiche degli elementi latini (gli stessi trattamenti fonetici) cf. župan > rum. jupîn, stana > rum. stînă, smentana > smîntînă). A questo primo strato fecero seguito altri strati – così che l'influsso slavo sul rumeno, la penetrazione slava durò alcuni secoli – ed è per questa ragione che la penetrazione slava in rumeno è così intensa e così diversa. Il rumeno è stato sottoposto ad una lunga influenza dello slavo, sotto varie forme: lo slavo comune, lo slavo meridionale (bulgaro), lo slavone (lo slavo ecclesiastico, è stato sottoposto ad una lunga influenza dello slavo, sotto varie forme: lo slavo comune, lo slavo meridionale (bulgaro), lo slavone (lo slavo ecclesiastico, letterario), lo slavo orientale e nord-orientale (il russo, il polacco, il ruteno), dal VI-VII secolo in poi, fino ai nostri giorni. Le regioni limitrofe della zona dacorumena (la Bessarabia, il Banato) si sono trovate, esse di più, sotto l'influsso russo (la Bessarabia), sotto quello serbo (il Banato) – e i dialetti rumeni sud-danubiani – l'arumeno, il megleno-rumeno – si sono trovati sotto l'azione dello slavo bulgaro. Il contatto con lo slavo è, per la storia della romanità rumena, il fenomeno più caratteristico. Si può porre anche la domanda legittima: di una lingua rumena, costituita e strutturata si può parlare prima o dopo l'arrivo degli slavi? Le risposte sono state diverse, per diverse ragioni: O. Densusianu ha sempre sottolineato una specificità slava per la romanità rumena, mentre S. Puscariu considerava che, per essere una lingua romanza a sé stante, il rumeno non avrebbe avuto bisogno del contatto con lo slavo, A. Rosetti sostiene l'idea di Densusianu, G. Ivănescu, l'idea di Puscariu.
Tutte queste penetrazioni slave – che durano secoli e secoli – suppongono un contatto tra le comunità linguistiche romanze – (rumene) - dacoromanze – e quelle slave. Perché, così come lo stabiliscono gli storici della lingua rumena, Densusianu 1901, p. 241, «une bonne partie de l'héritage latin (soit) placée par des emprunts faits au slave» – si devono supporre dei contatti slavo-romanzi-rumeni molto stretti. Le parole slave hanno radici profonde nella lingua – come le parole latine. Si è dunque parlato di un periodo di bilinguismo slavo-rumeno, il che significa in concreto che le persone praticavano un uso alternativo di ambedue le lingue (con i fenomeni di interferenze che così nascono). Basta ricordare quei fenomeni di calco linguistico (lume «mondo, terra» e «luce», cf. sl. svět; luna «mese» e «luna», cf. sl. mesec) e le sinonimie (preut-popă, timp-vreme, duh-suflet, arină-nisip) oppure addirittura superposizioni (il vocat. masc. sg. -e: lupe, latino ma anche slavo: rabe) per comprendere la profondità (nel sistema) delle interferenze dovute al bilinguismo slavo-rumeno.
Tutto ciò pone il problema del come, in quali condizioni concrete si è potuto avviare ad una tale «risistemazione delle strutture» (come dice Weinreich 1974). Dobbiamo dunque interrogarci sul problema delle condizioni sociolinguistiche del contatto. È questo aspetto del problema che ci mette di fronte di nuovo nella storia della lingua rumena alle isole linguistiche.
Gli Slavi erano organizzati in organizzazioni tribali župe (obšče) dirette da un župan o da knezi. Le loro abitudini, le loro occupazioni, le loro culture originarie erano, in parte, somiglianti a quelle dei Rumeni: agricoltura e vita pastorale (pastorizia). Anche gli slavi avevano delle organizzazioni difensive guidate da un župan o da un knèz (rum. chinez) che raggruppano più župe: una federazione più larga di isole-comunità. Perciò i primi termini entrati in rumeno sono termini popolari, agricoli, pastorali (jupîn, smîntînă, stăpîn, stînă con il trattamento latino a+n → î; cf. mînă).
Queste organizzazioni gentiliche caratterizzano anche la vita sociale dei Daco-romani: le comunità rumene costituivano dei villaggi delle comuni paesani ed erano guidate dagli judeci (Judices) anche juzi, pl. di jude). Fra i due tipi di comunità incominciano contatti che conducono a fenomeni linguistici di vicinanza, interferenza e bilinguismo: gli Slavi cominciano ad imparare la lingua dalle comunità rumene, le comunità rumene cominciano ad imparare lo slavo di tipo meridionale-bulgaro (št, žd). Ci troviamo di fronte a fenomeni di languages in contact: due sistemi di espressione linguistica per uno stesso contenuto (come ben si sa, Weinreich ha studiato i risultati del contatto: a) un sistema sostituisce l'altro, b) la commutazione delle due lingue, c) l'amalgama delle due lingue). Nelle zone balcaniche, i risultati sono due: gli Slavi imparano le lingue degli autoctoni (nelle zone del nord Danubio, il rumeno in Albania, l'albanese); gli autoctoni imparano la lingua degli Slavi (regioni del sud del Danubio, fino alle montagne del Pindo).
Le ricerche di Petrovici, Daco-slava, «Dacoromania» X, pp. 233-277 (e di Istvan Kniezsa, Ungarns Völkerschaften im XI Jh., Budapest, secondo una recensione in Archivium Europae Centro-Orientalis pp. 517-545; Ivănescu, 1980, p. 276) ammettevano che i Daco-romani si sono ritirati, all'inizio, nelle foreste alte e nelle montagne, all'arrivo degli Slavi che hanno occupato le vallate (un piccolo fiume viene chiamato Repedea (rapidus) alle sue fonti, in montagna, e Bistrita, nelle vallate.
Questa disposizione delle comunità suppone isole linguistiche separate.
I Dacoromani e gli Slavi che, con il passar del tempo, s'incontrano (entrano in contatto): gli Slavi salgono verso le cime (dove impongono dei toponimici quale Zlatna, Tîrnav, Ivănescu 1980, p. 277), i Dacoromani scendono verso le vallate, facendo incominciare l'epoca della simbiosi rumeno-slava.
Tutto ciò è stato reso possibile da una vita sociale e politica molto somigliante. Si è detto che gli Slavi sono venuti quali conquistadores: una invasione «in forza» (fr. musclée) che aveva trasformato i Dacoromani in «servi» (rom. șerb) cf. rumân «servo». Questa asserzione non è che, parzialmente e nell'ultimo periodo, vera... Gli Slavi erano venuti nella zona daco-romana per restarci. Ed è per questo che i loro «contatti» con le comunità daco-romane è stato piuttosto pacifico. Le ricerche archeologiche non hanno trovato – dei sec. VII-IX – che pochissimi resti di agglomerati permanenti slavi: gli scavi archeologici scoprono di solito delle zone di cultura slavo-rumena, ciò che fa supporre che i tempi dell'isolamento slavo e rumeno è durato poco. I vasi, la ceramica, gli strumenti agricoli primitivi sono, più o meno, uguali o identici per gli slavi e per le comunità daco-romane. La simbiosi attestata dall'archeologia, sembra essere più pertinente, che l'epoca della separazione. Essa porta infatti ad uno scioglimento delle isole, alla permeabilità che precede l'unione.
Il contatto tra le due popolazioni è stato agevolato anche dalle somiglianze socio-politiche e culturali delle comunità. I Daco-romani, nelle loro romanie, v(a)lachíe praticavano la pastorizia alta, nelle montagne, ma anche l'agricoltura (le due occupazioni andavano spesso insieme: i pastori coltivavano anche le terre, quando avevano l'occasione di vivere nelle zone di coltura agricola, oppure nelle pianure (erano transumanti, trasmigranti). Gli Slavi praticavano anche essi l'agricoltura e la pastorizia locale, nei dintorni delle loro terre. Sul territorio daco-rumeno, i pastori avevano l'ovile (stînă), nelle montagne, gli Slavi, nella zona delle colline e nelle valli. Salire nelle montagne o scendere verso le vallate diventava sempre più facile per le comunità che avevano strutture socio-professionali, ma anche strutture socio-politiche somiglianti.
Le unioni di comunità avevano dei capi che si chiamavano, in rumeno chinezi (in Transilvania, cf. sl. knez, oppure celnici (nel sud del Danubio; cf. v. sl. čelo «fronte», da dove il rum. fruntaș) ma anche jude (pl. juzi). I titoli dei capi delle comunità si equivalevano.
Ci sembra però di poter distinguere in questo scioglimento delle isole e il rifarsi di una comunità mista, slavo-rumena, una certa preponderanza degli Slavi. P.P. Panaitescu, Interpretări românești București 1947, p. 54-56 (ap. Ivănescu 1980, p. 273) facendo l'analisi etimologica dei termini delle classi altolocate in rumeno, scopriva l'origine slava: boier, stăpîn, jupîn, gospodar sono infatti elementi slavi così come slavi sono lo stesso i termini di servo, servire (slugă, sluji) – in opposizione ai termini di origine latina che indicano solo la popolazione «bassa», țăran (< țară) (terra), serb (servus), rumân (romanus). È possibile che questi termini con il loro sviluppo semantico siano una creazione tarda, dopo il X secolo, quando, assieme agli stati slavi nuovamente creati, le comunità slavo-rumene nate dalla simbiosi e dallo scioglimento dell'isolamento, hanno introdotto anche essi le strutture sociali feudali (slugă, a sluji «servire» sarebbero una prova che non soltanto i Rumeni si trovano nel basso della vita sociale!).
Ci possiamo ormai chiedere le cause della «vittoria» di una o dell'altra delle due lingue, in questo processo di scioglimento delle isole. Perché da questa simbiosi ha approfittato, nel Nord, il rumeno, imponendosi quale lingua delle comunità riunite slavo-rumene, perché, nel Sud, dove c’è stato lo stesso fenomeno, il risultato linguistico è a favore dello slavo?
L'unica risposta che possiamo dare ad una tale domanda è demografica e culturale. In tutte le zone dove si sono stabiliti, gli Slavi hanno trovato, sul posto, comunità daco-romane compatte e dense al confronto delle quali essi erano in minoranza. Questa superiorità non era solamente di ordine numerico, quantitativo, ma anche di tipo qualitativo: gli scavi archeologici scoprono anche oggi sempre tracce di cultura materiale daco-romana autoctona ben costituita e conservata, di fronte alle quali i nuovi arrivati, gli Slavi non opponevano all'inizio, nei secoli VII-VIII una cultura propria (non dimentichiamo che gli Slavi sono culturalizzati “nel senso dell'acculturation") solo dopo la loro cristianizzazione, dal IX secolo in poi, dalla cultura greca bizantina. Abbiamo dunque il diritto di considerare che, in un primo tempo dei contatti tra le comunità daco-romane e quelle slave, la preponderanza numerica e culturale era dalla parte delle popolazioni daco-romane e che sono stati gli Slavi ad imparare il daco-romano – ma che, in un secondo tempo, dopo la costituzione dello stato bulgaro e dopo la cristianizzazione (sec. IX) il peso degli Slavi, soprattutto a sud del Danubio, è diventato più importante di quello dei Rumeni (dunque, la slavizzazione). Lo scioglimento delle isole in favore di un gruppo o di un altro è determinato, demograficamente o culturalmente, da una "superiorità" numerica e/o culturale.
Il periodo della costituzione delle comunità slave rumene miste, dopo il periodo della "simbiosi", – il terzo periodo – è quello dell'introduzione delle strutture feudali – riprese da Bisanzio. Si arriva ad una organizzazione di tipo bizantino-slavo della struttura sociale delle comunità slavo-rumene. Siamo nei sec. XI-XII. Del resto, dai sec. XIII-XIV, le comunità rumene, organizzate ormai in Stati, entrano definitivamente (fino nel XVIII-XIX sec.) nella zona di cultura religiosa greca e amministrativa slava: "anima rumena in abiti slavi" scriveva il grande storico della letteratura rumena antica N. Cartojan.
II
5. La penetrazione dei Magiari dalla puszta Pannonica verso la Transilvania dove si erano stabiliti, nel sec. IX (896), si fa in più tempi e più tappe, incominciando dal sec. X fino al sec. XII-XIII. Il notaio anonimo (Anonymus) del re magiaro Béla (sec. XIII) è il cronista che ha descritto (o raccontato) minuziosamente l'avanzata ungherese verso l'Est (verso ciò che chiamava bonitas terra ultrasilvana (secondo Anonymus, i Magiari hanno incontrato la resistenza dei ducati slavo-rumeni, diretti dai duces: uno era Menumorut, che aveva il suo dominio (ducato) nel nord-ovest della Transilvania, un secondo Gelou, che regnava nella Transilvania propriamente detta, e il terzo Glad, nel Banato, sostenuto da alcuni knezi bulgari oltre il Danubio e dei Blaci ( = Vlachus) cioè dai Rumeni. (Di tutti e tre, Gelou è chiamato Dux Blacorum, oppure Dux Ultrasilvanus). Abbiamo così una descrizione socio-politica della Transilvania del X-XIII secolo: delle comunità slavo-rumene che avevano le loro organizzazioni politiche (ducati-voievodati-cnezati) – un conglomerato di comunità – isole linguistiche. Tutti questi duces si sono opposti militarmente all'avanzata magiara del re Arpad: Menumorut – il primo – rifiuta l'offerta di sottomissione bulgarico corde, perché si considerava sotto la protezione dell'imperatore di Costantinopoli (il che attesta almeno la sovranità bizantina sulle terre del nord del Danubio anche nella Transilvania e la coscienza dell'appartenenza all'Impero), entra in guerra ed è costretto ad arrendersi, Gelou muore nei combattimenti e Gled, dopo un primo riscontro, accettò – l'ultimo – la denominazione dei Magiari con la condizione di mantenere l'autonomia del Banato. In seguito a queste battaglie contro i "duci" rumeno-slavi, il comandante che conduceva l'esercito magiaro, un certo Tuhutum, fu accettato quale voivoda di Transilvania, ma la regione rimaneva autonoma di fronte all’unione delle tribù ungheresi.
Un ultimo voivoda romeno-slavo, Ahtum, è costretto anche lui ad una guerra contro l'esercito ungherese che l'aggrediva. Una Legenda Sancti Gerardi (del XII secolo) racconta questo episodio, non dimenticando di menzionare che Ahtum si appoggiava, anche lui, sui buoni rapporti che aveva con l'Impero Bizantino. La presenza bizantina dell'imperator era dunque risentita in Transilvania, nel sec. XI! Questa situazione-posizione speciale fece sì che il Voivodato di Transilvania conservasse il titolo di Principato o Voivodato e che restasse in buonissimi rapporti con l'Impero Bizantino. Così si spiega la presenza ad Alba-Iulia (Bălgrad), nel cuore della Transilvania, di un vescovato ortodosso-greco che diventò, assieme alla città di Alba-Iulia, il centro confessionale e politico tradizionale dei Rumeni della Transilvania. Così si spiegano ugualmente i buoni rapporti che i Romeni della Transilvania ebbero sempre con i Romeni della Valacchia (Muntenia) e della Moldavia – a tal modo che separati dall'XI secolo – la lingua rumena dei Romeni di Transilvania non è troppo diversa dalle lingue parlate dall'altra parte dei Carpazi.
Queste sono le premesse di una estensione del lessico di origine ungherese in tutta la lingua dei Rumeni. In questa prima fase dei rapporti tra le comunità ungheresi e le comunità rumene, la situazione socio-politica manteneva una permeabilità delle comunità rumene e magiare nel quadro di una regione occupata dagli Ungheresi, ma autonoma religiosamente e politicamente, il Voivodato di Transilvania – ebbe i suoi contributi alla penetrazione dei magiarismi nella lingua rumena. Infatti la penetrazione linguistica ungherese è limitata al lessico che comincia ad essere presente nel rumeno del nord (il dacorumeno) partire dai sec. XII-XIII. Parole come hotar "frontiera", meșter "maestro", vamă "dogana", oraș "città", dijmă "decima" sono attestate nel sec. XV e coincidono con l'organizzazione feudale moderna della vita sociale. Alcune parole di origine magiara: chip, fel, gînd, întîlni, mereu, meșter, neam, oraș, seamă, talpă, vamă ecc. (Densusianu 1901, Florica Dimitrescu et alii 1978, p. 100) fanno parte dal fondo lessicale centrale della lingua rumena. Ci sono anche suffissi di origine magiara: -a, -e. Alcune parole di origine ungherese erano, in ungherese, di origine germanica: meszter, bíró, herceg, polgár (rum. pîrgar, germ. Bürger (meister) ecc.
Ma incominciando dal XIII sec., i re magiari cambiano la politica verso la Transilvania. Comincia la non-fiducia nei confronti delle comunità rumene che rimanevano circoscritte nei loro villaggi. Le autorità magiare volevano far sviluppare una vita urbana, fondare delle città che corrispondessero alle civiltà feudali dell'Occidente. È per queste ragioni che gli Ungheresi fecero colonizzare la Transilvania, facendo venire dall'Occidente coloni germanici (i cosiddetti Sassoni, rum. Sași). Si chiamavano "Sassoni" ma venivano dalle Fiandre, dalle regioni del Reno occidentale, dal Lussemburgo e anche dal Mare del Nord. Nel XIII secolo sono fatti venire in Transilvania anche i Cavalieri Teutonici (tra il 1211 e il 1225).
Allo stesso tempo comincia una politica di attrazione dei knezi rumeno-slavi. I knezi diventano amministratori e judices dei villaggi rumeni, rappresentando l'autorità superiore, il re, i nobili, il clero. Si fa uno jus kenezatus oppure jus keneziale (o keneziatus) che il re ha il diritto di dare – su un tempo limitato o per tutta la vita – a qualcuno che serve con fiducia il proprietario magiaro del villaggio. I knezi riescono ad entrare nelle classi privilegiati magiarizzandosi (così diventano da Drag > Dragfi, da Ban > Banfi, da Cîndea > Kendeffy; Rumeni di origine erano i Corvini (< Corvus) e anche Nicolaus Olahus).
In Maramureș i voivodi e cnezi avevano attribuzioni più estese. Essi diventano nobili del "Regat" (regno).
E i Rumeni? I contadini rumeni – perché la stragrande maggioranza erano contadini – si depauperizzano sempre di più: adscripti glebae, essi non potevano trasferirsi da un dominio all’altro senza l'approvazione del proprietario e solo se avevano pagato le tasse e avevano fatto le giornate di lavoro per il proprietario. Una sorte uguale ebbero anche i Knezi rumeni: la depauperizzazione, attraversando le montagne dei Carpazi. Perciò molti Rumeni, contadini soprattutto, scappavano verso Sud, in Valacchia, attraversando le montagne dei Carpazi. Economicamente poveri, oppressi e socialmente marginalizzati, i Rumeni autoctoni si separavano sempre di più dai Magiari (e da altre comunità di stranieri collocati – colonizzati – in Transilvania).
Tutto ciò crea un distacco sempre più grande tra i Rumeni e gli Ungheresi. Essi non partecipavano alla vita dello Stato – che era una vita ungherese – non avevano la stessa religione come gli Ungheresi, non gli si riconoscevano diritti. In più, nel 1437, la legge dell'Unio Trium Nationum, l'alleanza fra le "tre nazioni", Magiari, Szekely e Sassoni (Tedeschi) lascia fuori legge, tollerati, in una specie di "apartheid" i Rumeni, che rappresentavano la maggioranza della popolazione transilvana. Entrati in questa segregazione, i Rumeni reagirono con delle ribellioni e rivolte durante i secoli, ma soprattutto con una separazione totale, socioculturale, religiosa, politica ed economica, di tutto ciò che rappresentava il potere governativo ungherese in Transilvania. Le comunità autoctone di Rumeni si chiudevano e si isolavano soprattutto in campagna, nella vita rurale, lasciando ai governativi ungheresi le città, i centri di cultura e di religione. Questi rapporti conflittuali in politica durarono fino all'integrazione definitiva della Transilvania alla Romania, alla fine della prima guerra mondiale (1918); allora la situazione si rovesciò: furono i Magiari a costituirsi in comunità chiuse, pronte a chiedere diritti di lingua e di autonomia. Questo conflitto, del resto, dura tutt'oggi...
I risultati di una tale separazione delle comunità rumene e ungheresi in Transilvania è stato l'isolamento linguistico. Nessuna permeabilità delle comunità; comunità trasformate in isole linguistiche; culture minoritarie. L'azione dell'ungherese sul rumeno è esclusivamente regionale, limitata alla Transilvania: tra le più note quale regionalismo astăluș "falegname", bolund "pazzo" (magh. bolond), corbaci "frusta", palinca "acquavite", sabău (magh. szabó) "sarto" ecc. Nelle parlate (dialetti) rumeni della Transilvania, solo il 9,60% sono prestiti magiari (con un potere di frequenza-circolazione del 2,90%), di fronte all'84,02% di elementi latini (R. Todoran, ap. Dimitrescu et alii, 1978, p. 101). Altrettanto poche parole sono passate dal rumeno in ungherese: ficsur, sztronga, bechecs, csuta, "cerva", rippa "riva" (v. Bledy Géza, Influenţa limbii române asupra limbii maghiare (Influsso della lingua rumena sulla lingua magiara), Sibiu 1942; Márton Gyula "Studia", 1967, pp. 29-39). Le comunità vivono separatamente.
È molto interessante sottolineare che questo tipo di influenze reciproche si realizza meglio nelle regioni moldave dei Csango (rum. Ceangăi) dove le comunità magiare dei Csango hanno una posizione sociale e occupazioni somiglianti a quello dei Rumeni: infatti sono piuttosto delle comunità dei villaggi che vivono una vita rurale comune. I Csango vivono anche al di là dei Carpazi, in Moldavia. I dialettologi rumeni sottolineano questo influsso rumeno sull'ungherese dei Csango – soprattutto in Moldavia: i Csango costituiscono anch'essi delle isole linguistiche minoritarie. Forse per questa ragione sono praticamente bilingui. L'influsso rumeno sull'ungherese dei Csango viene valutato a 2800 parole (Florica Dimitrescu et alii 1978, p. 102). Però il dialetto ungherese resiste, non scompare. Le isole persistono, anche se l'isolamento è più penetrabile...
III
Abbiamo presentato finora il ruolo dell'isolamento delle isole nella storia di una lingua: il rumeno.
Assistiamo dunque, nella storia della lingua rumena, a un doppio tipo di movimento linguistico:
1) dalle comunità separate (isole linguistiche) allo scioglimento dell'isolamento e alla formazione di comunità miste: il caso dei rapporti slavo-rumeni secondo uno schema:
isolamento → permeabilità → bilinguismo → vittoria di una permeabilità → bilinguismo → vittoria di una o dell'altra lingua;
2) da più comunità linguistiche in contatto (quali le comunità ungheresi e rumene, all'inizio dei contatti, nel quadro di una regione autonoma all'interno del regno ungherese, la provincia voivodato di Transilvania) – ma non riunite, – all'isolamento di ognuno dei due tipi di comunità, si arriva alla formazione obbligata di isole linguistiche (nelle condizioni dell'integrazione politico-statale obbligata in una delle due comunità di lingue). Gli Ungheresi nella Romania di oggi, i Rumeni nell’Ungheria di oggi costituiscono solo delle isole linguistiche.
Lo schema sarebbe:
comunità in contatto → permeabilità → isolamento → isole linguistiche
Il rumeno – quale lingua delle comunità socio-politiche ben definite – può illustrare, se interpretiamo attentamente e se analizziamo concretamente la sua storia, la formazione delle isole linguistiche, la permeabilità che accompagna, talvolta, il loro contatto, la fusione delle isole linguisticamente miste tramite il bilinguismo – bensì anche l'isolamento perpetuo tra le comunità che, ugualmente, non vogliono/possono entrare in contatto.
Tutto dipende dalle condizioni socio-culturali e socio-politiche alle quali sono sottomesse le comunità – ciò vuol dire che la lingua è l'ancilla delle strutture sociali della comunità.
Questa è, infine, la ragione principale per la quale consideravamo, all'inizio di questo discorso, che il rumeno dovesse avere un posto interessante in una discussione sulle isole linguistiche minoritarie, questo perché il rumeno è stato, durante i secoli della sua storia, minoritario e di maggioranza, in isolamento o in osmosi linguistica, in una area romanza continua ma anche al di là dell'area continua, in area non-romanza, ma anche all'infuori di essa, in una evoluzione sui-generis.
* Alexandru Niculescu, Isole e isolamenti di lingua nella storia del rumeno in Isole linguistiche e culturali all'interno di culture minoritarie: problemi psico-linguistici, socio-linguistici, educativi, a cura di Nereo Perini, Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari, Udine, 1988, pp. 163-173.
(n. 7-8, luglio-agosto 2025, anno XV)
BIBLIOGRAFIA
1. O. DENSUSIANU, Histoire de la langue roumaine, tome I, Paris, 1901.
2. FLORICA DIMITRESCU et alii, Istoria limbii române, Bucarest, 1978.
3. G. IVĂNESCU, Istoria limbii române, Iași, 1980.
4. A. MIONI, Una lingua per la religione: problemi sociolinguistici, in Memoria del sacro e tradizione orale; Atti del terzo colloquio del centro di studi Antoniani, Padova, 1984, pp. 277-291.
5. A. NICULESCU, Roum. lucra (a) -munci (a) "travailler" in "Bulletin de la Société de linguistique de Paris", t. LXXVIII (1983), f. 1, pp. 325-355.
6. A. NICULESCU, Roum. ţară in "Bulletin de la Société de linguistique de Paris", T. LXXIX, 1984, f. 1, pp. 274-251.
7. A NICULESCU, Aspects socio-culturels du vocabulaire latin du roumain in Actes du XVII Congrès International de Linguistique et Philologie Romane, vol. 3, 1985, pp. 413-419.
8. A. ROSETTI, Istoria limbii române, Bucarest, 1978.
9. A.G. SAVU, PETRE DIACONU, RADU POPA, La résistance des Roumains pendant la période des migrations, in Roumanie, Pages d'histoire X, 1985, 4, p. 73-97.
10. H. H. STAHL in Aujourd'hui, l'histoire, Editions Sociales, Paris 1974, pp. 41-42.
11. U. WEINREICH, Lingue in contatto (Trad. it.) Boringhieri 1974.
12. E. ZAHARIA, Populația românească în Transilvania, în sec. VII-VIII, Bucarest 1977.
|
|

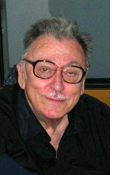 In un convegno sulle isole linguistiche, anche se ciò può sorprendere, la lingua rumena ha un posto privilegiato. Perché la storia della lingua rumena non è altro che storia di comunità linguistiche del continuum romanicum che hanno saputo conservare – al di là del limes e senza l'aiuto della romanità – il loro idioma romanzo, il loro parlar latino... I Francesi hanno preso l'abitudine di chiamarlo «un ilôt latin dans une mer slave»; gli storici (Ferdinand Lot, G. Brătianu) parlano del rumeno, come di un miracolo della storia (che ha permesso di salvare le strutture latino-romanze in un mondo latino scomparso l'unico sopravvivente di un impero sommerso dalla slavità). È un'isola latina, perché l'idioma che si parla oggi nella Romania e al di là delle sue frontiere – in Bessarabia, in Transnistria nella pianura della Tisa e nel Banato serbo – rappresenta una lingua nazionale unitaria (le varianti regionali, in rumeno, sono molto somiglianti l'una all'altra), costituita dall'estensione di un nucleo daco-romano. Ma un'isola che è in relazione con altre isole rumene a sud del Danubio – gli idiomi sud-danubiani, l'arumeno, soprattutto, poi il meglenorumeno – isolate anch'esse e sperdute nella Penisola Balcanica. Se il rumeno nord-danubiano è una lingua qui a réussit – una lingua nazionale – gli idiomi sud-danubiani sono anche oggi (come abbiamo visto dagli interventi fatti in questa sede) in cerca della loro individualità unitaria – sovradialettale - e – last but not least – del riconoscimento che essi meritano.
In un convegno sulle isole linguistiche, anche se ciò può sorprendere, la lingua rumena ha un posto privilegiato. Perché la storia della lingua rumena non è altro che storia di comunità linguistiche del continuum romanicum che hanno saputo conservare – al di là del limes e senza l'aiuto della romanità – il loro idioma romanzo, il loro parlar latino... I Francesi hanno preso l'abitudine di chiamarlo «un ilôt latin dans une mer slave»; gli storici (Ferdinand Lot, G. Brătianu) parlano del rumeno, come di un miracolo della storia (che ha permesso di salvare le strutture latino-romanze in un mondo latino scomparso l'unico sopravvivente di un impero sommerso dalla slavità). È un'isola latina, perché l'idioma che si parla oggi nella Romania e al di là delle sue frontiere – in Bessarabia, in Transnistria nella pianura della Tisa e nel Banato serbo – rappresenta una lingua nazionale unitaria (le varianti regionali, in rumeno, sono molto somiglianti l'una all'altra), costituita dall'estensione di un nucleo daco-romano. Ma un'isola che è in relazione con altre isole rumene a sud del Danubio – gli idiomi sud-danubiani, l'arumeno, soprattutto, poi il meglenorumeno – isolate anch'esse e sperdute nella Penisola Balcanica. Se il rumeno nord-danubiano è una lingua qui a réussit – una lingua nazionale – gli idiomi sud-danubiani sono anche oggi (come abbiamo visto dagli interventi fatti in questa sede) in cerca della loro individualità unitaria – sovradialettale - e – last but not least – del riconoscimento che essi meritano.