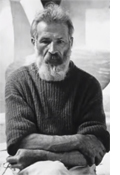|
|
Sublime, sublimazione, sublimalismo nell'opera di Constantin Brâncuși
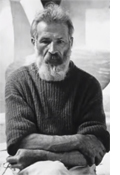 Parlare di Constantin Brâncuși non è facile, perché la sua opera suppone una lettura partecipativa e invita lo spettatore a meditare... La tavola del silenzio ne è la prova... È una tavola rotonda alla quale, se ci sediamo su una delle dodici sedie, rotonde pure esse, non potremo pranzare o cenare, ma potremo solo chiederci a cosa serve un tavolo al quale si può sedere, ma non si possono appoggiare i gomiti sul bordo del piano orizzontale e non si può nemmeno avvicinare la sedia al tavolo, cioè fare un gesto molto spontaneo e naturale. Soltanto dopo aver guardato e osservato a lungo quest’opera, possiamo tentare di decifrarene il significato simbolico che ci evoca l’Ultima cena. Poi, finalmente, possiamo fare anche un selfie lì e partire con il sentimento di aver visto qualcosa di speciale, pro sublime. Parlare di Constantin Brâncuși non è facile, perché la sua opera suppone una lettura partecipativa e invita lo spettatore a meditare... La tavola del silenzio ne è la prova... È una tavola rotonda alla quale, se ci sediamo su una delle dodici sedie, rotonde pure esse, non potremo pranzare o cenare, ma potremo solo chiederci a cosa serve un tavolo al quale si può sedere, ma non si possono appoggiare i gomiti sul bordo del piano orizzontale e non si può nemmeno avvicinare la sedia al tavolo, cioè fare un gesto molto spontaneo e naturale. Soltanto dopo aver guardato e osservato a lungo quest’opera, possiamo tentare di decifrarene il significato simbolico che ci evoca l’Ultima cena. Poi, finalmente, possiamo fare anche un selfie lì e partire con il sentimento di aver visto qualcosa di speciale, pro sublime.
Però quelli che vogliono vivere intensamente l'emozione del momento dell'incontro con l'opera di Brâncuși, dunque analizzare un’opera brancusiana, devono prepararsi, cioè occorre, inizialmente, sapere cosa c’è da vedere, osservare, leggere e scoprire al di là delle apparenze. Nel testo presente proponiamo al fruitore di non rimanere alla modalità di godimento di tipo spontaneo, ma anche di penetrare nel significato profondo dell’universo sculptoreo del famoso scultore romeno. Parlare ai giovani di Brâncuși è una necessità e un dovere e allo stesso tempo una responsabilità difficile da assumere. E io dovrò seguire l'esempio dell'illustre E.H. Gombrich, il quale, quando scrisse la Storia del mondo, mirava a farla come il nonno che vuole raccontare ai suoi nipoti la storia dell'umanità. E tutto questo, senza spaventare il bambino con troppe date, anni, numeri e nomi difficilmente da ricordare.
L'arte può essere compresa solo analizzando il suo divenire. Quindi dovremo tornare indietro di due millenni per capire Brâncuși... Dovremo parlare di quello che gli antichi greci chiamavano mimesis, cioè l'arte di copiare la natura. Ma quando apparse questo fenomeno? Tentiamo una spiegazione, provando di ritornare nel tempo. Conformemente alle teorie del grande filosofo greco Platone, quando vediamo un'ombra, distinguiamo praticamente un disegno, o, come amava dire, intravediamo un'idea. Una fonte di luce proietterà sempre un'ombra e la figura che un corpo facente ombra proietta su una superficie e che ne riproduce, più o meno alterata, assomiglierà alla forma della realtà... L'ombra è, praticamente, un disegno della natura. Un disegno estroso perché si deforma sui rilievi delle pareti e ha solo due dimensioni. Tuttavia, sappiamo che lo spazio ha tre dimensioni, quindi non sorprende che Platone abbia visto nell'ombra non necessariamente le realtà, ma piuttosto idee sulla realtà. L'ombra costituisce, quindi, una forma naturale di mimesis, una realtà priva della terza dimensione. Osservando un'ombra, a condizione che questa non sia distorta, possiamo riconoscere l'oggetto o il carattere che la genera. Possiamo dedurre che l'ombra rappresenta, in un certo modo, la forma primordiale del disegno che la natura ci ha regalato.
Oltre all'ombra, un altro fenomeno della natura che ci aiuta a comprendere il concetto di mimesis è quello del riflesso, oppure semplicemente il fenomeno del rispecchiamento. Quando ci guardiamo allo specchio, crediamo che la superficie dello specchio riproduca accuratamente la nostra stessa immagine. Ma, come ci insegna la fisica stessa, l'immagine è, per eccellenza, virtuale, cioè si produce sul piano mentale, come un'idea. Non esiste, quindi, in realtà, ma è una costruzione naturale la cui comprensione si basa sulla nostra percezione e immaginazione.
Un ultimo fenomeno della natura che può aiutarci a capire il mondo delle idee, questo universo che esiste solo nella nostra mente, è l'impronta. Se scopriamo l'impronta della zampa di un cane sulla neve, anche se non vediamo il cane, la nostra mente visualizza l'immagine generica di un cane. Quindi nella nostra immaginazione appare un cane che in realtà non vediamo in quel preciso momento, ma lo vediamo con la mente in base alle nostre conoscenze ed esperienze sull'ambiente naturale.
Partendo dal desiderio dell'uomo di imitare la natura, animato pure dal contatto e dalla percezione dei fenomeni naturali di cui abbiamo parlato prima, l'ombra, l'immagine specchiata e l'impronta, i teorici hanno intuito un principio estetico, secondo il quale l'arte è l'imitazione della realtà, cioè il concetto di mimesis. Sviluppato soprattutto nell'antichità, tra i molteplici significati del termine, ricordiamo la concezione di Platone che considerava la mimesi nella sua qualità di «imitazione dell'imitazione», fatto che fa scattare la domanda: si tratta di un'imitazione della verità o di un'illusione? Nella concezione platonica dell’arte, la mimesi è da condannare perché, imitando le cose, si allontana dal vero. Tuttavia, nell’estetica aristotelica, mimesi acquista un significato positivo, come imitazione della forma ideale della realtà, per cui l’operare dell’artista diventa simile all’operare della natura [1].
Date queste considerazioni è spiegabile che apparvero i primi artisti che cercarono di copiare la natura e, poiché volevano imitare la natura, i greci iniziarono a misurare tutto, con una predilezione speciale per il corpo umano. Dunque, per la prima volta nella storia umana, gli artisti iniziarono a studiare le proporzioni del corpo umano. Inoltre, scoprirono che tutto in natura obbedisce al principio della sezione aurea [2].
Gli scienziati antichi elaborarono, dunque, questa formula matematica che riguarda le proporzioni ideali. Nella scultura e architettura greca si stabilirono, quindi, per la prima volta nella storia del mondo, le misure del corpo umano da una prospettiva matematica. Dopo più di 1500 anni, Leonardo da Vinci disegnerà l'Uomo Vitruviano e il concetto di mimesi raggiungerà la sua prima espressione ben definita. Per il nostro approccio, riteniamo, quindi, che la nozione di mimesi è nata nell'antica Grecia e ha trovato la sua massima espressione nel Rinascimento, attraverso Michelangelo e Leonardo. Dunque, per un lungo periodo storico l'imitazione divenne un concetto diffuso nell’arte. Infatti, da un lato si sviluppa la tesi secondo cui la natura non va imitata in particolare, ma soprattutto le opere degli antichi che ne diventano oggetto. Si conserva invece un significato antico del concetto di mimesis, legato all'idea di «copia fedele della realtà», che incoraggia gli studi sulle regole per la corretta costruzione della prospettiva. Infatti, nell’ultima frase, ho sintetizzato il parere di uno specialista, più precisamente della professoressa Maddalena Mazzocut-Mis [3], che indaga l'immagine dal punto di vista storico e dalla prospettiva di un ricercatore che possiede anche un'esperienza filosofica. La cui conclusione sostiene il nostro discorso: nelle arti figurative, mimesis significa imitazione, ma anche costruire la realtà.
Brâncuși è cresciuto osservando attentamente la mimesi... Ha disegnato e modellato in conformità con la filosofia di Platone, senza tralasciare i modelli di bellezza della scultura greca antica e rinascimentale. Si è appropriato di 2000 anni di storia dell'arte ed è diventato un esperto della rappresentazione anatomicamente proporzionale del corpo umano, dimostrandosi un perfetto maestro nel renderne le forme naturali e sintetizzando le essenze del mondo nelle immagini plastiche. Per lui, l'uomo ha la pelle, sotto la pelle ci sono i muscoli e sotto i muscoli le ossa. La prova è l'Ecorché modellato in gioventù, in collaborazione con il dottor Dimitrie Gerota, un'opera con la quale lo scultore dimostra un'eminente conoscenza dell'anatomia umana. Il busto del generale Davila o Vitellius sono opere che parlano da sole di questa realtà. Come nota lo storico dell'arte Pavel Șușară in Brâncuși, scultore dell'oriente/ levante, proprio perché ha studiato la composizione del corpo umano, fatto di carne e ossa, Brâncuși finisce per porre la sua domanda fantastica: l'uomo può essere ritratto solo dalla prospettiva del suo aspetto esteriore, o può essere ritratto mettendo in risalto il suo spirito, la sua anima? In altre parole, lo scultore si fa filosofo e si chiede: l'uomo è solo un corpo? L'aspetto esteriore è l'unica realtà che lo caratterizza? Ci sono modi di rappresentare il concetto di ‘uomo’ che non considerino solo ciò che è visibile? Possiamo guardare l'uomo dall'interno verso l'esterno? Interessa solo la forma? Come si può descrivere il contenuto, l'essenza, la sostanza? C'è una parte invisibile che l'artista può evidenziare per catturare l'unicità di un personaggio?
Un'opera d'arte deve innanzitutto mettere in luce lo spirito, il mistero o l'ineffabile e non l'aspetto esteriore del personaggio, dice Brâncuși. Ecco perché proporrà una fontana per commemorare un personaggio come Spiru Haret, con totale sconcerto di coloro che volevano un vero Spiru Haret su un piedistallo. Poiché Brâncuși voleva vedere in Spiru Haret l'anima unica dell'uomo e non solo il suo aspetto esteriore. Spiru Haret, per lo scultore, era una fontana spirituale e morale, con la cui «acqua» crebbe la scuola romena. Brâncuși guardava all'essenza e non all'apparenza, negando in questo modo la tradizione della mimesi. Per egli l'uomo-soggetto non è definito dalla sua condizione oggettiva, ma da quella spirituale. E l'arte era stanca nell'epopea della resa degli aspetti esteriori, come risulta dalle stesse affermazioni dello scultore: «La tradizione è stata interrotta durante il Rinascimento. Ho il massimo rispetto per Giotto, dopo di lui vennero tiranni, come Michelangelo, che dipinse senza sentimento religioso e anche senza rispetto per la vita. Ho visto la Cappella Sistina. È come una macelleria. Ciò che serve è fluidità, forza e adorazione della linea» (n.tr).
Brâncuși è quindi un ricercatore di archetipi, di antiche strutture significative che possono essere comprese solo dalla prospettiva del mistero della condizione umana. Solo così possiamo accettare quanto si dice della Monnalisa di Leonardo, che ha un sorriso misterioso... Ma il mistero della donna è solo nel suo sorriso e nei suoi occhi? E ancora bisogna fare riferimento a quanto dice Brâncuși: «La mia statua, capite, signore, è la donna, la sintesi stessa della donna. Per cinque anni ho lavorato, e ho semplificato, ho fatto dire alla materia ciò che non si può dire. E qual è la donna alla fine? Un sorriso tra pizzo e fard? Questa non è la donna!» (n.tr.)
Se guardiamo Madame Pogany rimaniamo stupiti dal mistero che esprime la scultura. Manca il sorriso, la bocca è appena abbozzata, proprio per sottolineare uno sguardo enorme e timido che evita lo sguardo dello spettatore. La Monnalisa è ovviamente in posa, ci guarda quasi in modo provocatorio ed esiste perché è vista da Leonardo in carne e ossa. Pogany evita il nostro sguardo con l'ingenuità e la modestia della prima giovinezza. Pogany è la fanciulla che sa che diventerà una donna. Pogany è la rappresentazione della femminilità che mette in discussione la sua condizione. Ecco l’opinione di Matei Stircea Crăciun, autore di un ampio trattato di ermeneutica sulla creazione brancusiana:
«In MademoisellePogany II (1919) e MademoisellePogany III (1931), le alte sopracciglia inscrivono due enormi archi circolari che scendono vigili verso la punta del naso appuntito, come il becco di un uccello. In quest'ultima versione, l'artista ha posto gli occhi a clessidra su Mademoiselle Pogany I che ha il disegno puro delle palpebre chiuse, sorprendentemente ricurve verso l'alto, convesse come uccelli – che, anche quando dormono, sembrano dialogare con l'alto. La licenza anatomica afferma la continuazione dell'idea tra il motivo di Mademoiselle Pogany e il motivo di Birds in the Air. Braccia fuse l'una all'altra, un sottile fuso» [6].
Brâncuși va inteso, quindi, come un filosofo dell'espressività plastica. È una specie di prete laico, che non ha quale scopo di diventare un ritrattista, cioè di creare immagini mimetiche. Per lo scultore, il corpo è ciò che potremmo chiamare il guscio dello spirito, e solo lo spirito si dimostrerà immortale. Da qui deriva il desiderio di Constantin Brâncuși di vedere le manifestazioni spirituali come elementi determinanti della rappresentazione, perché il valore non risiede nell'immagine fotografica dell'essere umano. Allo stesso modo, l'uccello non è un uccello perché ha piume, ali, becco e artigli, ma è un uccello per la sua capacità miracolosa di librarsi, di librarsi sopra tutto ciò che esiste. L'uccello è un uccello perché vola più alto, e per Brâncuși proprio il volo diventa l'oggetto della rappresentazione...
Ora correrò il rischio di tracciare un parallelo tra arte e chimica. Sappiamo tutti che in chimica esiste un fenomeno che i ricercatori hanno chiamato sublimazione. Analizzare le definizioni fornite dai dizionari esplicativi può sempre essere un buon punto di partenza per chiarire i termini. Ecco le definizioni fornite dai lessicografi:
sublimazióne s. f. [dal lat. tardo e mediev. sublimatio -onis]. – 1. a. L’azione, il fatto di sublimare, di rendere o di essere reso sublime... 2. In fisica e chimica, fenomeno consistente nel passaggio di una sostanza dallo stato solido allo stato aeriforme direttamente, senza passare per lo stato liquido (il fenomeno inverso prende il nome di brinamento, sebbene nell’uso corrente si usi spesso, anche per questo,il termine sublimazione) [7].
sublimare (ant. soblimare) v. tr. [dal lat. tardo sublimare, der. di sublimis «sublime»; il significato chimico viene dal lat. mediev. degli alchimisti]. – 1. a. ant. o raro. Elevare, innalzare a grandi onori, ad alte cariche: s. al principato, all’impero, alle supreme dignità. b. Esaltare, elevare spiritualmente, rendere sublime... 2. In fisica e chimica, far passare una sostanza dallo stato solido allo stato aeriforme mediante il processo detto sublimazione (v.). Con uso intr., riferito alla sostanza che subisce tale processo. [8].
Ecco ora anche le definizioni dei lessicografi romeni:
SUBLIMÁ, sublimez, vb. I. 1. Intranz. (Despre corpuri chimice) A trece (prin încălzire) din starea solidă direct în stare gazoasă, fără a mai trece prin starea lichidă. ♦ A trece dintr-o stare cristalină în stare de vapori și apoi din nou în stare de cristale, prin condensarea vaporilor. 2. Refl., tranz. și intranz. A (se) transpune pe un plan superior, în sentimente superioare. ♦ Fig. A (se) purifica, a (se) rafina. – Din fr. sublimer. [9]
SUBLIMARE, substantiv feminin. Acțiunea de a sublima și rezultatul ei. ♦ Deplasare a energiei izvorâte din porniri instinctuale și egoiste spre atingerea unor scopuri altruiste și spirituale. [< sublima]. [10]
Dal Vocabolario Treccani riteniamo per il verbo sublimare l’origine dal latino tardo sublimare, derivato di sublimis, aggettivo che nel latino significava: 1. sublime, elevato; 2. alto, aereo; sollevato in aria; 3. (figurato) illustre, nobile, glorioso; 4. di alta statura; sollevato in aria. Il significato che appartiene alla chimica proviene dal latino medievale ed è creato, probabilmente, dagli alchimisti.
Come si vede, il significato etimologico è di ordine morale e filosofico e si riferisce alla natura dell'uomo che oscilla tra l'istinto egoistico e l'ideale altruistico, di tipo spirituale, aspetto che viene sfumato nella definizione del lemma in romeno: spostamento di energia originato da partenze istintive ed egoistiche verso obiettivi altruistici e spirituali.
Brâncuși fu l'artista che intuì il fatto che rappresentare ciò che non si vede è molto più importante che riprodurre una realtà ridotta all'epidermide. Se l'uccello ha come tratto pertinente il suo volo, nell'uomo, prima di tutto, si combinano le misteriose valenze della capacità di «essere», di vivere e sentire l'amore, la sofferenza, il silenzio, la speranza di ascensione al cielo. L'essenza della vita sta nel miracolo della creazione, dell'uovo, un uovo che non solo deve essere visto, ma anche toccato per comprenderne la sua miracolosa perfezione.
Brâncuși sublima la realtà, purificandola da tutto ciò che non è essenziale, proprio come un chimico quando vuole raffinare una sostanza e ricorre al fenomeno della sublimazione. Attraverso la sublimazione, le impurità si separano dalla pura sostanza. Il fuoco, in fisica e chimica, è il principio attivo del processo di sublimazione. Ed è quello che ha fatto Constantin Brâncuși! Ha sublimato! Ha pulito la materia, l'ha spogliata dalle apparenze per rivelare il mistero sostanziale. Proprio per questo si ribella davanti alla Cappella Sistina: gli artisti, 500 anni dopo Michelangelo, volevano ancora eguagliarlo al livello mimetico! In realtà, Brâncuși apprezzava Michelangelo, così come stimava Rodin. Ma sapeva già che non avrebbe fatto come loro, perché il nostro vero valore di esseri umani sta in ciò che sentiamo e pensiamo, così come sapeva che all'ombra dei grandi alberi cresce solo l'erba piccola.
Possiamo pure parlare, in conclusione, delle correnti artistiche a cui Brâncuși era imparentato. Basti citarne alcuni: Impressionismo, Cubismo, Surrealismo, Dadaismo, ecc., e l'elenco potrebbe andare avanti per un'intera pagina. Per il nostro percorso argomentativo, dobbiamo anche ricordare ciò che dicevano i dadaisti: l'arte di essere dada non è essere dada. Brâncuși non ha mai fatto parte di una corrente artistica, anche se ha frequentato l'avanguardia. Mi permetterei di immaginare una corrente artistica che abbia Brâncuși come unico rappresentante, perché l'unicità dell'artista lo rende possibile. E chiamerei questo orientamento sublimalismo, non per il desiderio di inserire l'artista in una tendenza, ma piuttosto per il desiderio di spiegare ai giovani chi era Brâncuși e come dovremmo intendere la sua opera. Per me Brâncuși è SUBLIME nella scultura che ha realizzato, una scultura che invita alla meditazione, così come è sublime nel modo in cui spiega le sue sculture: «Chi dice delle mie opere che sono astratte è un imbecille; quello che chiamano astratto è il realismo più puro, perché la realtà non è rappresentata dalla forma esterna, ma dall'idea che sta dietro, dall'essenza delle cose.» (n.tr.) [11]
Sublime, sublimazione, sublimalismo sono parole che possono metterci in condizione di avvicinarci all'opera dello scultore rumeno da una nuova prospettiva, che può essere compresa più facilmente a partire da quella che i greci chiamavano mimesi, per poi appellarsi alla teoria dell'illusione di illusioni di Platone e, più tardi, agli illustri rappresentanti del Rinascimento italiano. Questo è, secondo il mio parere, l'unico modo per comprendere e spiegare il fenomeno della sublimazione nell'opera di Brâncuși, che fa delle sculture e della bottega del grande scultore qualcosa di prettamente romeno, ma universalmente riconosciuto.
George Dan Istrate
(n. 4, aprile 2023, anno XII)
NOTE
[1] https://www.treccani.it/vocabolario/mimesi
[2] La sezione aurea o rapporto aureo o numero aureo o costante di Fidia o proporzione divina, nell'ambito delle arti figurative e della matematica, indica il numero irrazionale 1,6180339887... ,ottenuto effettuando il rapporto fra due lunghezze disuguali, che può essere incontrato nelle circostanze più sorprendenti; La sezione aurea viene indicata dalla lettera greca Φ (phi maiuscolo) o anche φ (phi minuscolo), che si leggono "fi Cf. https://it.wikipedia.org/wiki/Sezione_aurea
[3] Maddalena Mazzocut-Mis, Mimesis. Imitazione e costruzione della realtà nelle arti figurative in Breve storia dell’estetica, Milano, Mondadori, 2003, pp. 2-4 (https://www.fondazionesancarlo.it/conferenza/mimesis/ )
[4] Pavel Șușară, Brâncuși, un sculptor de la Răsărit, București, Editura Monitorul Oficial R.A., 2020.
[4]https://historia.ro/sectiune/portret/viata-infinitulu-constantin-brancusi-dupa-ce-ai-574604.html
[5] Si veda anche Elizabeth Bouleanu, „Prinţesa X“, controversata operă în formă de falus a lui Brâncuşi, a fost inspirată de o celebră prinţesă frigidă, înAdevărul,25/02/2017, accesat în 06/12/2022
[6] Matei Stircea Crăciun, Brâncuși – Domnișoara Pogany, 1912 Rodin – Je suis belle, 1882: «La Domnișoara Pogany II (1919) și Domnișoara Pogany III (1931), sprâncenele înalte înscriu două enorme arce de cerc ce descind alert spre vârful nasului ascuțit, aidoma unui cioc de pasăre. În variantele ultime, artistul înlocuiește ochii clepsidrici ai Domnișoarei Pogany I cu desenul pur al unor pleoape închise, uimitor de curbate în sus, convexe ca la păsări – care, și atunci când dorm, par să dialogheze cu înaltul. Licența anatomică afirmă continuitatea ideatică între motivul Domnișoarei Pogany și motivul Păsărilor în văzduh. Braţele contopite unul cu altul, un fus zvelt.» https://www.contributors.ro/brancusi-domnisoara-pogany-1912-rodin-je-suis-belle-1882/, consultato il 06/12/2022
[7] https://www.treccani.it/vocabolario/sublimazione, consultato il 06/12/2022
[8] https://www.treccani.it/vocabolario/sublimare/, consultato il 06/12/2022
[9] https://dexonline.ro/definitie/sublima, consultato il 06/12/2022
[10] https://dexonline.ro/definitie/sublimare, consultato il 06/12/2022
[11] https://ro.pinterest.com/pin/206039751672250553/, consultato il 06/12/2022
|
|