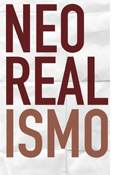|
|
Letteratura ed engagement: Il Neorealismo
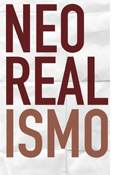 Non è facile dare una definizione del Neorealismo dato che non ha dato luogo a una poetica ben precisa. Diciamo che è stata una corrente letteraria, cinematografica e artistica compresa tra gli anni della Resistenza e la metà degli anni Cinquanta, all’incirca. Italo Calvino, nella Prefazione del 1964 al suo primo romanzo Il sentiero dei nidi di ragno, affermò che il Neorealismo Non è facile dare una definizione del Neorealismo dato che non ha dato luogo a una poetica ben precisa. Diciamo che è stata una corrente letteraria, cinematografica e artistica compresa tra gli anni della Resistenza e la metà degli anni Cinquanta, all’incirca. Italo Calvino, nella Prefazione del 1964 al suo primo romanzo Il sentiero dei nidi di ragno, affermò che il Neorealismo
non fu una scuola, ma un insieme di voci, in gran parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse Italie, specialmente delle Italie fino allora più sconosciute dalla letteratura. [1]
E Giancarlo Ferretti così lo ha definito:
Il neorealismo fu […] un vasto movimento di idee dalle componenti ibride e dai contorni indistinti, comprende personalità e correnti ed esperienze diverse e sempre in un orizzonte essenzialmente umanistico [2].
Il ritorno alla realtà si era già verificato alla fine degli anni Venti dopo gli sperimentalismi dell’avanguardia e il ritorno all’ordine imposto dal regime fascista, ma non si può confondere il neorealismo con il realismo che a partire dalla fine degli anni Venti e per tutti gli anni Trenta ha contrassegnato la letteratura italiana e la narrativa in particolare, anche se romanzi come Fontamara di Ignazio Silone e Tre operai di Carlo Bernari hanno senza dubbio anticipato alcuni caratteri del neorealismo. In mezzo ci sono state la guerra e la Resistenza che hanno rappresentato un momento di svolta e di presa di coscienza dei problemi politici, sociali ed economici delle varie realtà del nostro paese, specialmente da parte di quegli intellettuali che vi hanno preso parte. Come ha affermato Giaime Pintor «Senza la guerra io sarei rimasto un intellettuale con interessi prevalentemente letterari» e proseguiva dicendo che era ormai necessario come intellettuale rinunciare ai propri privilegi e collaborare «alla liberazione di tutti», cioè partecipare direttamente alla lotta contro il nazi-fascismo [3]. E questa sua affermazione trova riscontro in molti altri intellettuali della «generazione degli anni difficili» [4]. Iniziava così la stagione dell’impegno in cui si facevano i conti con il passato e si lanciavano nuove parole d’ordine. Bisogna però considerare che nella letteratura, nel cinema e nella pittura del neorealismo non c’è solo un bisogno di tornare alla realtà, ma anche il proposito di denuncia delle ingiustizie sociali, della condizione di miseria delle classi subalterne, dell’arretratezza del nostro paese e al tempo stesso c’è la speranza di un profondo rinnovamento sociale, economico e politico. Infatti, come ha sottolineato Carlo Salinari:
Il neorealismo in Italia è sorto […] come espressione di una profonda frattura storica, quella crisi che fra il 40 e il 45 con la guerra e la lotta antifascista, investì, sconvolse fino alle radici e cambiò il volto dell’intera società italiana. Il neorealismo si nutrì, quindi, innanzitutto di un nuovo modo di guardare il mondo, di una morale e di un’ideologia nuove che erano proprie della rivoluzione antifascista. In esse vi era la consapevolezza del fallimento della vecchia classe dirigente e del posto che, per la prima volta nella storia, si erano conquistate sulla scena della società civile le masse popolari [5].
Esso quindi affonda le radici nel clima della resistenza e dell’immediato dopoguerra, nell’illusione e negli ideali di profondo rinnovamento nati in quel periodo. Infatti l’opera neorealista presuppone l’impegno dello scrittore, del cineasta, del pittore al fianco delle classi subalterne e alla loro lotta per il riscatto e l’emancipazione sociale. Tra le opere nate durante la Resistenza bisogna ricordare Uomini e no di Elio Vittorini, scritta a caldo durante gli eventi e pubblicato nel 1944 che anticipa la svolta che si realizzerà durante l’ultimo anno di guerra civile e che esprime la partecipazione diretta dello scrittore siciliano e di molti intellettuali alla lotta partigiana contro il nazi-fascismo. Da questo punto di vista il 25 aprile 1945 è una data importantissima per la storia del nostro paese che segna l’inizio di una nuova fase politica e culturale: dopo tante sofferenze e atrocità gli Italiani finalmente riconquistarono la libertà e vennero gettate le basi del sistema democratico. In un mondo distrutto dalla guerra bisognava ricostruire tutto, non solo «le case e le industrie, ma [anche] gli animi e la società. […] In questo lavoro, che è ricchezza comune, s’inserisce come elemento essenziale e vitale l’attività degli intellettuali» (Editoriale del primo numero della rivista «Società»).
L’esperienza della guerra e della resistenza al fascismo e al nazismo, le istanze rivoluzionarie legate alla lotta armata del popolo, le speranze di profondi cambiamenti nella struttura sociale del nostro paese imposero nel dopoguerra un’esigenza di radicale rinnovamento della nostra letteratura, che, per quanto avvertita con urgenza e con entusiasmo, restò molto spesso velleitaria nei risultati e confusa nelle premesse teoriche. […] Sul piano delle strutture narrative, il neorealismo postbellico si differenzia da quello degli anni Trenta per una maggiore (e spesso invadente) preoccupazione ideologica che si traduce nel recupero di una tradizione romantica e veristica e nel tentativo di ripristinare un modello di romanzo tradizionale, che in realtà i realisti degli anni Trenta (a partire da Vittorini, che sarà considerato un maestro del nuovo corso letterario) avevano dall’interno corroso e in gran parte già liquidato [6].
Questa affermazione coglie il senso della frattura causata dalla guerra e dalla resistenza, e cioè l’inizio dell’impegno politico da parte degli intellettuali e dal bisogno di voltar pagina e di assumere una posizione di distacco critico rispetto al ventennio fascista e di mettere in discussione l’atteggiamento di condivisione della maggior parte degli intellettuali rispetto al regime di Mussolini. In quel clima particolare nacquero numerose riviste che svolsero un ruolo molto importante e che parteciparono al processo di rinnovamento politico, culturale e letterario, tra cui «Società», già ricordata, «Il Ponte» di Piero Calamandrei e «Il Politecnico» di Vittorini.
In quel contesto l’azione dei partiti di massa ebbe un ruolo sempre più grande in Italia e nei paesi occidentali. Ovviamente anche la letteratura risentì di quel clima di rinnovamento e anche gli scrittori condivisero l’impegno e la partecipazione alle illusioni e alle speranze del dopoguerra. I modelli a cui si ispirarono i protagonisti del neorealismo sono quelli del realismo ottocentesco e in particolare l’opera di Giovanni Verga. Come ha scritto ancora Calvino nella nota Prefazione alla terza edizione de Il sentiero dei nidi di ragno (1964):
Ci eravamo fatta una linea, ossia una specie di triangolo: I Malavoglia, Conversazione in Sicilia, Paesi tuoi, da cui partire, ognuno sulla base del proprio lessico locale e del proprio paesaggio [7].
Il compito che si ponevano gli scrittori del neorealismo era quello di raccontare la realtà così com’era e con un linguaggio realistico, popolare, molto vicino al parlato e ricco di inflessioni dialettali. I temi trattati sono quelli della lotta partigiana, della deportazione e della società del dopoguerra. In quel periodo molti autori del neorealismo aderirono al Partito comunista che sotto la guida di Togliatti ebbe modo di esercitare una sorta di egemonia politica e culturale, a cui pochi si sottrassero, tra cui bisogna fare almeno il nome di Franco Fortini che sin dagli anni della guerra fredda criticò da sinistra il populismo, lo storicismo e lo stalinismo della sinistra ufficiale. Da questo punto di vista la diffusione del marxismo e la pubblicazione delle opere di Sartre e di Camus, di alcune opere di Zdanov, delle Lettere (1947) e dei Quaderni del carcere (1958-1952) di Antonio Gramsci e dei primi libri di Lukács influenzarono profondamente la coscienza e l’operato degli intellettuali di sinistra. A partire dalla fine degli anni Quaranta, in seguito alla sconfitta politica del Fronte popolare (1948) e ai primi segnali della guerra fredda, subentra un sentimento di delusione dovuto al mancato rinnovamento sociale e politico e al processo di restaurazione politica e quindi viene meno quella spinta propulsiva tipica dell’immediato dopoguerra e gli ideali che avevano ispirato il neorealismo cominciano a esaurirsi e a essere superati. Tuttavia bisogna considerare che alcuni autori neorealisti sono stati in qualche modo influenzati dal populismo e dalla precettistica del «realismo socialista» presentando eroi positivi, per lo più di estrazione popolare o piccolo-borghesi. È il caso di Vasco Pratolini che con il suo romanzo Metello ha fatto tanto discutere i critici marxisti e che nell’ambito della letteratura neorealista ha rappresentato un caso abbastanza eclatante. Inoltre alcuni autori come Cassola e Fenoglio continuano a richiamarsi a questi valori e ad ambientare le loro opere anche negli anni successivi nel clima della resistenza e delle lotte sociali del dopoguerra. Ma già nella prima metà degli anni Cinquanta si manifesta in maniera sempre più crescente da parte degli autori più attenti alle trasformazioni economiche e sociali la necessità di andare oltre il neorealismo, cioè di esprimere una nuova sensibilità e un nuovo modo di fare letteratura. È il caso, per esempio, di autori come Pasolini e i suoi sodali di «Officina», oppure di Sanguineti e dei giovani della nuova avanguardia, o ancora di Italo Calvino che nel 1957 pubblica La speculazione edilizia e di Ottiero Ottieri di cui nello stesso anno esce il romanzo Tempi stretti che ha anticipato il filone della cosiddetta «Letteratura industriale».
Sulla letteratura neorealista pesa ancora la condanna di alcuni critici marxisti, in particolare di Alberto Asor Rosa che in seguito correggerà in parte il suo giudizio [8]. Ma al di là dei limiti, in alcuni casi abbastanza evidenti, la letteratura neorealista ha rappresentato, nel bene e nel male, una pagina abbastanza singolare della nostra storia letteraria del secondo Novecento.
Giuseppe Muraca
(n. 9, settembre 2025, anno XV)
NOTE
[1] Italo Calvino, Prefazione a I sentieri dei nidi di ragno, Einaudi, Torino 1964, p. 5.
[2] Giancarlo Ferretti, Introduzione al neorealismo, Editori Riuniti, Roma 1974, p.8.
[3] Id., Il sangue d’Europa, Einaudi, Torino 1965.
[4] AA. VV., La generazione degli anni difficili, Laterza, Bari 1962.
[5] Carlo Salinari, Preludio e fine del realismo in Italia, Morano, Napoli 1967, p. 39.
[6] Romano Luperini, in R. Luperini e E. Melfi, Neorealismo, neodecadentismo, avanguardie, Letteratura italiana Laterza, a c. di Carlo Muscetta, Laterza, Roma-Bari 1980, p. 12.
[7] Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno, cit.
[8] Ci riferiamo al suo libro Scrittori e popolo, Samonà e Savelli, Roma 1965.
|
|