









|
|
Letteratura mediterranea. Un percorso antologico possibile?
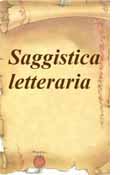 Introduzione Introduzione
Il Mediterraneo oggi più che mai è tornato a occupare uno spazio proprio. Crocevia di culture apparentemente vicine, ma che al proprio interno vivono lotte e contrasti socioculturali di una certa rilevanza, tutto ciò che appartiene alla sfera mediterranea da sempre affascina: i territori che si affacciano sul Mediterraneo rappresentano i punti di partenza di tanti viaggiatori alla ricerca di nuovi mondi: evasione dalla propria terra natia e il bisogno di cercare un altrove diverso. Tra antica nobiltà e un pittoresco popolare, il mare trascina, allontana, travolge, divide le terre, gli esseri, le culture e le appartenenze. Ma è anche un mare salvifico che unisce, riappacifica, consola, rassicura, protegge e proietta a sua volta verso orizzonti nuovi. Il Mediterraneo è testimone di una storia ben consolidata che include guerre, crociate, conquiste, ribellioni, battaglie; è un mare che rivive tutti i giorni attraverso una sincronia costante che lo erge a protagonista: immigrazioni, sbarchi, lotte, eventi cruciali di vita e di morte, speranze e illusioni, che spesso confondono e stravolgono tutti coloro che si trovano “nel mezzo”. Il Mediterraneo, quindi, riveste un’importanza fondamentale nella nostra vita. Se ne parla dappertutto. Come evento di cronaca, come spazio di confine e di sconfinamento, come orizzonte socioculturale in evoluzione, passato da seppellire, o crocevia indispensabile del futuro. Analizzando più attentamente la configurazione di questo mare troviamo che è formato da un insieme di mari:il mar Alboran, il Golfo di Lione, il Tirreno, lo Ionio, il mar Egeo, l’Adriatico, ognuno con caratteristiche proprie.
Questo aspetto onnicomprensivo del Mediterraneo apre a interrogativi su possibili percorsi specifici all’interno dello studio della letteratura italiana ed europea e sulla possibilità che possa aprirsi a uno spazio più inclusivo, soprattutto da un punto di vista antologico. Un’indagine recente riguardante la ricezione antologica della letteratura mediterranea offerta agli studenti ha dato, purtroppo esiti scarsi. In un momento storico, culturale e sociale in cui abbiamo assistito a un aumento esponenziale dei fenomeni di immigrazione e nello stesso tempo di emigrazione giovanile verso tanti luoghi del e per il Mediterraneo, non si rilevano percorsi specifici dedicati alla letteratura mediterranea, o itinerari dedicati a scrittori che in qualche modo abbiamo affrontato il tema, se non sporadiche inclusioni poetiche. Le uniche eccezioni antologiche riguardano Eugenio Montale e Albert Camus, le cui poesie e racconti richiamano il paesaggio su cui si innescano tematiche relative al Mediterraneo.
Ciò sorprende.
Il Mediterraneo è fonte di ispirazione continua: l’infinità del mare e l’assoluto bisogno di condivisione si scontrano spesso con un forte senso di solitudine e di isolamento: la bellezza e la maestosità del paesaggio marino portano sullo sfondo gli aspetti più tragici e impervi della vita stessa. Ed è lo stesso confine tra vita e morte a farsi labile quando tornano agli occhi le tante immagini drammatiche di cronaca.
Il Mediterraneo secondo alcuni autori
Sono soprattutto gli autori stranieri a offrire diverse interpretazioni sul Mediterraneo nei propri racconti. René Fregni [1] ci parla dei vari volti di questo mare: c’è chi viaggia nel Mediterraneo, chi lo osserva da terra, chi lo ricerca come protezione, chi lo insegue come rifugio sicuro. Chi lo ha combattuto, si adagia consapevole perché le onde sulla battigia hanno cancellato tracce lasciate dai piedi in fuga, come in una sorta di complicità quasi materna. Molte sono anche le fiabe e i racconti mitici che traggono ispirazione dal Mediterraneo. Come madre immortale il mare appare gioiello e centro dell’universo. È lo stesso Fregni a identificarsi nel novero degli scrittori mediterranei autodefinendosi ‘uomo del Mediterraneo’ perché «tutti i sensi, tutta la sensibilità e tutti i suoi ricordi sono mediterranei». [2] Egli riserva un posto speciale all’immagine di un ulivo testimone del passaggio del tempo e simbolo di eternità.
Alcuni autori di storie che appartengono al Mediterraneo hanno vissuto questo mare fin da giovani. Hanna Mina [3] è considerato il più grande narratore arabo contemporaneo sul mare. Il mare è l’origine e il conflitto con le proprie origini. Secondo lo scrittore, la vita è una continua lotta sul mare e sulla terra perché il connubio parte dal legame con la propria nave, la ‘dimora indissolubile’, archetipo della vita del navigatore. L’attesa di un nuovo imbarco rappresenta l’obiettivo dell’uomo di mare; è lo stesso a credere nel Mediterraneo come nuova fonte ispiratrice. Ciò che distingue il mar Mediterraneo da altri mari è che sulle sue rive si sono insediate molte civiltà diverse che appartengono tanto all’Oriente quanto all’Occidente. E qui entrano le responsabilità di coloro che governano gli Stati che si affacciano sul Mediterraneo. L’essere uno scrittore arabo offre la possibilità di indagare i due mondi: quello del mare e quello del deserto. Ciò rinvia agli Irati flutti di Auden: «Il mare è la situazione reale e il viaggio è la vera condizione dell’uomo. Il mare è il luogo in cui avvengono gli eventi decisivi, i momenti di eterna scelta, la tentazione, la caduta e la redenzione». [4] Auden parte da un sogno contenuto nel Preludio (Libro V) di William Wordsworth, in cui immagina l’incontro con una figura che sembra palesarsi quale mistura tra un arabo del deserto e Don Chisciotte, con una pietra in una mano, e una conchiglia nell’altra. Da questo frammento, Auden fa derivare tre coppie di simboli, fondamentali per comprendere appieno il significato dell’opposizione tra il mare e il deserto: la pietra della geometria astratta e la conchiglia dell’immaginazione. Auden non cita chiaramente il Mediterraneo, ma evidenzia la frattura che si verifica tra la terra (identificata nelle devastanti mura della città) e il mare. Sono per Auden due entità ben distinte.
È il viaggio a rappresentare una geometria di allegorie, tipologie, parabole e simboli che possono incontrarsi quanto provocare una catastrofe. Terra e mare per Auden sono divisibili.
Invece, secondo la scrittrice Costanza Ferrini «il Mediterraneo ha dato grandi filosofi, pensatori, creatori; sulle sue rive, sia orientali che occidentali, si generano ancora creatori che credono nella libertà, nella bellezza, nel progresso e nel bene, a eccezione di alcuni scrittori israeliani che si dimostrano contrari a questi principi, contro quindi una visione pacifica nel Medioriente». [5] L’autrice pensa che la letteratura mediterranea possa aiutare a costruire un Mediterraneo al di là di ogni frattura.
Maurizio Maggioni [6] valorizza Genova come il più grande porto del Mediterraneo negli anni Trenta, un ancoraggio senza confini, luogo di transito per navi e uomini operosi. Il Mediterraneo è osservato nella sua dimensione anche statica, un’entità occupante un altrove dove risiedono i poteri dominanti di chi regola i cammini del mondo e il loro corso. Maggioni offre una visione critica ponendo l’attenzione anche sul verificarsi di eventi che riguardano il Mediterraneo, frutto di calcoli di interesse e speculazione portati avanti da governi autoritari e solo in apparenza democratici.
Tra le interpretazioni sul mare, quella spirituale ci riporta all’antico e alle letture bibliche. Il credente di qualsiasi etnia si rivolge al proprio Dio nella quotidianità caratterizzata dal bisogno.
«Nel Mediterraneo oltre all’acciuga, al pane, all’olio e al vino c’è Dio. Il Dio dei giudei, il Dio dei musulmani e il Dio dei Cristiani». [7]
I mille volti del Mediterraneo sono il risultato di una diacronia affascinante ed eterna: secoli di vita, infatti, non hanno cambiato le peculiarità più importanti: così attraente e fluido, il mare si manifesta anche misterioso e magmatico; il mar Mediterraneo rimane un’entità vivente che trascina con sé la meraviglia dell’esistenza come le tragedie più cupe e imprevedibili. È un mare che racchiude una tradizione storica da cui deriva il nostro vivere odierno.
«Il Mediterraneo è diverso e multiplo, caotico e limpido, consolante e tragico; è il mare nostrum dei Romani che in arabo sono i bizantini, è il mare degli Elleni, ma è anche Mare Intermedio e Bianco degli arabi, ma è anche quello dei Corsari, dei Barbarossa […]. Il Mediterraneo, il nostro Mare per me sono i miei: la mia famiglia, le mie madri, più poetesse di tutti i pastori insulari, i miei padri diritti e degni, forti, ma dolci, instancabili narratori del vento e dell’onda, del sole e del suo inestinguibile bruciare, della luna e delle sue lenzuola di gelsomino e seta grezza. È la nostra barca a remi e a vela, minuziosamente rappezzata César, e ricolma quotidianamente di dentici e cernie». [8]
Uno sguardo poetico al Mediterraneo: Albert Camus ed Eugenio Montale
Il Mediterraneo è all’origine del pensiero di Albert Camus e testimone della vita dello scrittore; le coste mediterranee dell'Africa rappresentano, infatti, i luoghi che hanno accompagnato il poeta nelle varie fasi della sua esistenza. Camus concentra la sua ricerca della misura attraverso un dialogo tra un mare considerato come essere fluido, infinitamente mutevole e la terra. «Il percorso camusiano tra il sentire e il pensare presenta una compattezza tale che si può parlare in Camus di vocazione mediterranea e di osmosi con lo spirito mediterraneo. La sua mediterraneità, ovviamente, affonda le radici nella patria algerina, nel cuore di una natura mediterranea rigogliosa, generosa, possente che esalta i sensi, un luogo privilegiato dove il sentire si fa acuto e acquista una dimensione spirituale. Camus attinge ad alcuni elementi della natura: ad esempio ombra e sole si coniugano col concetto di tempo; l’ombra è ineliminabile perché altrimenti il sole brucia e consuma. In fondo si tratta della dialettica della vita stessa. Spesso nelle sue liriche il poeta celebra l’antica bellezza greca messa in contrapposizione con la valorizzazione eroica bellica romana.
Il Mediterraneo rimane il mare bianco di mezzo, ovvero il luogo in cui cercare e ritrovare sé stessi. Non è un’impresa semplice per il poeta perché se il mare è considerato un enigma, più difficile risulta essere poi lo svelamento. Il bagno nelle acque del Mediterraneo è per Camus, la consacrazione del connubio terra mare.
Anche qui so che non mi avvicinerò mai abbastanza al mondo. Ho bisogno di essere nudo e di tuffarmi nel mare, ancora tutto profumato dall'essenza della terra e lavare questa in quello. [9]
La seguente poesia di Albert Camus introduce il lettore nell’immagine descrittiva di un Mediterraneo indefinito come luogo, ma preciso nella propria temporalità: il mattino appare quasi offuscato dallo sguardo assente di chi si affaccia alla finestra; sono giovani donne che iniziano il loro affaccendarsi mattutino; sono uomini di mare che scrutano l’orizzonte. È un mattino che man mano si dipana e offre lo spettacolo degli smalti marini riecheggiando una latinità che caratterizza i popoli di questo mare.
Mediterraneo
Allo sguardo vuoto delle finestre, il mattino
con tutti i suoi denti che ha azzurri e brillanti,
gialli, verdi e rossi, ai balconi si cullano le tende.
Giovani donne con le braccia nude stendono i panni.
Un uomo, a una finestra, col binocolo in mano.
Mattino chiaro dagli smalti marini
perla latina dai bagliori liliali:
Mediterraneo.
Il mezzogiorno è scandito da una figura retorica suggestiva:il mare immobile e caloroso èprotagonista e accoglie senza domandare. È testimone del tempo, spirito latino e antichità, ed è portatore di verità celate e di confini non oltrepassati; nel mare dolore e morte si affiancano a trionfi ed esaltazioni. Le voci silenti sono molteplici quante le richieste non ascoltate e quanto le promesse non mantenute. Altra immagine suggestiva è quella del mare enorme e leggero, un mare rassicurante intriso di passato e di mediterraneità. Esso rivela eternità e può travolgere in modo vertiginoso, morire e poi rinascere come una fenice, ma allo stesso tempo rimanere un mare resiliente e magico.
Mezzogiorno sul mare immobile e caloroso:
mi accetta senza grida: un silenzio e un sorriso.
Spirito latino, Antichità, un velo di pudore sul grido torturato!
Vita latina che conosce i suoi limiti,
rassicurante passato, oh! Mediterraneo!
Sulle tue rive trionfano ancora voci ormai taciute,
che dicono di sì perché ti hanno negato!
Enorme e leggero,
assicuri e soddisfi e mormori l'eternità dei tuoi minuti,
oh! Mediterraneo! E il miracolo della tua storia,
lo racchiudi tutto quanto
nell'esplosione del tuo sorriso.
Inalienabile vergine, a ogni ora la sua natura si concepisce
in nature già formate.
La sua vita rinasce sui nostri dolori.
Prende il volo! E da quali ceneri, luminosa fenice!
L’apostrofe iniziale Mediterraneo introduce l’appartenenza a un mondo pronto ad attenderci.
L’uomo è indiscutibilmente legato alla natura; l’universo rappresenta tutte le categorie del genere umano: gli uomini hanno bisogno di una maschera e si trovano a recitare parti della commedia umana perché la natura è vera e lo confermano gli scritti di Ovidio, Virgilio e Melibeo. Il Mediterraneo è dei greci, ma i romani hanno tentato di attribuire un carattere sostanzialmente proprio. Il mare è così diventato quello spazio biondo, pergolato e azzurro dove oscilla la certezza, una sicurezza che l’uomo crede di possedere, mentre invece riesce solo ad accarezzarla.
Mediterraneo! Il tuo mondo è a misura nostra
L'uomo all'albero si unisce e in due l'Universo si recita la commedia
in costume del Numero d'Oro dall'immensa semplicità senza scosse
sgorga la pienezza, oh! natura che non fai salti!
Dall'olivo al Mantovano, dalla pecora al pastore,
solo l'innominabile comunione dell'immobilità.
Virgilio cinge l'albero, Melibeo va al pascolo.
Mediterraneo!
Biondo pergolato azzurro dove dondola la certezza,
così vicina, oh! così vicina alle nostre mani,
che i nostri occhi l'hanno accarezzata e le dita l'hanno lasciata.
La ciclicità della sera accoglie l’uomo che rientra. Varcata la porta vespertina, i pensieri ritornano e si condensano in ombre e istanti di felicità. È in quei momenti che l’uomo sente di avere la possibilità di riflettere sui propri sbagli, certo di avere una proroga. Il mare è custode di cimiteri eterni dove la vita non è infinita, ma dipende da qualcosa o qualcuno che volteggia nella maschera immobile eindifferente nella scelta del predestinato: casualità ed ebbrezza di luce sono variabili anche tragiche della vita del mare stesso. Ma le tante incertezze si sposano alle infinite possibilità di riscatto. È una terra madre che apre le braccia ai propri figli quando sono impazienti di scoprire fino in fondo le meraviglie della vita.
Nella sera incombente con la giacca sulle spalle, tiene la porta aperta,
lambito dai riflessi della fiamma, l'uomo entra nella sua felicità
si dissolve nell'ombra.
Così questi uomini rientreranno in questa terra, certi di avere una proroga,
più sfiniti che sazi della felicità di aver saputo.
Nei cimiteri marini c'è solo eternità.
Lì, l'infinito si stanca ai funebri fusi.
La terra latina non trema. E come il tizzone detonante volteggia nella maschera immobile
di un cerchio,
indifferente, appare l'inaccessibile ebbrezza della luce.
Ma ai suoi figli questa terra apre le braccia e fa carne della loro carne,
e questi – sazi, si riempiono del segreto sapore di questa
trasformazione - lentamente la assaporano a mano a mano che la scoprono.
Il Mediterraneo mostra tutti i colori e le sfumature lucenti del proprio volto. Rappresenta l’uomo nella sua integrità, completo o scintillio d’armi, nel proprio connubio di corpo e spirito. Nell’animo del Mediterraneo è quindi racchiusa l’umanità intera e la vita ciclica di ognuno: si celebrano antico e presente, solitudine e miseria. Solamente la morte, secondo Camus, potrà rendere l’uomo finalmente puro e libero.
E presto, ancora e poi, i denti, i denti azzurri e brillanti
luce! Luce! L'uomo si completa in lei.
Polvere di sole, scintillio d'armi,
principio essenziale dei corpi e dello spirito,
in te i mondi si bruniscono e si umanizzano,
in te ci rendiamo e i nostri dolori si sublimano,
insistente antichità
Mediterraneo, oh! Mare Mediterraneo!
Soli, nudi, senza segreti, i tuoi figli attendono la morte.
La morte te li renderà, puri, finalmente puri.
Per Camus il Mediterraneo non è attribuibile al mito dell’età dell’oro, ovvero rinviabile a quel periodo mitico in cui regnavano gioia, ordine e ricchezza quando Esiodo celebrava questa età come l’età di un’aurea stirpe di uomini mortali dai quali discesero gli dèi dall’Olimpo. Oggi il Mediterraneo, secondo Camus, non può essere diviso tra mortalità e religiosità divina, ma deve rappresentare sempre un luogo di espressione vitale e di ricchezza nel suo essere variegato. È un mare che guarda a Oriente, soprattutto per ciò che rappresenta oggi, perché sottolinea una vitalità che nasce dalla dialettica dei contrari. È la sfida dell’esistenza nel quotidiano vivere di cui tutti dobbiamo rendere conto.
Mediterraneo di Eugenio Montale
La seguente poesia è invece di Eugenio Montale e appartiene al poemetto Mediterraneo; è inclusa al centro della raccolta Ossi di seppia. Lo scrittore rimane affascinato dalla voce del mare: le onde urtano ripetutamente contro la costa per poi sciogliersi; questo movimento rinvia ai rintocchi costanti delle campane. In ascolto del mare e delle innumerevoli sfumature sonore, Montale contempla un paesaggio che ricorda la casa natia di Monterosso nelle Cinque Terre, dove il poeta trascorreva da fanciullo le vacanze estive. Il ricordo si intensifica grazie al connubio marino: il movimento incessante delle onde è simile al disordine del cuore e l’immensità del mare si sposa con le sfumature delle onde, calme e basse, agitate e alte.
Il mare rappresenta la profondità dell’animo umano.
L’apostrofe iniziale è di notevole impatto emotivo per lo scrittore. Antico racchiude tutta la storia del nostro pianeta, in un passaggio ciclico dove diacronia e sincronia diventano qualcosa di interscambiabile. Si tratta di un mare che sussurra, parla, urla tutta la propria rabbia interiore quando le bocche si schiudono come verdi campane e si ributtano indietro e si disciolgono. Emerge una visione del mare percepita attraverso i sensi e le personificazioni (rumore - voce; onde - bocche; movimento marino delle onde -si schiudono- si ributtano- e si disciolgono) in un crescendo poetico suggestivo.
Antico, sono ubriacato dalla voce
ch’esce dalle tue bocche quando si schiudono
come verdi campane e si ributtano
indietro e si disciolgono.
Il ricordo della propria casa natia è associato a un’estate quanto lontana nel tempo, quanto invece vicina nella propria mente. È un paese che non si dimentica, nonostante il sole cocente, l’aria fosca e il turbinio di zanzare. Tutto rimane immutato. Il mare è sempre lì quasi a impietrire chi si aspetta un altro movimento, un’altra possibile vita. Si tratta di un mare che spaventa, inaridisce, rende inermi le persone, le ammonisce attraverso la propria ingombrante presenza.
La casa delle mie estati lontane,
t’era accanto, lo sai,
là nel paese dove il sole cuoce
e annuvolano l’aria le zanzare.
Come allora, oggi la tua presenza impietro,
mare, ma non più degno
mi credo del solenne ammonimento
del tuo respiro.
Ma è solo apparenza. È un mare che cerca unione e complicità. Il poeta sente che il proprio battito fa parte di un disegno più grande. La legge del mare è eterna: immenso, differente e immobile nei secoli, il mare è in grado di liberarsi da ogni impurità sbattendo sugli scogli e lasciando alla deriva tutto il superfluo: i sugheri, le alghe e le asterie ovvero le inutili macerie del proprio abisso non sono che le miserie umane di cui l’uomo dovrebbe liberarsi per essere davvero in sintonia con la natura e con se stesso. Montale presenta una lirica di notevole impianto narrativo e riflessivo che gravita attorno al rapporto tra l’uomo e il mare, allegoria della condizione esistenziale dello scrittore ligure.
Tu m’hai detto primo
che il piccino fermento
del mio cuore non era che un momento
del tuo; che mi era in fondo
la tua legge rischiosa: esser vasto e diverso
e insieme fisso: e svuotarsi così d’ogni lordura
come tu fai che sbatti sulle sponde
tra sugheri alghe asterie
le inutili macerie del tuo abisso.
Per Camus il mare è visto dall’‘interno’, da chi si affaccia ai balconi per iniziare una nuova giornata, dalle donne operose, protese ai ‘bagliori liliali’del Mediterraneo che attendono i rientri degli uomini È un mare ‘vergine’dove‘a ogni ora la natura si concepisce’. Ciò rinvia all’immagine lucreziana della nave da cui siamo trasportati anche quando è immobile all’ormeggio e si creda proceda oltre. Ed è da lì che fuggono colline e pianure per raggiungere la terra. Si tratta di un mare che racchiude secoli di storia, di religiosità, un mare testimone di tragedie che custodisce la vita interrotta di coloro che cercavano l’essenza di una libertà negata. Se solo la morte ha potuto rendere questi uomini liberi la poesia di Montale apre ad altre ipotesi interpretative.
Il Mediterraneo è un luogo conosciuto per il poeta; i ricordi sono quelli dell’infanzia e il sole cocente estivo si inchina all’autorità di un mare che sorprende tutti i giorni. La giocosità infantile determina il minuscolo fermento dal quale batte un cuore pulsante molto forte. È il cuore che si misura con l’immensità del mare: gli scenari vastissimi, i paesaggi scenografici sono in grado di suscitare in ciascuno vibranti emozioni al tatto. Il mare ha quindi un indiscutibile ruolo da protagonista che Montale, cresciuto sulla riviera ligure, pare conoscere in ogni più intima sfumatura. Il mare è una presenza sempre mutevole e capace di dispiegare una tavolozza pressoché infinita di presentazioni eppure mantiene una sorprendente identità; spesso viene presentato come simbolica lontananza, pronto ad abbracciare per intero tutto il nostro orizzonte, grazie alla sua poderosa vastità soprattutto se messa in relazione con gli spazi angusti che gli uomini ritagliano attorno a loro stessi attraverso muri invalicabili; ci appare mentre fa capolino tra le fronde, col suo liquido e accecante formicolare, oppure quando percepiamo la presenza incombente del fragoroso infrangersi delle onde su scogliere schiumanti; o veniamo investiti dal suo alito umido e salmastro, tanto da lasciare un’impronta indelebile. Il Mediterraneo è ciò che ci lega profondamente. È il mare di tutti.
Mariangela Lando
(n. 11, novembre 2023, anno XIII)
NOTE
[1] R. FREGNI è vincitore del premio Populiste nel 1990; è autore di numerosi libri e tiene laboratori di scrittura in carcere. Lo scrittore ha fatto del viaggio nel Mediterraneo una fonte di sopravvivenza e di scrittura. In italiano è tradotto nell’antologia Lingue di mare, lingue di terra, Messina, Mesogea, 1999.
[2] C. FERRINI, Venature mediterranee Dialogo con gli scrittori di oggi, Messina, Mesogea, 2000, p.17.
[3] H. MINA prima di diventare celebre grazie al romanzo La vela e la tempesta, uscito nel 1993, si è formato come autodidatta ed è stato a lungo marinaio, esercitando molti lavori.
[4] W.H. AUDEN, Gli irati flutti, prefazione di Gilberto Sacerdoti, Roma, Fazi Editore, 1995.
[5] C. FERRINI, Venature mediterranee Dialogo con gli scrittori di oggi, cit., p. 23.
[6] M. MAGGIONI è vincitore del premio Viareggio e Campiello con Il pettirosso nel 1995.
[7] Ivi, p. 35.
[8] Ivi, p. 39.
[9] A. CAMUS, Il rovescio e il dritto, Milano, Bompiani, 1990.
BIBLIOGRAFIA
M. BARRADA, A. al-M. Qadduri, Lo sguardo marocchino Messina, Mesogea, 2002.
J. DANIEL, Resistere all'aria del tempo, (con Camus) prefazione di Claudio Magris, Messina, Mesogea, 2009.
G. DUBY, Gli ideali del Mediterraneo, storia, filosofia e letteratura nella cultura euro, Messina: Mesogea, 1999.
C. FERRINI, Lingue di mare, lingue di terra, Messina, Mesogea, 2004.
A. FINE, Un caso di coscienza e altri racconti,introduzione di Silvio Perrella, Messina, Mesogea, 2002.
M. V. Montalbán, E. G. Calleja, C. Vergari (Traduttore), Lo sguardo spagnolo, Messina, Mesogea, 2002.
E. MONTALE, Tutte le poesie a cura di Giorgio Zampa, Milano Mondadori, 2009.
|
|

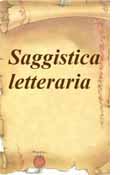 Introduzione
Introduzione