









|
|
Amedeo Anelli: «Mi sembra che in Italia non sia molto conosciuta la poesia romena»
 Ospite dei nostri Incontri critici è Amedeo Anelli (n. 1956, Santo Stefano Lodigiano), filosofo, professore, critico d’arte e poeta. Ha pubblicato numerosi cataloghi, libri d’arte e saggi di critica letteraria, estetica, e di arti visive. Ha fondato e dirige dal 1991 la rivista internazionale di poesia e filosofia «Kamen’». Dal 2000 è membro del Corpo Accademico dell’Accademia di Belle Arti «Pietro Vannucci» di Perugia e dal 2009 fa parte del comitato scientifico internazionale della rivista slovena «Poetikon». Ospite dei nostri Incontri critici è Amedeo Anelli (n. 1956, Santo Stefano Lodigiano), filosofo, professore, critico d’arte e poeta. Ha pubblicato numerosi cataloghi, libri d’arte e saggi di critica letteraria, estetica, e di arti visive. Ha fondato e dirige dal 1991 la rivista internazionale di poesia e filosofia «Kamen’». Dal 2000 è membro del Corpo Accademico dell’Accademia di Belle Arti «Pietro Vannucci» di Perugia e dal 2009 fa parte del comitato scientifico internazionale della rivista slovena «Poetikon».
I suoi scritti sono tradotti in russo, francese, svedese, tedesco inglese, portoghese, sloveno. In traduzione romena sono state pubblicate le raccolte Simfonietă e Polifonii (Eikon, 2017 e 2019), a cura di Eliza Macadan. È inoltre presente nell’antologia Mâna scrie sunetul: elecțiuni afective de poezie italiană contemporană che riunisce 12 poeti italiani contemporanei, a cura di Eliza Macadan (Eikon, 2014).
Amedeo Anelli, la sua creatura più longeva è la rivista internazionale di poesia e filosofia fondata nel ’91: «Kamen’», con tre sezioni monografiche. Quali sono le motivazioni sottese alla scelta di questa formula?
La rivista «Kamen’», dal russo ‘pietra’, è nata nei primi anni Novanta per il bisogno di ripensare la forma «rivista» e in particolare la forma «rivista di poesia», raccordandola con tutti i saperi. Di qui le sezioni monografiche su esponenti della cultura non solo poetica e sui rapporti con tutte le discipline: dal giornalismo alla fisica, dalla teoria della letteratura all’estetica, alle categorie del comico ecc. «Kamen’» intendeva rilanciare un’idea forte di progettualità e della molteplicità delle tradizioni in un contesto in cui mancavano l’approfondimento, la sistematicità di scelte tali da offrire riflessioni, interpretazioni, dissensi o consensi forti, che non fossero semplice presa d’atto di lavori in corso. C’era il bisogno di riaffermare un principio di responsabilità della cultura e nella cultura, un pensiero mirato a «cambiare il cambiamento», non a esserne passive pedine. Per tale visione forte della cultura e dell’intellettuale si decideva la formula monografica, che permette di affrontare gli argomenti nel modo più completo e approfondito e di evitare insomma l’effetto ‘Grand Hotel’: la rivista da sfogliare, da leggiucchiare, ma da non leggere integralmente, non da meditare. L’intenzione era porre l’accento sulle tradizioni della poesia di pensiero a forte radicamento etico. Ciò non ha a che fare col pensiero poetante, e questo per l’avversione verso poetiche di origine idealistica, radicate nelle aporie romantiche della modernità da denunziare e tentare di sanare. Il contesto della poesia italiana degli ultimi decenni è di grande debolezza, e vi restano forme esaurite della linea simbolista-decadente; con grande ritardo rispetto alle tradizioni europee. In questi anni di lavoro «Kamen’» è diventata più che una rivista: un progetto internazionale plurimo e un’ampia comunità di ricerca sulle tradizioni dell’Europa e non solo, avendone un senso progressivo e guardando innanzi tutto a quelle a venire, ma con il sentimento che sia sempre possibile una protensione inversa dal futuro al presente.
Le sue poesie sono pubblicate anche in traduzione romena. In un tempo politico, sociale ed economico che grida l’impellente bisogno di tessere un dialogo con sé stessi, la conflittualità interiore può essere lenita dalla Poesia?
I miei principali interessi sia in poesia sia altrove sono rivolti al rapporto tra pensiero e orizzonte di senso. Faccio una poesia polifonica stratificata che si basa su campi semantici, che in prima misura si affida alle immagini e non segue la logica della frase, anche se sembra rientrarvi. La poesia è in grado secondo le proprie leggi di portare in sé ogni sapere, ogni sensibilità e quindi anche le lacerazioni del vissuto e del conflitto; sicuramente questo mio scrivere pone su vari gradi il problema dell’interrogazione filosofica ed esistenziale. Se questo lenisce o acutizza la conflittualità interiore, questo non le saprei dire… Fra chi mi ha tradotto in romeno vorrei ricordare con gratitudine anche Doina Condrea Derer.
Lei ha affermato: «È impossibile occuparsi di letteratura e di critica, ai giorni nostri, se non si conosce approfonditamente il panorama europeo dal ’600 in poi». È il respiro transnazionale a catturare la sua attenzione?
Per fare Arte e Critica d’Arte serve tutto e non basta nulla. La modernità ha aperto a molteplici interrelazioni e alla Weltliteratur. È impossibile studiare in profondità gli autori se non li caliamo almeno nella cultura europea in cui si sono formati con tutte le passioni, i prestiti e le rielaborazioni. Al giorno d’oggi non si può più fare storia della letteratura sul modello lineare alla Francesco De Sanctis e senza considerare tutte le implicazioni culturali che hanno toccato gli autori. Il concetto di campo semantico con opportune correzioni arriva dalla fisica di fine Ottocento. Il padre di Aleksandr Sergeevič Puškin leggeva in italiano il Parini di Il Giorno e l’autore ne tenne conto nell’Evgenij Onegin, e così via…
La sua impronta poetica è di carattere fondamentalmente filosofico. Nel tessere un rapporto fra filosofia, etica ed estetica in qual misura ha risentito della cultura russa?
Oltre alla linea dantesca della poesia europea, sicuramente l’area slava ha contribuito ad ampliare i miei interessi filosofici a partire dal filosofo ucraino Hryhorij Savyč Skovoroda, un ponte fra Giordano Bruno e Comenio, e la fondazione della cultura russa a cominciare da Puškin, Dostoevskij, fino a Tarkovskij… Ma questa tensione è tipica anche della mia tradizione culturale a partire da Dante, Campanella, Leopardi ecc…
Lei ha tradotto l’opera dei poeti russi Arsenij Tarkovskij, Osip Mandel’štam, Boris Pasternak. Nella rappresentazione contemporanea della figura traduttiva, è stata fortemente voluta anche dagli organi istituzionali l’introduzione della codifica di mediatore. Ritiene di essere dotato esclusivamente di un talento traduttivo linguistico o di essere anche un mediatore culturale?
Contrariamente a visioni di stampo idealistico sull’intraducibilità della poesia, penso che una pratica millenaria come la traduzione sia un modo per far dialogare le culture e una grande verifica per chi viene tradotto. Per quanto maldestro il traduttore, se il poeta ha spessore qualcosa passa; non si può certo pretendere l’equivalenza, perché Giovanni non potrà mai diventare Carlo, in una forma come quella poetica in cui tutto ha senso. Ma sono i bisogni della tradizione di arrivo che fanno la traduzione, sicuramente la totalità del dialogo fra culture e l’ampliamento che un’altra lingua porta nell’orizzonte di senso della propria.
Recentemente ha curato l’opera poetica di Roberto Rebora, rendendo disponibile la quasi totalità dei testi poetici editi in libri, riviste ed edizioni rare. Emerge l’attenzione ai temi del silenzio attivo, della temporalità, del dato di coscienza, della corporeità senziente, del rilievo della percezione e degli enigmi della Natura. Ebbene, quanto reputa che Rebora sia vicino a una prospettiva neo-fenomenologica?
Sicuramente Roberto Rebora è uno degli esponenti poetici (insieme con Vittorio Sereni, Antonia Pozzi e anche Daria Menicanti) della Scuola di Milano, anche se non è stato un allievo diretto di Banfi per motivi esistenziali: la morte prematura del padre e il lavoro all’Officina del Gas della Bovisa di Milano. Comunque vi sono molte interconnessioni e vicinanze, a cominciare dall’amicizia con Enzo Paci e dal progressivo processo di raffinazione e di sospensione del giudizio e di riduzione fenomenologica che a suo modo ha applicato al proprio poetare. Basterebbero comunque i temi che lei ha citato: silenzio attivo, corporeità senziente, temporalità ecc… ad avvicinarlo a una cultura fenomenologica
La scrittura contemporanea può annoverare letterate illuminate, vere pioniere quanto a innovazione e rispetto della tradizione. Qual è l’attuale status della letteratura esperìta da donne?
Ci sono nel marasma generale e nella epigonalità diffusa del poetare italiano contemporaneo vere eccezioni come Margherita Rimi e altre che portano il loro solido contributo all’evoluzione del linguaggio non solo poetico: ad esempio, la critica Daniela Marcheschi, che fa eccezione anche nella poesia. Ma non ne farei una questione di genere, quanto di qualità, pur portando nel testo anche la loro femminilità.
La letteratura romena è costantemente tradotta in lingua italiana e la rivista «Orizzonti culturali italo-romeni» ne registra le pubblicazioni nel database Scrittori romeni in italiano: 1900-2022. In che misura pensa sia conosciuta in Italia e quali scrittori romeni hanno attirato la sua attenzione?
Dopo le aperture degli anni Sessanta del secolo scorso, si pensi al fiorire delle traduzioni e delle antologie, mi sembra che nel nostro Paese non sia molto conosciuta la poesia romena, che ci sia da fare un grande lavoro soprattutto editoriale. Sono molti i poeti romeni che mi hanno nutrito a cominciare da Mihai Eminescu, sino a Ion Barbu, Tudor Arghezi, poi ovviamente Lucian Blaga, per venire sino a noi con Ana Blandiana ed Eliza Macadan di cui ho prefato diversi libri.
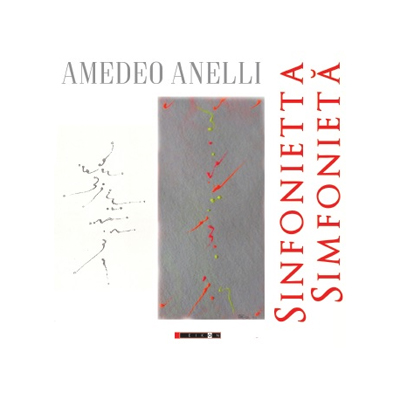
A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone
(n. 9, settembre 2022, anno XII)
|
|

