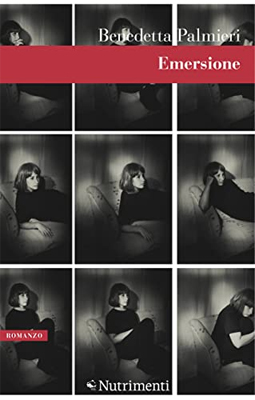|
|
Benedetta Palmieri: «Oggi c'è la diffusione di un approccio personale alla scrittura»
 Nella sezione Scrittori per lo Strega della nostra rivista, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, vi proponiamo una nuova serie di 10 interviste con gli scrittori segnalati all’edizione n. 76 del Premio, e con i loro libri, allargando ovviamente lo sguardo ad altri argomenti di attualità. Nella sezione Scrittori per lo Strega della nostra rivista, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, vi proponiamo una nuova serie di 10 interviste con gli scrittori segnalati all’edizione n. 76 del Premio, e con i loro libri, allargando ovviamente lo sguardo ad altri argomenti di attualità.
Benedetta Palmieri, nata a Napoli nel 1973, è segnalata per il romanzo Emersione (Nutrimenti, 2021). Lo presenta Alberto Rollo : «La voce che dice io, Hornby, si sveglia al dolore di una perdita incomprensibile: l’uomo che ha amato si è ammazzato. Tanto violenta, tanto drastica è la sua assenza che Hornby non può far altro che strapparlo all’Ade e averlo come interlocutore naturale. Palmieri racconta il suo inferno con voce tagliente, cruda, innamorata. Ricorda talvolta Annie Ernaux, talvolta Joan Didion, talvolta Elsa Morante. Formicola tra le righe un’urticante intelligenza delle cose del mondo, soffia sulle pagine un desiderio di riscatto, che coincide con la stessa sostanza della scrittura, riscatto essa stessa, a fronte della cattiva marea del nulla».
Emersione narra del dolore dovuto a una perdita incomprensibile: l’uomo che una donna ha amato si è ammazzato. Le sue righe suggeriscono l’amore come un sentimento che intrappola, che non dà scampo e non prevede vie di fuga: Elena e Paride infrangono ogni regola, ogni convenzione, narra Omero. Ebbene, non si sceglie d’amare né d’essere amati?
Immagino le vie dell’amore innumerevoli, e altrettanti i modi della sua ricerca o della sua attesa (ma forse anche dello schivarlo) – ove ciò sia un’esigenza. Personalmente, sono sempre stata affascinata dall’idea che non si scegliesse. Ma oggi penso di riconoscere anche un terreno condiviso tra la dirompente inevitabilità del sentimento e quella che definirei una disposizione a che quell’incontro avvenga. Non so, forse ipotizzo una consapevolezza e una apertura propedeutiche (pur se non necessariamente manifeste), una capacità d’accoglimento dell’amore – quantomeno in talune fasi della vita. Ma potrei essere condizionata dalla mia esperienza personale.
L’uomo non era un depresso, né era angustiato da collassi esistenziali. Leggendo le sue pagine pare che emerga un elogio dell’imperfezione. È il difetto, la fragilità, l’incompiutezza che ci rende unici?
Ho molto rispetto e molta tenerezza per l’imperfezione. Credo che tutto ci renda unici, anche la compiutezza può farlo. Ho però particolare simpatia per ciò che è impreciso, sbavato, sbeccato. Ma se nei confronti delle imperfezioni e delle fragilità altrui ho sempre provato comprensione, ho faticato invece a accettare le mie, che ho a lungo cercato di contenere in forme di spiccata rigidità. Un esercizio dannoso, che ho imparato – anche se forse è più giusto dire che sto imparando – a dismettere piano piano, grazie all’analisi e all’ineludibile necessità di crescere.
Hornby, la protagonista del suo romanzo, si contempla con sgomento. L’ascolto interiore può configurarsi come elemento focale per la riscoperta dell'amore verso se stessi?
Sono persuasa di sì. Ascoltarsi è un passaggio necessario per la conoscenza e l’accettazione di sé – senza le quali immagino sia difficile amarsi. Credo però che non esistano formule date, non regole uniche, non soluzioni efficaci per tutti.
Oggi, in tantissimi scrivono romanzi e tantissimi sono gli esordienti. È altresì innegabile la crisi in cui versa il mercato editoriale. Quali parole sente di rivolgere a chi coltiva il sogno e la speranza della pubblicazione della propria opera?
Devo dire che io mi sento sempre, ancora alla scoperta della strada da percorrere. Dunque, l’unica cosa che mi sentirei di dire è di misurarsi costantemente con se stessi – esplorare la propria passione, i desideri, la propria determinazione, avere contezza di sé. E poi, credo si debba aspirare a una saldezza d’animo, che aiuti a tenere presenti la propria indole e la propria direzione – nei momenti in cui le cose vanno male così come in quelli in cui vanno bene.
Francesco De Sanctis scrisse che la letteratura di una nazione costituisce una «sintesi organica dell'anima e del pensiero d'un popolo». Posto che la letteratura siauno specchio della rispettiva società in un tempo definito e che varia di opera in opera, quali potrebbero essere il ruolo e la funzione della scrittura nel frangente storico che stiamo vivendo?
Attribuire preventivamente un ruolo e una funzione alla scrittura temo rischi di vincolarla, sottraendole parte del suo senso e della sua più profonda bellezza. Altro è riuscire a registrare ruoli e funzioni manifestatisi in determinati momenti storici, ma è una cosa che credo si possa fare a distanza. C’è però un’idea che mi suggestiona, ed è la diffusione di un approccio personale (quando non direttamente autobiografico) alla scrittura. Un approccio che non credo si debba attribuire a quella parte più deteriore di certo individualismo dei nostri tempi. A me sembra piuttosto il tentativo – in un mondo dai tratti stranianti e sgretolati – di fare appello al nostro primo filtro, al primo aggancio alla realtà, a ciò che possediamo per certo e che meglio possiamo conoscere, ossia noi stessi.
La scrittura contemporanea può annoverare letterate illuminate, vere pioniere quanto a innovazione e rispetto della tradizione. Qual è l’attuale status della letteratura esperìta da donne?
Ho qualche remora sulla questione della letteratura divisa per sessi. Ma, per restare più strettamente sulla domanda, mi sembra che in Italia sia piuttosto forte una rappresentanza molto battagliera sui temi proprio del femminile, in un’ottica soprattutto politica. Non so dirne l’efficacia e rispetto le scelte altrui, ma non mi sentirei di fare ugualmente.
Bachtin asserisce che il romanzo sia un ‘genere aperto’, destinato non a morire bensì a trasformarsi. Oggi, si notano forme ‘ibride’. Quali tendenze di sviluppo ravvede di un genere che continua a sfuggire a ogni codice?
Quella ibrida è una forma che trovo molto interessante, che mi piace per il suo offrire ampie possibilità, libertà di movimento, spazio per affrontare una storia su piani differenti e con differenti modalità. Mi sembra effettivamente piuttosto rappresentativa al momento e ho idea che potrebbe esserlo ancora a lungo. Ma la scrittura è materia viva e in quanto tale mutevole in maniera imprevedibile, e così i suoi generi; quindi non mi senterei di azzardare predizioni.
La letteratura romena si fregia di una robusta altresì varia produzione. Essa è costantemente tradotta in lingua italiana, con nomi di punta quali Ana Blandiana, Herta Müller, Mircea Cărtărescu, Emil Cioran, e la rivista «Orizzonti culturali italo-romeni» ne registra le pubblicazioni nel database Scrittori romeni in italiano: 1900-2021. Quali scrittori romeni hanno attirato la sua attenzione?
Ho la sensazione che sia conosciuta abbastanza, ma che si potrebbe conoscerla di più. Per dire di me, penso a Emil Cioran. Ne L’inconveniente di essere nati, Cioran scrive: «Esiste una conoscenza che toglie peso e portata a quello che si fa – e per la quale tutto è privo di fondamento tranne essa medesima»; e poi riprende qualche rigo più sotto: «Il poter ripetere, a ogni incontro, che nessuno dei gesti da noi compiuti merita la nostra adesione, che niente è avvalorato da una qualche traccia di sostanza». Ebbene, è qualcosa che non solo mi suggestiona, ma che ho pensato, sentito distintamente – e spaventosamente, aggiungerei. Credo però possa esistere, per chi riesce a trovarlo, uno spazio al di qua di quel pensiero estremo – uno spazio meno radicale, meno definitivo, nel quale in qualche modo dimenticare o tacitare momentaneamente quella conoscenza, per consentirsi di procedere nella vita.
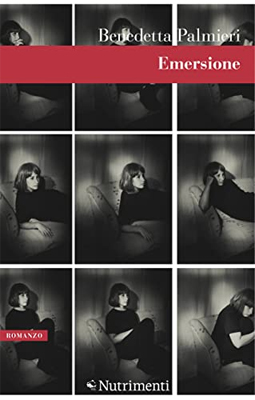
A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone
(n. 4, aprile 2022, anno XII)
|
|

 Nella sezione
Nella sezione