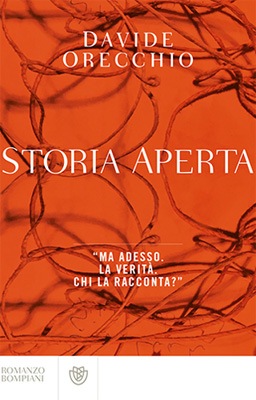|
|
Davide Orecchio: «La migliore letteratura sociale aiuta a ‘decontaminare’ da falsi miti e ignoranza»
 Nella sezione Scrittori per lo Strega della nostra rivista, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, vi proponiamo una nuova serie di 10 interviste con gli scrittori candidati al Premio e quelli segnalati all’edizione n. 76, e con i loro libri, allargando ovviamente lo sguardo ad altri argomenti di attualità. Nella sezione Scrittori per lo Strega della nostra rivista, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, vi proponiamo una nuova serie di 10 interviste con gli scrittori candidati al Premio e quelli segnalati all’edizione n. 76, e con i loro libri, allargando ovviamente lo sguardo ad altri argomenti di attualità.
Davide Orecchio, nato a Roma nel 1969, è uno dei 12 candidati al Premio Strega 2022 con il romanzo Storia aperta (Bompiani, 2021). Martina Testa lo presenta così: «Storia aperta di Davide Orecchio è un romanzo originale e potente. Racconta la storia di un uomo del Novecento, Pietro Migliorisi, scrittore e giornalista, che dopo la giovanile militanza nel fascismo ha un’autentica conversione alla causa comunista, fede che lo accompagnerà per il resto della sua vita. Intorno a questa parabola politica si disegna quella umana, intima del personaggio, con i suoi affetti, le sue ossessioni, le sue paure, mentre sullo sfondo – o a volte in primo piano – scorre quasi un secolo di storia italiana. A tenere insieme il tutto c’è una scrittura di grandissima sapienza».
Pietro Migliorisi, protagonista di Storia aperta ed eteronimo di tanti uomini e donne della sua generazione. «Noi siamo ignoranti. Noi siamo, in miliardi di pixel, gli eredi». Chi è il «bambino diacronico»?
È un figlio del Novecento. Nasce nel 1915. Muore nel 2001. Ed è un figlio della Storia, perché ha il destino di abitare un tempo iperstorico, ultrastorico. Educato nel fascismo, diventa presto un giovane intellettuale fascista «di sinistra» – formula alquanto ambigua, lo ammetto –, diciamo un frondista. Combatte le guerre del fascismo. La prima, da volontario, in Africa (1935-1936). Poi, per obbligo, in Grecia e Sicilia, durante la Seconda guerra mondiale. Diventa progressivamente afascista, antifascista, comunista, man mano che scopre il vero obiettivo del regime fascista: fare di lui un assassino oppure un morto. La sua ultima battaglia è quella giusta, da partigiano, nella Resistenza romana (1943-1944). In quei nove mesi si rimette al mondo e ottiene una seconda vita (da qui, non a caso, si avvia la seconda parte del romanzo). Pietro è un bambino diacronico in quanto figlio del tempo storico, ma anche per una sua attitudine istintiva, impulsiva, temeraria, spesso sprovveduta e infantile.
Lei racconta l’ascesa del fascismo, l’articolarsi del comunismo, i seguenti declini e il mutamento diiambedue le ideologie. Ciò, evidentemente, ha richiesto ricerche storiche accurate e meticolose. Quale metodo si è imposto di adottare per trattenere le informazioni e, poi, renderle narrativa?
Il metodo di studio per i lavori preparatori al romanzo è quello che avrebbe adottato un qualsiasi studioso o studente di storia. Costruzione di una bibliografia, esame della letteratura secondaria e primaria, della memorialistica, delle fonti di archivio prescelte. Il metodo della scrittura è il compimento di un metodo che adotto da diversi anni, nel quale cerco di far parlare con un tono narrativo le fonti, le mescolo alla voce narrante, utilizzo citazioni, ricorro anche alla tecnica del pastiche. Il risultato è un romanzo non storico nel senso tradizionale, ma che racconta una storia, una vita, sperimentando un dialogo con le proprie fonti.
Storia aperta effigia l’incontro tra generazioni differenti e rappresenta la trasmissione di un lascito novecentesco per ora aperto. La lotta politica, l’adesione a una causa: i nostri tempi possono ospitare, a suo avviso, siffatti propositi di cambiamento sociale attraverso il canale della Letteratura?
Dubito che la letteratura possa essere uno strumento della lotta politica. Almeno la buona letteratura. Non lo è nemmeno nella storia che racconto nel libro. Il protagonista vorrebbe essere uno scrittore comunista. Scrittore in quanto comunista, e comunista in quanto scrittore. E fallisce. Ma certo gli intellettuali, le scrittrici, gli scrittori continuano ad avere un ruolo persino nei nostri tempi, e lo possono usare per le cause nelle quali credono. E la migliore letteratura sociale può aiutare a «decontaminare» da falsi miti e ignoranza, a creare consapevolezza. Basti pensare all’opera omnia di George Orwell, un classico. O, in tempi più recenti, a Una paga da fame di Barbara Ehrenreich e alle pagine di Anna Politkovskaja sulla Russia di Putin.
Un padre comunista e intellettuale, fedelissimo ai dettami del partito: perché ha ritenuto di dover indagare i dubbi dei padri, le loro motivazioni e i loro smottamenti?
Perché volevo conoscere la storia di mio padre, che ispira il personaggio di Pietro Migliorisi, e che avrebbe potuto essere mio nonno. Non sapevo molto della sua biografia e, dopo la sua morte, mi sono rimboccato le maniche per studiare. Prima del romanzo, molto prima, c’è stato un semplice desiderio di conoscenza. Inoltre avevo scoperto, o meglio chiarito, che mio padre non era stato solo comunista, ma anche fascista da giovane; volevo riannodare le sue due vite, e magari capire anche qualcosa della storia di questo Paese.
Francesco De Sanctis scrisse che la letteratura di una nazione costituisce una «sintesi organica dell'anima e del pensiero d'un popolo». Posto che la letteratura siauno specchio della rispettiva società in un tempo definito e che varia di opera in opera, quali potrebbero essere il ruolo e la funzione della scrittura nel frangente storico che stiamo vivendo?
Credo che scrittrici e scrittori, nei tempi di guerra e malattia che stiamo attraversando, dovrebbero porsi il compito di ripulire le parole dalla propaganda, di trovare le parole giuste per esprimere posizioni condivise e sentimenti che noi tutti proviamo. Le parole sono infangate da incantesimi e camuffamenti. La letteratura le può e deve nettare.
Hegel sviluppa una definizione del romanzo: esso è la moderna epopea borghese. Lukács afferma che questo genere, essendo il prodotto della borghesia, è destinato a decadere con la morte della borghesia stessa. Bachtin asserisce che il romanzo sia un «genere aperto», destinato non a morire bensì a trasformarsi. Oggi, si notano forme «ibride». Quali tendenze di sviluppo ravvede di un genere che continua a sfuggire a ogni codice?
Io tifo per Bachtin. Decisamente. Il romanzo è un genere ravvivato proprio dai tentativi di trasformarlo e ibridarlo. Può accogliere qualsiasi progetto narrativo. Le tendenze più felici, dal mio punto di vista – che riguarda le mie frequentazioni di lettore, le mie passioni – sgorgano da quella letteratura di vite, di storie, di memorie ibridate in fonti e testimonianze, in saggio e invenzione, che da W.G. Sebald e Danilo Kiš arriva ai contemporanei David Peace, Mattias Enard, Helena Janeczek, Svetlana Aleksievič, per citare solo alcuni nomi.
La scrittura contemporanea può annoverare letterate illuminate, vere pioniere quanto a innovazione e rispetto della tradizione. Qual è l’attuale status della letteratura esperìta da donne?
Leggiamo sempre più scrittrici autorevoli, importanti e di successo. Certamente di più rispetto a dieci, venti, trenta o quarant’anni fa. Quindi, ottimo. Questa domanda sullo status dovremmo però rivolgerla a loro, alle scrittrici, non a me, che sono pur sempre un maschio con meno occhio e sensibilità rispetto alle permanenze del patriarcato. Se posso suggerire un punto di partenza per rendersi conto della situazione attuale: Daniela Brogi, Lo spazio delle donne, Einaudi 2022.
La letteratura romena si fregia di una robusta altresì varia produzione. Essa è costantemente tradotta in lingua italiana, con nomi di punta quali Ana Blandiana, Herta Müller, Mircea Cărtărescu, Emil Cioran, e la rivista «Orizzonti culturali italo-romeni» ne registra le pubblicazioni nel database Scrittori romeni in italiano: 1900-2021. Quali scrittori romeni hanno attirato la sua attenzione?
Ha citato autori, classici e contemporanei, di profonda raffinatezza e non conosciuti, purtroppo, dal vasto pubblico italiano. Ma forse nemmeno «purtroppo». Direi «per forza di cose». Chi attira la mia attenzione? Sarò scontato nella risposta, ma i libri di Cărtărescu me li procuro sempre.
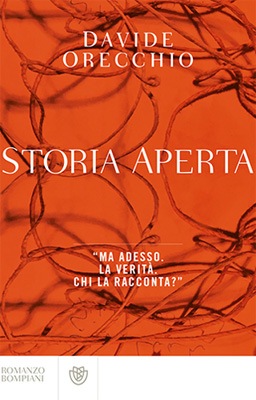
A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone
(n. 5, maggio 2022, anno XII)
|
|

 Nella sezione
Nella sezione