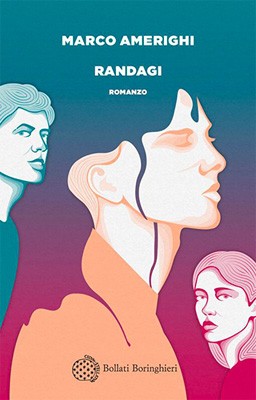|
|
Marco Amerighi: «La scrittura è sempre un atto politico, perché implica una scelta»
 Nella sezione Scrittori per lo Strega della nostra rivista, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, vi proponiamo una nuova serie di interviste con gli scrittori finalisti dell’edizione n. 76 del Premio, e con i loro libri, allargando ovviamente lo sguardo ad altri argomenti di attualità. Nella sezione Scrittori per lo Strega della nostra rivista, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, vi proponiamo una nuova serie di interviste con gli scrittori finalisti dell’edizione n. 76 del Premio, e con i loro libri, allargando ovviamente lo sguardo ad altri argomenti di attualità.
Il vincitore del Premio Strega è Mario Desiati con «Spatriati» (Einaudi), 166 voti. L'edizione 2022 ha visto per la prima volta sette finalisti, anziché cinque (due ex aequo al quinto posto, mentre il settimo, per regolamento, è un libro pubblicato da un editore medio-piccolo). Questa la classifica della finale che si è tenuta al Museo Etrusco di Villa Giulia il 7 luglio 2022: secondo classificato Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskij (Rizzoli), terza Alessandra Carati, E poi saremo salvi (Mondadori), quarta Veronica Raimo, Niente di vero (Einaudi), già vincitrice dello Strega Giovani. Quinto Marco Amerighi, Randagi (Bollati Boringhieri), sesto Fabio Bacà, Nova (Adelphi) e settima Veronica Galletta, Nina sull’argine (minimum fax).
Marco Amerighi, nato a Pisa nel 1982, si è classificato al quinto posto nella finale di quest'anno con il romanzo I randagi (Bollati Boringhieri, 2021). Silvia Ballestra lo presenta così: «I randagi di Marco Amerighi sono cuccioli, e poi giovani cani sciolti, alla ricerca di sé in un peregrinare tra amori e luoghi nel tentativo di sfuggire a famiglie, seppur presenti, spesso esplose. [...] Randagi è, in questo, davvero una storia in grado di cogliere l’essenza di un tempo e dei giovani che, impotenti e spaesati, lo hanno abitato. Personaggi memorabili e una lingua bella e tornita, quella di Amerighi, che con misura e sapienza ci regala echi luminosi e ironici di toscanità anche classica. Un romanzo importante, libero, vitale, caratterizzato da un’affabulazione felice e trascinante, ricca e compiuta».
In Randagi la famiglia Benati, protagonista, naviga nell’ultimo Novecento: gli sms, i viaggi Erasmus, l’attentato nella città di Madrid dell’11 marzo 2004. È un passato recentissimo, eppure davvero distante, considerate le evoluzioni, i mutamenti, i cambiamenti dell’ultimo ventennio. Quali sono le ragioni sottese a tale scelta del «tempo del racconto»?
Due, le ragioni. La prima: il romanzo si conclude nel 2008, che è l’anno dell’esplosione di Facebook e, generalmente, di quei social che renderanno il mondo più vicino, più veloce, globalizzato. Fino a quel momento, i tempi e gli spazi erano più dilatati. Si potevano scrivere sms o lettere senza sapere se o quando sarebbero arrivate. Si poteva far perdere le nostre tracce. E dato che uno dei temi fondamentali del romanzo è la scomparsa – che guarda caso pesa sui maschi della famiglia Benati come una maledizione – quali tempo migliore di questo?
La seconda ha a che vedere con la Storia recente. Il romanzo è diviso in tre parti e ogni parte ha come sfondo un evento: il G8 di Genova del 2001, gli attentati terroristici di Madrid del 2004 e, anche se più indirettamente, i movimenti studenteschi dell’Onda del 2007. Sono tre momenti in cui la generazione dei protagonisti di questo romanzo ha visto svanire i sogni, le illusioni e le lotte in cui aveva riposto tutta se stessa. Ed è proprio a partire da questi eventi che si è sperduta nel mondo, che è diventata raminga; randagia, appunto.
L’inettitudine serpeggia tra le pagine. È il dramma di un’umanità che ha issato bandiera bianca?
Non di tutta, forse. Di sicuro lo è, come una sorta di tara genetica, per le ragazze e i ragazzi, nati tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Novanta. Una generazione cresciuta nella certezza di trovare felicità e successo nella vita, quella felicità e quel successo che i loro nonni avevano ricostruito dalle macerie della Seconda guerra mondiale, e i loro genitori avevano gonfiato e lucidato negli anni del boom economico. E invece... e invece a loro non è toccato quasi niente. Perché è stata la prima generazione della decrescita, la prima a vivere in condizioni di instabilità economica, politica e sociale maggiore dei loro predecessori. La generazione che ha scoperto che all’orizzonte non l’aspettava la luce verde di cui parlava Fitzgerald ne Il grande Gatsby. Per loro non c’era proprio nessuna luce all’orizzonte.
Una costellazione di personaggi, un romanzo diviso in tre parti con al centro un tipo diverso di destino. Il suo romanzo presenta pagine oltremodo realistiche relative a sensazioni di vuoto, di smarrimento e di malinconia aderenti a tanti giovani «randagi». Ha desiderato compiere anche un atto di denuncia sociale?
Io credo che la scrittura sia sempre un atto politico (nel senso etimologico del termine, di ciò che ha a che vedere con la polis, con la ‘collettività’) perché implica una scelta. Io scelgo di raccontare questa storia e non un’altra e facendolo mi schiero, restituisco uno sguardo sul mondo, il mio sguardo. Questo non significa che sia automaticamente un atto di denuncia. Io non voglio insegnare o inculcare nulla, i libri ‘a tesi’ sono spocchiosi e inutili. Mi piace piuttosto l’idea di gettare una luce, alimentare una riflessione. E lasciare ai lettori e alle lettrici la libertà di farsi la propria idea sul mondo che ho costruito per loro. Senza questa libertà – che è libertà di immedesimarsi, di emozionarsi, ma anche di valutare criticamente – per me la scrittura e i romanzi non servono a nulla.
Quali sono le ragioni per le quali coloro che sono nati negli anni Ottanta del secolo passato si ritrovano afflitti da un precoce senso di fallimento esistenziale?
Questa generazione è l’unica ad aver fallito prima ancora di averci provato. Niente male, eh? È come dicevo sopra. I nonni di queste ragazze e ragazzi sono riusciti a ricostruire l’Italia dopo la Seconda guerra mondiale, i loro genitori hanno goduto dei piccoli ma costanti frutti di una crescita economica, e i randagi... be’, quel posto al sole che era stato promesso loro non c’era. Ecco dove nasce la crisi di questa generazione. Una crisi accresciuta da una mancanza di punti di riferimento: politici, per uno Stato assente; affettivi, per colpa di famiglie distratte o al contrario troppo pressanti; culturali, per quei maestri più interessati ai propri interessi che alla loro funzione pedagogica. Con questi ingredienti, come non ci si può sentire dei falliti?
La contemporaneità non contempla esclusivamente le opposizioni oralità/scrittura e poesia/prosa, ma anche la possibilità di scelta tra e-book/online e cartaceo, tra letteratura cartacea e digitale. Quanto lo sguardo di un autore è condizionato dal profumo della carta stampata o, viceversa, dalla comodità del digitale?
Non ne sono condizionato in nessun modo. Come lettore forte, mi appoggio a entrambi i formati. Certo è che la carta prima o poi si esaurirà sul pianeta. E la produzione dei libri cartacei dovrà arrestarsi. E allora forse dovremmo iniziare a fare i conti – adesso, subito! – con la necessità di familiarizzare di più con i formati on-line. Per questo serve anche che gli editori diano una mano ai lettori, che mettano più titoli in catalogo, che aumentino la produzione, abbassino i prezzi... è una riflessione complessa, ma che bisogna iniziare a fare il prima possibile.
Francesco De Sanctis scrisse che la letteratura di una nazione costituisce una «sintesi organica dell'anima e del pensiero d'un popolo». Posto che la letteratura siauno specchio della rispettiva società in un tempo definito e che varia di opera in opera, quali potrebbero essere il ruolo e la funzione della scrittura nel frangente storico che stiamo vivendo?
Torno a quello a cui accennavo rapidamente sopra. Scrivere per me è condurre le lettrici e i lettori in luoghi sconosciuti, permettendo loro di vestire panni non loro, guidandoli a immedesimarsi nell’altro. Un grande poeta del Seicento persiano diceva: «non si è degni di essere chiamati uomini finché non si prova il dolore dell’altro». Ecco, in un mondo di egoismi, prevaricazioni e guerre, il romanzo ricopre ancora una missione fondamentale: aiutarci a sentire quello che sente l’altro. Che sia la gioia più unica o il dolore più bruciante. Uscire da noi stessi, pensare agli altri. Non mi pare poco.
Hegel sviluppa una definizione del romanzo: esso è la moderna epopea borghese. Lukács afferma che questo genere, essendo il prodotto della borghesia, è destinato a decadere con la morte della borghesia stessa. Bachtin asserisce che il romanzo sia un «genere aperto», destinato non a morire bensì a trasformarsi. Oggi, si notano forme «ibride». Quali tendenze di sviluppo ravvede di un genere che continua a sfuggire a ogni codice?
Due cose si dicono sul romanzo da decenni: che è borghese ed è morto. Borghese lo è ontologicamente, per formazione, certo. Difatti, ancora oggi scriviamo di famiglie e di felicità mancate. E morto lo è perché, conclusi gli sperimentalismi, adesso sembra aver esaurito la propria carica rinnovatrice. Ma la realtà attorno a noi cambia. E con essa il linguaggio, e tutte le forme espressive. Anche il romanzo sta già cambiando, cercando linguaggi più inclusivi, che guardino a tutte le persone senza alcuna distinzione, non come oggetti ma come soggetti di una rappresentazione. Dove andrà, il romanzo? Non ne ho la più pallida idea. Ed è questo il bello. Il non sapere mi guida a provare, a scavare, a tentare nuove strade. O a scegliere di ripercorrere quelle che mi sembra mantengano intatta la loro forza.
La scrittura contemporanea può annoverare letterate illuminate, vere pioniere quanto a innovazione e rispetto della tradizione. Qual è l’attuale status della letteratura esperita da donne?
Grazie a Dio oggi leggiamo più autrici di qualche anno fa. Ahimè, però, se scaviamo dietro le solite note Morante, Ginzburg e Maraini, troveremmo un sottobosco fittissimo di scrittrice dimenticate o addirittura guardate con sospetto. Scrittrici meravigliose come Paola Masino, Fabrizia Ramondino, Marina Jarre e Anna Banti. Credo che le nuove generazioni di scrittrici che oggi si stanno facendo conoscere, da Marta Barone a Giulia Caminito, solo per citare le prime due che mi vengono in mente, siano ben consapevoli del grande processo di riscoperta, e di divulgazione, che deve essere fatto. Perché certe grandi scrittrici tornino a parlare a tutte e a tutti.
La letteratura romena si fregia di una robusta altresì varia produzione. Essa è costantemente tradotta in lingua italiana, con nomi di punta quali Ana Blandiana, Herta Müller, Mircea Cărtărescu, Emil Cioran, e la rivista «Orizzonti culturali italo-romeni» ne registra le pubblicazioni nel database Scrittori romeni in italiano: 1900-2021. Quali scrittori romeni hanno attirato la sua attenzione?
Purtroppo il peso che riveste in Italia temo sia ancora molto marginale. Ho letto Cioran con un gusto e una passione enorme. E poche volte ho pensato di dover «appendere la penna al chiodo», come di fronte ai fenomenali libri di Herta Müller (anche se credo di ricordare che scriva in tedesco, giusto?). Ah, e ho Solenoide di Cărtărescu accanto al letto che mi guarda male, ma non ho avuto ancora il tempo per affrontarlo. Giuro, me ne siete testimoni, che lo farò presto.
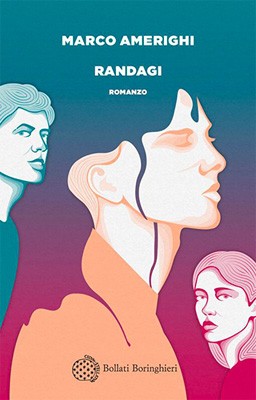
A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone
(n. 7-8, luglio-agosto 2022, anno XII)
|
|

 Nella sezione
Nella sezione