









|
|
Mario Baudino: «Stare fuori dalle mode, l’unica arma per rivendicare la propria libertà»
 Ospite dei nostri Incontri critici è Mario Baudino con il saggio Il teatro del letto. Storie notturne tra libri, eroi, fantasmi e donne fatali, edito da La nave di Teseo nel 2021. A partire da Guy de Maupassant con il suo breve racconto del 1882, Il letto, citato in apertura del libro («Il letto è tutta la nostra vita. Perché vi si nasce, vi si ama, e vi si muore»), l’autore costruisce un colto itinerario, tutto da scoprire, sui piaceri che la posizione orizzontale invita a cullare. Perché il letto «è il nostro teatro, il teatro del potere, dell’amore, della morte, in altre parole dell’io». Ospite dei nostri Incontri critici è Mario Baudino con il saggio Il teatro del letto. Storie notturne tra libri, eroi, fantasmi e donne fatali, edito da La nave di Teseo nel 2021. A partire da Guy de Maupassant con il suo breve racconto del 1882, Il letto, citato in apertura del libro («Il letto è tutta la nostra vita. Perché vi si nasce, vi si ama, e vi si muore»), l’autore costruisce un colto itinerario, tutto da scoprire, sui piaceri che la posizione orizzontale invita a cullare. Perché il letto «è il nostro teatro, il teatro del potere, dell’amore, della morte, in altre parole dell’io».
Nato a Chiusa Pesio (Cuneo) nel 1952, Mario Baudino vive a Torino dove svolge l’attività di giornalista per «La Stampa». Ha pubblicato le raccolte di poesie Aeropoema, Grazie e Colloqui con un vecchio nemico, tutte presso Guanda. È autore di saggi e di romanzi, fra cui ricordiamo Il sorriso della druida (Sperling & Kupfer 1998), Il mito che uccide (Longanesi 2004), Per amore o per ridere (Guanda 2008), Il gran rifiuto (Passigli 2009).
Da Ulisse ai giorni nostri, passando per Proust e Mark Twain, il dottor Johnson o il Re Sole, il letto è una scena teatrale almeno quanto è custode di segreti. Il teatro del letto. Storie notturne tra libri, eroi, fantasmi e donne fatali tesseuna ricca rassegna tra letteratura, arte e storia. Il letto racconta di noi? La sua storia è la nostra?
Ho cercato di raccontare il letto come oggetto culturale, tra arte e letteratura ma anche come oggetto fisico. Ha una storia abbastanza sorprendente, al di là del fatto che intorno alla sua forma in qualche modo «perfetta» sono state create nel tempo infinite variazioni. Il risultato è che ovviamente la «storia del letto» è la storia del nostro rapporto con esso. Attraverso direi soprattutto l’immaginario. Quindi sì, la nostra storia.
Emil Cioran scrive nei Quaderni: «Ho spento la luce e mi sono steso a letto. Il mondo esterno, di cui non sento che il brusio indistinto, ha smesso di esistere. Non resto che io e… Qui sta il punto. Certi eremiti sono vissuti trenta, quarant’anni in questo eccesso di silenzio e di muta conversazione con sé stessi. Perché non ho il coraggio di ripetere ogni giorno un’esperienza come questa?» Come risponderebbe a questa domanda?
Magari con il Baudelaire «poeta adorante e al sonno ostile»? Nei Diari intimi, per esempio, leggiamo: «A proposito del sonno, avventura sinistra di tutte le sere, si può dire che gli uomini si addormentano quotidianamente con un’audacia che sarebbe inintelligibile se non sapessimo che è il risultato dell’ignoranza del pericolo». Il letto e il sonno (il sogno e la morte) sono figure ambivalenti e direi drammatiche.
Nell’omologazione sempre più diffusa anche in campo letterario, come si può fare per scendere dal letto di Procuste?
I casi sono due: o attendere un nuovo Teseo che uccida il turpe ‘stiratore’ riservandogli la stessa sorte delle sue vittime, o provare a scrivere, come del resto ci insegna la tradizione, per amore o costrizione della letteratura, a prescindere dai luoghi comuni e dal comune sentire. Stare fuori dalle mode può essere sgradevole, almeno per certi aspetti materiali, ma in fondo è l’unica arma per rivendicare la propria libertà. Non dimentichiamo del resto che Teseo è l’eroe civilizzatore, e dal punto di vista degli ateniesi anche il padre della democrazia: non certo estranea almeno come necessità o obbiettivo anche al nostro mondo letterario, piccolo quanto si vuole.
Lei ha iniziato la sua carriera negli «anni di piombo» come cronista giudiziario presso il quotidiano torinese «La Gazzetta del popolo». Quanto si rinviene ancora nelle sue opere il piglio del cronista?
Questo forse non sta a me giudicare. Diciamo che credo di aver conservato l’istinto del cronista, la voglia di conoscere i fatti nel miglior modo possibile ma anche di riuscirci nel minor tempo possibile. Il che, quando si passa ad altri tipi di scrittura, o di lettura, o di studio, non è particolarmente d’aiuto. Devo così impormi, spesso, di ‘rallentare’. C’è però un altro aspetto notevole, che è quello di aver conservato il pudore del testimone. Nel mio vecchio giornale mi avevano insegnato che il cronista deve scomparire dietro il suo articolo (una volta che ero stato un po’ maltrattato da certi tipacci, e volevo scriverlo, il capo mi disse: Ricordati sempre che le sofferenze del cronista non fanno notizia). È stata un’esperienza molto formativa, nel momento forse più drammatico della nostra storia recente. Mi ha insegnato molto, soprattutto la vita vera, il non vergognarsi di aver paura e nello stesso tempo il non arretrare quando sono in gioco le cose importanti. Poi, va da sé, mi sono molto divertito. Tutto ciò non può non aver avuto effetti sulla scrittura – e del resto a quel periodo risale il mio primo libro di poesie.
La sua densa bibliografia annovera poesia e prosa: da La forza della disabitudine a Lo sguardo della farfalla, a esemplificare opere altresì premiate. Quanto reputa che differiscano in termini di impatto comunicativo nei tempi a noi coevi, così galoppanti?
Non ritengo la poesia una forma di comunicazione, ma di esplorazione del linguaggio come elemento costitutivo del nostro essere (quindi semmai anche «della» comunicazione). Una metafisica laica, se mi consente l’ossimoro. Al fondo, un’interrogazione sul destino. Con la poesia ci si mette in assonanza. Con la prosa è indubbiamente diverso, anche se nel mio caso ho sempre pensato a una prosa in fondo ironica e persino divertente, giocata sul calembour narrativo, quindi una forma di cordialità e di affratellamento con l’eventuale lettore: dove ognuno di noi due fa il suo gioco, appunto, senza necessariamente che sia del tutto simile e consentaneo reciprocamente. La letteratura in generale non «comunica» nulla, invita a un percorso comune. Il suo impatto «non comunicativo» fa sì che, oggi, cammini forse in una sorta di catacomba. O almeno, ogni tanto vi discenda, per trovare un senso al suo lavorio ininterrotto.
In Lei non sa chi sono io compì un’esplorazione nelle intricate e molteplici ragioni che hanno indotto tanti scrittori a firmarsi con uno pseudonimo. Ebbene, nell’era dei social il nickname è da interpretare con la stessa chiave di lettura di uno pseudonimo letterario?
Direi che sono diverse le motivazioni e anche la necessità specifiche. È vero che il nickname da una parte mette al riparo rispetto all’assunzione di una responsabilità piena per quel che si scrive, e dall’altra funziona un po’ come un nome d’arte, viene congegnato in modo da attirare l’attenzione; ma è anche vero che limita anziché esaltarla la libertà di chi lo sceglie, perché gli dà l’illusione di poter dire tutto, o qualsiasi cosa, o qualsiasi bizzarria e persino turpitudine, sfuggendo al confronto (tralasciamo ora gli aspetti penali che può talvolta implicare). Ma essere liberi vuol dire affrontare il confronto e il conflitto: con persone reali e non con fantasmi, considerato che i social sono popolati in misura notevolissima da account fantasma, che falsano e distorcono in modo propagandistico o affaristico la comunicazione.
Nel caso degli scrittori che ho un poco studiato, invece, lo pseudonimo ha sempre una funzione precisa (e soprattutto non truffaldina): presentare il proprio lavoro sotto diversi aspetti e non farsi condizionare dalla propria storia pubblica (come accade in Romain Gary) o superare diffidenze e stigmi sociali di una cultura maschile e maschilista (come accade alle sorelle Brontë o a George Eliot, o in certi casi a scrittrici e scrittori omosessuali), aggirare la censura, proporre anche nello pseudonimo stesso una chiave di lettura (Stendhal), eseguire un vero e proprio esperimento letterario senza rischiare la reputazione in caso di fallimento (Walter Scott), sfuggire alle noie del successo (come parrebbe per la Ferrante). In ogni caso, tutti vengono però influenzati profondamente da questo secondo io che assume dimensioni autonome, diventa una sorta di doppio, ha una vita propria.
Ne Lo sguardo della Farfalla tratteggia personaggi avviluppati dalle sabbie mobili della lettura. La sua personale esperienza di organizzatore di festival ed eventi letterari quale testimonianza può offrire circa il rapporto che oggi intercorre tra giovani e lettura?
Diciamo che quando si organizza un evento, pur senza dirlo esplicitamente, si finisce per ragionare in un certo modo. Ovvero, abbiamo un tema che riteniamo importante ma che potrebbe non essere troppo popolare, e della sale da riempire perché l’assessore, il sindaco, lo sponsor ci tallonano. E dunque invitiamo ‘anche’ il romanziere televisivo, il filosofo alla moda o la soubrette intellettuale, non si sa mai. Accade poi che gli incontri più problematici ottengano un bel successo, magari anche di giovani: i quali come si sa leggono molto fantasy, fumetti e soprattutto manga, ma non disdegnano certo proposte più difficili e significative. Io penso che il pubblico italiano sia piuttosto maturo, in tutte le fasce d’età, e si divida per gusti e opzioni in modo più o meno analogo. Ho visto cosplayer anche cinquantenni alle fiere del fumetto, e non pochi. Ho visto platee ‘intellettuali’ sghignazzare in coro davanti all’affermazione che Proust è una vera barba, insomma, come tutti voi e tutti noi, ho visto cose… Detto questo ognuno ha il diritto di leggere quel che gli pare, e a me non sembra che i lettori italiani (sono relativamente pochi, ma questa è un’altra storia) lo esercitino poi così male.
Il medico Samuel-Auguste Tissot in un trattato dal titolo De la santé des gens de lettres «associava le malattie nervose all’eccesso di lettura, soprattutto in campo femminile». Oggi, il mercato editoriale vanta numerosissime autrici. Ritiene che si possa scorgere uno specifico tratto muliebre nella produzione letteraria?
Il romanzo, genere borghese per eccellenza, ha avuto fin dalle origini un pubblico, se non a maggioranza femminile, almeno tradizionalmente considerato come un universo di ‘lettrici’ più che di lettori. Recupero un vecchio appunto relativo ad Albert Thibaudet, critico francese che nel 1926, in un libro sulla storia del romanzo dal punto di vista della diffusione e della ricezione, rifletteva sulla «comparsa» delle donne tra il nuovo pubblico dei lettori – un fenomeno che pure aveva ormai più di un secolo alle spalle – definendola «insieme alla scoperta della stampa, la più grande rivoluzione letteraria dell’Occidente». Perché, aggiungeva, «il romanzo sono le donne, generalmente scritto su di loro, spesso per loro, talvolta da loro». Non andrà dimenticato del resto che già nel Decamerone le narratrici sono sette, contro tre maschi, anche se ancora nell’Ottocento il «bovarismo» ossia la dipendenza femminile da romanzi sentimentali (chiamato anche «novellismo»), venne considerato dal punto di vista psichiatrico una sorta di male del secolo.
Ormai il sorpasso è avvenuto da tempo, sarebbe da vedere se anche dal punto di vista delle scrittrici sugli scrittori maschi. A naso, direi di sì. E che esista un tratto specifico legato al sesso a me parrebbe indubbio, si scrive sempre partendo da esperienze personali (va da sé che «ci vuole orecchio», come cantava Jannacci): non lo vedrei nei temi quanto nella grammatica stessa del narrare. Mi pare che da parte femminile sia molto più presente un certo autobiografismo (diverso dalla cosiddetta autofiction), ma queste sono alla fin fine impressioni personali. Per tornar agli pseudonimi, quando George Eliot (ovvero Mary Anne Evans) pubblicò il suo primo romano, Scene di vita clericale, Charles Dickens ne fu entusiasta al punto di scriverle – tramite la casa editrice – una lettera che cominciava ovviamente con «Dear Sir» e manifestava però molte perplessità sul sesso dell’autore. «Credo di dover adottare il nome che l’eccellente scrittore ha scelto di assumere. Non ne potrei suggerire uno migliore; ma sarei stato fortemente tentato… di rivolgermi a lui come a una donna».
Può darsi che già avesse annusato qualcosa nella società letteraria londinese, che avesse intercettato un qualche pettegolezzo, però è una lettera che mi colpito. Dickens aveva indubbiamente orecchio.
Un libro da leggere, forse a letto, senz’altro mettendosi comodi, così come «suggerisce Cervantes nel rivolgersi, presentando il suo Don Chisciotte, al desocupado lector, ossia qualcuno che abbia tempo, calma, serenità e anche uno spazio adeguato dove sistemarsi». Può regalare ai nostri lettori un consiglio di lettura?
Qualsiasi libro è ottimo da leggere a letto, purché il formato non sia esorbitante. Sconsiglierei dunque, per i fortunati (pochissimi, pare una ventina nel mondo) che ne posseggono almeno alcuni volumi, la venerata edizione di Shakespeare del 1623, il First Folio (d’altronde, se ne guardano bene: vale milioni di dollari, o a scelta di euro). Nella fattispecie, per le lunghe notti e anche per i pigri pomeriggi d’agosto, avrei due opzioni: una è Balzac, per i più avventurosi. Qualsiasi titolo delle Commedia Umana (sono 90, mi pare, c’è da scegliere), se si è digiuni cominciando magari da Papà Goriot o meglio ancora dalle Illusioni perdute, per proseguire poi con Splendori e miserie delle cortigiane e tornare infine a Goriot, dove si annidano già i personaggi principali degli altri due romanzi. È una cavalcata, una corsa senza fiato, farà della nostra estate una grande avventura. Per i più ‘desocupados’, e che hanno intenzione di rimanere tali, l’agile Italo Calvino di Se una notte d’inverno un viaggiatore, dove fra l’altro l’iniziale apostrofe al lettore suona come una ironica, amabile, insistita ripresa proprio di Cervantes.
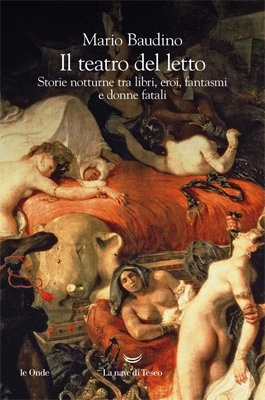
A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone
(n. 9, settembre 2022, anno XII)
|
|

