









|
|
Rosaria Catanoso: «L’anima romena è un’anima in esilio»
 Continua la nostra inchiesta, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, nel campo della critica letteraria, con diversi argomenti di attualità e un'ampia indagine sulla ricezione della letteratura romena in Italia, un tema di particolare interesse per noi. Continua la nostra inchiesta, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, nel campo della critica letteraria, con diversi argomenti di attualità e un'ampia indagine sulla ricezione della letteratura romena in Italia, un tema di particolare interesse per noi.
Ospite dei nostri Incontri critici è Rosaria Catanoso, dottoressa di Ricerca in Metodologie della Filosofia. Insegna filosofia nei licei e collabora con la cattedra di Filosofia Politica del corso di laurea in Filosofia del Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università della Calabria. Membro del Centro per la Filosofia Italiana, pubblica studi e contributi sulla rivista di cultura «Tempo Presente», sul mensile «Segno», sui siti www. dialettica&filosofia.it e www.filosofiainmovimento.it. Ha pubblicato l’ampia monografia Hannah Arendt. Imprevisto ed eccezione lo stupore della storia (Giappichelli, Torino, 2019). È autrice di numerosi studi sulla Arendt, con particolare riferimento alla questione del giudizio e dell’azione politica.
La nostra intervista parte da Rapporto sul sapere. L’intellettuale nel tramonto della politica (Fondazione Giacomo Matteotti, 2021), un libro che ha lo scopo di comprendere quale sia il posto ricoperto oggi dai pensatori di professione. L’intento è ricercare una connessione critica tra la filosofia, intesa come pensiero speculativo, e il vivere quotidiano. Nell’era dell'economia del sapere è necessario ricreare una sfera pubblica in cui gli intellettuali e le masse possano tornare a dialogare in una dimensione agita e consapevole.
«La fine della politica come grande narrazione ha condotto all’ineffettualità dell’intellettuale? In altre parole, c’è un legame tra la fine delle grandi ideologie novecentesche e la crisi in cui versa la figura dell’intellettuale?» Lei pone questi quesiti al termine del suo lavoro, ma può definire un «intellettuale»?
In verità, al di fuori delle utopie e delle ideologie che inevitabilmente sono connesse alla figura dell’intellettuale, è in una dimensione meno carica di attese messianiche che sarà possibile immaginare un modello di intellettuale dalle caratteristiche più interessanti. Ben lungi dall’identificarsi con una vaga propensione culturale, o con un’inclinazione per sterili speculazioni filosofiche, a distinguerlo dovrà essere la capacità di appropriarsi di quei margini di libertà che ogni società non offre sempre spontaneamente, ma consente. In un clima costellato da un relativismo valoriale, o con le parole Weber politeismo di valori, la libertà è il solo al quale non possiamo e non dobbiamo rinunciare. Al termine del mio lavoro, una raffigurazione – pur sommessa – ritengo doveroso tratteggiarla. L’esigenza avvertita come impellente è di nuove autorevolezze, forse più umili, meno presuntuose e meno palingenetiche. Se l’intellettuale occidentale è stato contraddistinto fondamentalmente dalla presenza più o meno equilibrata di un pensiero forte e allo stesso tempo critico; allo stato attuale si può, in un certo qual modo, far a meno di chi ricerchi grandi progetti e alti obiettivi. Potremmo essere disposti a rinunciare a grandi obiettivi che abbiano come scopo la critica dell’esistente e che ne vogliano indicare un superamento. Non ci sono riferimenti, latu sensu, a operazioni politiche. Ne abbiamo avute fin troppe. Non sarebbe sbagliato scegliere un percorso più moderato. Non ci staremmo accontentando, se volessimo navigare a vista. Le questioni da affrontare sono tutte intricate e interconnesse, che richiedono uno stravolgimento talmente grande da sembrare irrealizzabile. Un percorso, quindi, per prove ed errori può risultare meno utopico, e più vicino allo stato esistente.
Qual è oggi la condizione dell’intellettuale?
Le riflessioni espresse nel volume vogliono comprendere i mutamenti cui è incorso l’intellettuale, cercando di rimanere a galla in un tempo in cui sembra esser stato surclassato da influencer, che già nel nome hanno in forma intrinseca il dato d’influire sui loro seguaci. Negare un cambiamento di rotta equivale a rimanere estranei alla propria epoca, e così essere esclusi dalla possibilità di leggerla criticamente. Non verrà meno la cultura, non verranno meno i maestri, gli studiosi; ma sembra ormai mutata l’esigenza di trovare in tali figure simboli e modelli cui far riferimento.
Fuori da ogni prospettiva rivoluzionaria, l’intellettuale è pressoché inutile. Amara constatazione. Abdicare alla rivoluzione, però, significa esiliare coloro che alla stessa hanno sempre incitato le masse. Il punto, quindi, non è tanto che nella società odierna l’intellettuale non conti, o valga meno di un tempo; ma che a costui venga richiesto d’espletare mansioni specifiche che spaziano dalla progettazione al coordinamento, alla comprensione delle condizioni di possibilità di un progetto. Emergono figure nuove, manager, responsabili, esperti in pubbliche relazioni, in questa condizione diventa pressoché impossibile parlare di lavoro intellettuale in maniera generalizzata e univoca. Entro meglio nel dettaglio. Dopo aver osservato la crisi in cui versa la figura sociale dell’intellettuale; dopo essermi soffermata sul dilagante potere virtuale degli influencer – che ha abbattuto i limiti, sempre esistiti, tra massa ed élite – rendendo quasi attingibile la fama e la notorietà; il punto conclusivo diventa il rapporto tra intellettuali e mass media nel momento in cui questi mezzi offuscano, oltre alla figura del chierico anche la verità di cui, da sempre, costoro si sentivano portavoce. Esprimere la verità, quindi, va di pari passo con il suo perseguimento; mascherare quella verità conduce alla marginalità dell’intellettuale che si perde nel caos mediatico delle opinioni.
Entriamo qui nell’ambito delle caratteristiche imprescindibili degli intellettuali.
A dispetto delle opinioni, c’è qualcosa che appare insindacabile quale caratterista degli intellettuali. La giustizia e la verità sono i due valori inderogabili. Essere uomini di giustizia e di verità è una peculiare forma di cittadinanza attiva, il cui esito può non essere immediatamente visibile nella sfera pubblica, ma il cui valore rimane a salvaguardia della democrazia. La figura da me tracciata per certi versi ricorda Bobbio e Benda, modelli di uomini liberi che hanno tenuto alta e accesa la fiaccola dei valori non pratici. Non si chiede più di cambiare il mondo, consapevoli che da soli sia impossibile. Ma di custodire, senza mezzi termini la fedeltà a valori intramontabili. I cambiamenti e i progressi tecnici richiedono la weberiana etica delle intenzioni o dei principi. Sostenere e promuovere un tale modello etico fa dell’intellettuale il custode della tradizione cui apparteniamo. Un testamento, forse, dai toni tragici – come ci ricordano le recenti riflessioni promosse da Salvatore Natoli – perché invita ciascuno a reggere alle sconfitte e alle perdite che ci affliggono senza mai cedere e al contempo saper fruire al meglio di ciò che la vita offre: goderla. Dobbiamo fare del pensiero una zona di resistenza, fino a generare forme dal sapore anarchico, ma organizzate istituzionalmente.
Chi sarà così l’intellettuale del Ventunesimo secolo?
Penso un individuo consapevole dell’infinità del desiderio umano e del suo essere continuamente esposto allo scacco e alla delusione. Sarà in grado di fare grandi cose, senza però ridurre gli altri ai propri interessi e alle proprie voglie. Senza misconoscerli nella loro unicità e verità. Sarà in grado di cogliere come la felicità non stia nelle cose e nei beni, ma nel giusto rapporto con gli altri e con il mondo. Seguirà la legge convinto che sia in primo luogo un dispositivo di relazione. L’esistenza umana è, infatti, un tessuto di relazioni e per questo la legge prima ancora d’avere un valore deontologico ne ha uno ontologico. La figura, quindi, non è più di un solitario pensatore chino sui libri. Gobbo. Seduto. Comodo al suo scrittoio. Pensare, attività da sempre vissuta in solitaria, deve essere una facoltà condivisa, allo scopo di ritrovare – ovunque – quel comune sapere utile a trasformare in modo integrale le nostre vite.
«Perdiamo tre quarti di noi stessi per diventare simili agli altri» scrive Schopenhauer. Stiamo perdendo la capacità di pensare in modo autonomo, originale e creativo? L’intellettuale può riuscire a esprimersi attraverso i media non divenendo funzionale al recital virtuale che, oggi, pare essenziale a raggiungere i più?
Ecco la domanda imprescindibile. Questa è la questione che ha mosso tutta la mia ricerca. Per risponderle, ho dovuto cogliere quella differenza sostanziale non solo tra influencer e intellettuali, ma tra l’uso che questi due diversi personaggi compiono dei social media. Da tempo ormai la cultura si è trasformata da oggetto d’uso a merce, modificando la funzione storica dell’intellettuale. Cronologicamente, questa trasformazione prende avvio già con la seconda rivoluzione industriale. La cultura ha cessato di essere prodotta per i suoi diretti destinatari, il suo valore d’uso si è presto tramutato in valore d’uso sociale, diventando un oggetto di scambio e acquisendone un valore economico. Gli studiosi delle scienze sociali, nel Novecento, si sono interessati a questo processo chiamato «industria culturale», al punto in cui i suoi prodotti sono diventati oggetti di consumo. Per soddisfare un pubblico sempre più vasto i prodotti culturali devono presentarsi come perenne novità, come ha rilevato Baudrillard. L’intellettuale deve distinguersi, deve attrarre l’attenzione e mettere in mostra le sue creazioni.
Quindi cosa ne è dell’intellettuale allorché la cultura abbia fatto il suo ingresso all’interno della spettacolarizzazione proposta dal mercato capitalistico?
Anche l’intellettuale si trova dentro questo ingranaggio, dal quale fatica a uscire, pena la perdita di un posto nel mondo che dia risonanza alle sue parole. Già Benjamin negli anni Trenta ha tratteggiato il mutamento culturale generato dai processi produttivi. Nell’era del web, tutto ciò è ancora più plateale. Il passaggio tecnologico nel quale siamo immersi non è analogo a quelli precedenti, ma di una portata ancora più dirompente. Il cambiamento generato dai mezzi di comunicazione di massa, dal virtuale, dal web è di gran lunga maggiore rispetto a quello introdotto da Gutenberg. Eppure una tale rivoluzione ha come conseguenza la parabola discendente degli intellettuali. Scevri da ogni commento moraleggiante sulla decadenza dei costumi, seguendo le orme già tracciate da Eco, nel proverbiale saggio che ha segnato il nostro approccio alla cultura di massa, vogliamo stigmatizzare l’atteggiamento del critico apocalittico che coglie nella cultura di massa solo anticultura. Quindi, non si vuol ritenere, a dispetto degli apocalittici, che gli intellettuali siano la prima e più illustre vittima del prodotto di massa. Qui si vuol cogliere come i mezzi di comunicazione di massa abbiano inciso sull’intellettuale tradizionale. Costui può contare sulla parola scritta. Nella grande comunicazione mediatica, il linguaggio scritto risulta essere sempre più marginale. Lo stile è volatile, svincolato da ogni rapporto con il patrimonio semantico della lingua. Ogni discorso è semplificato. I post su instagram sono l’emblema di come si possano adoperare foto e immagini accompagnate da parole addirittura sgrammaticate. Connettersi e interagire sono diventati i sostituti dell’aver qualcosa da dire. Il linguaggio è semplice ai confini con la banalità, accessibile a tutti, scevro da colte argomentazioni, privo di un lessico ricercato. Questi elementi lo connotano, di certo, per democraticità. Dalla coesistenza di vecchi e nuovi media, dal continuo scambio tra giornali, cinema, televisione e social network, si è giunti al punto in cui questi ultimi consentono la visione dei primi. Già la televisione, pur avendo superato agevolmente tutte le barriere costituite dall’analfabetismo, dall’assenza di cultura e perfino dalle differenze politiche e ideologiche, non ha promosso nuove figure intellettuali che ereditassero lo spirito critico e l’autonomia di giudizio. Ecco, spirito critico e autonomia nel giudicare sono i due elementi del pensare da sé che occorre salvaguardare. E per tutelarli serve esercizio, servono nuove ‘posture’, allenamenti mentali e fisici. Serve un lavoro. C’è ancora bisogno di pensatori. Al passo con i tempi, che spicchino in mezzo a individui mediocri, indistinti e in cerca di like. Costoro non saranno saccenti o superbi, ma saranno consapevoli degli strumenti a loro disposizione, ma ancor più della loro natura e non avranno bisogno dei social per esistere, ma li adopereranno quali nuove possibilità. Ecco come stiamo facendo noi; come da tempo fanno gli autori di Tlon, come tentano di mettere in atto i nuovi filosofi pop. Le strade stanno mostrando un pensiero in comune, in un mondo in cammino.
Avvalersi dell’arma del dubbio, dell’arte di ascoltare e di porre domande, di interrogarsi e di scolpirsi come «una statua», come direbbe Plotino, potremmo abituarci a pensare «out of the box»? È il like il responsabile del declino del pensiero critico?
I social e i software hanno amplificato la possibilità di comunicare universalmente, ma non hanno davvero incrementato la capacità del pensiero di elaborare. L’universalità della comunicazione necessita di un nuovo modello culturale. Le nuove tecnologie di informazione e di comunicazione non hanno ancora creato una nuova cultura. E così la crescente e smisurata diffusione degli strumenti di informazione dà vita anche a forme sempre più omogenee del vivere e del pensare. Questa forma di omologazione universale attraversa tutti i campi, dal cibo all’informazione, dalla politica alla cultura. Una civiltà unica mondiale rischia d’essere il nostro destino. Gli strumenti tecnologici contemporanei informano, offrono possibilità creative e riproduttive, ma non agevolano un processo critico. Quel che spaventa è la possibilità d’essere a conoscenza di molte cose, pur senza aver letto un saggio, un romanzo o aver visto un’opera d’arte. I nuovi mezzi di comunicazione non mostrano grandi personalità, spiccano individui mediocri, indistinti che cercano riconoscimenti, applausi e like. Individui banali hanno come solo desiderio quello di partecipare, allo scopo di sentirsi inclusi e considerati. Riconoscersi, sentire gli stessi gusti avvicina agli altri. Non è il gusto il riferimento con il quale digitiamo il nostro like anche sui social? Non è forse la ricerca di un comune sentire che ci spinge a cercare consenso? Il riferimento al gusto rimanda al kantiano giudizio estetico, vale a dire a una facoltà in grado di cogliere i fenomeni direttamente. Ed è questa capacità della ragione di cui si sente cogente la necessità, di un giudizio che nasca da un puro piacere contemplativo. Il piacere, quale sentimento peculiare che intensifica una sensazione legata a un oggetto, vuole essere condiviso e comunicato. Si aspira ad avere l’assenso degli altri. Il gusto, da argomento tipicamente settecentesco dell’incomunicabilità e della privatezza delle sensazioni, delle modalità attraverso cui trasmetterle e comunicarle, determina le nostre scelte, da quelle politiche a quelle commerciali. Pronunciarsi su ciò che piace o non piace è un modo per rivelare le proprie affinità, ricercando ciò che è comune. In questo modo ci si scopre legati agli altri nel momento in cui si ritrovano affinità su ciò che piace o dispiace. Il gusto non è più qualcosa di intimo e personale, ma rivelativo di se stessi aiutandoci a mostrare per quel che si è. L’esercizio del gusto ricrea le condizioni per un confronto e una condivisone con gli altri.
È palesemente in atto un deciso svilimento dell’idea di politica, concepita non più come interesse alla res pubblica bensì quale interesse individuale e privato. Come può l’intellettuale risanare questa ferita, divenendo soggetto «agente»?
Lo scopo al quale sono chiamati – da fronti diversi – intellettuali, pensatori, politologi, filosofi, scienziati, tecnici è ricostruire l’identità della politica, riprendendo a familiarizzare con le «visioni del mondo». Del resto, senza un pensiero critico del presente, e alternativo a questo nostro presente, la politica diventerà subalterna al corso destinale della storia, non riuscendo, in qualche modo – per quel che è possibile – a prevederlo allo scopo di contrastare le circostanze nefaste e di modificare i fatti. Se i pensatori dell’età moderna non hanno mai smesso di cercare i fondamenti della logica, della moralità, dell’estetica, dei precetti culturali, delle regole del vivere civile, e non hanno mai smesso di credere che la ricerca avrebbe avuto successo; l’epoca attuale si caratterizza per aver smarrito una verità universale. In questa civiltà massmediatica ogni singolo fenomeno assurge a verità assoluta. Le opinioni contano più dei fatti. Tutto è contemporaneamente vero e falso. Discutibile. Argomentabile. Eppure si è esaurita la critica, la cui funzione non è consistita nell’affermare verità assolute, ma nel gerarchizzare e nel pensare da sé. Il giudizio diviene imprescindibile per formulare una teoria etica che risponda alle problematiche della vita politica, e per ricucire il legame tra filosofia e azione, tra teoria e pratica. Siamo dinanzi a un nuovo sistema culturale, valoriale, scientifico in cui tutto diventa opinabile. In questo quadro, l’intellettuale non può più stabilire gerarchie e valori. Eppure il pensiero critico non può eclissarsi. Scompaiono le figure che presumevano d’aver diritto di far lezione alla storia, ma non può scomparire il pensiero radicato, com’è, nella storia dell’Occidente. Ecco perché appare sempre più diffusa la domanda di maestri, di esempi, proprio per il loro essere figure concrete con una valenza significativa in grado di trascendere un caso particolare, che diventa valido per ogni altro caso. I maestri, di cui non possiamo fare a meno hanno come compito quello di fornire indicazioni. Nella loro esemplarità orientano gesti, simboleggiano quel dovere morale di giudicare, di prendere posizione in modo autonomo di fronte agli eventi.
L’intellettuale, alla luce delle sue riflessioni, può intendersi come paradigma dell’umanità?
Una bella speranza, oltre che un augurio importante in questi tempi difficili. Del resto, sono proprio consapevole che siamo in un mare aperto. E non possiamo più credere di risolvere da soli i problemi Degli altri abbiamo un bisogno imprescindibile, e innato. In antitesi a pensatori solitari, immagino un pensare insieme. Pensare, attività da sempre vissuta in solitaria, deve, invece, essere condiviso. Lo scopo è proprio rompere quell’intricato legame tra il singolo e i social, per ritornare alle relazioni tra gli individui. Senza demonizzare la tecnologia, bisogna riscoprire un pensare in comune, allo scopo di mettere il sapere in circolo. Il nostro io non è altro che il nodo che potenzialmente lega tutte le persone e gli eventi che hanno contribuito a formarlo, un pensare insieme mette in contatto anche gli altri, in carne e ossa. A dispetto di tutti gli intellettuali disincarnati, parlare di vita concreta, sensibile, corporea mette in comune i problemi e i bisogni, le possibilità e le novità.
Quindi, non basta una filosofia ridotta a teoria, a dottrina e a discorso, ma bisogna proporre una filosofia nelle vesti di ethos per vedere trasformata la propria esistenza e quella altrui. Non ci si salva da soli. Le azioni da compiere vanno pensate, prima d’essere programmate, studiate e attuate. Non c’è scelta intrapresa, senza pensiero meditato.
Qual è lo status attuale della critica in Italia, come istituzione culturale e manifestazione del pensiero critico?
La vera questione non è relativa alle singole personalità, bensì collettiva. In un tempo in cui la cultura si è trasformata da oggetto d’uso a merce, la funzione storica dell’intellettuale è radicalmente mutata. Una trasformazione profonda, lenta e apparentemente ineludibile ha avuto luogo in forma sempre più intensa, lungo gli ultimi cento anni. Un tale passaggio investa anche coloro che della cultura sono i diretti esponenti. Dagli inizi del Novecento in avanti, l’industria culturale è stata oggetto di ricerche e di sperimentazioni tecnicamente e socialmente all’avanguardia, volte a migliorare le prestazioni e ad aumentarne gli utili; divenendo oggetto di sfruttamento intensivo e di operazioni a carattere politico. Questo ha avuto conseguenze tanto positive quanto negative per gli intellettuali, proprio perché costoro se da un lato hanno denunciato un sistema del quale non accettavano le fondamenta, dall’altro sono sempre stati all’interno dello stesso sistema che criticavano. Quindi, in certi casi, apparivano scomodi o quanto meno incapaci di risolvere quella che per certi versi sembrava essere una krísis, nel suo significato etimologico. Quindi, chiediamoci, cosa ne è dell’intellettuale allorché la cultura abbia fatto il suo ingresso all’interno della spettacolarizzazione proposta dal mercato capitalistico? Anche l’intellettuale si trova dentro questo ingranaggio, dal quale fatica a uscire, pena la perdita di un posto nel mondo che dia risonanza alle sue parole. E così si trova a rivestir il ruolo di creatore di spettacoli, o quanto meno di una messa in forma della sua produzione artistica e creativa anche, ama non solo, allo scopo di vendere e di essere attrattivo per il pubblico. Quel che si ripropone come questione cruciale, non è tanto l’originalità degli intellettuali contemporanei, rispetto ai loro predecessori; né l’estrosità dei loro precorsi culturali rispetto ai presunti canoni dei periodi storici precedenti. E ancora la questione non è neppure la collocazione degli intellettuali all’interno della società in cui vivono. Il cuore del discorso è quale posizione occupino gli intellettuali nei circuiti produttivi attuali. Queste figure si sono trovate, anche, a dover conferire all’esercizio della propria professione un carattere altamente spettacolare soprattutto per riscuotere quel riconoscimento e quella fama degne delle loro scoperte e delle loro opere. Da un’idea sono giunti a formulare una visione totale completamente alternativa al mondo reale. Quindi, hanno ripensato radicalmente la società. Anche se sotto il profilo pubblicistico, costoro si sono dovuti mostrare in grado di rendere funzionale la propria attività. Questo significa non assolvere meramente a compiti tecnici, di semplice illustrazione e divulgazione dei progetti, né nell’affermare valori esclusivamente ideologici o letterari; ma adottando la forma del manifesto, del pamphlet, dello scritto polemico, le opere di queste personalità si presentano come vere crociate combattute con le armi della critica. Tali elementi sono finalizzati a fornire ogni fondamento che dia un supporto concreto e tangibile alle idee proposte. Quel che è indubbiamente visibile è la mescolanza tra letteratura e politica da parte dell’engagement intellettuale, giungendo a un’identificazione tra pensiero e azione. L’attività è sempre una critica delle ideologie e, in quanto tale, politica mitigata dall’arte, che non smette di esporre un vero e proprio programma. Infatti, attraverso la pacifica e proficua convivenza e integrazione di attività progettuale e attività culturale che alcuni dei principali protagonisti italiani acquisiranno autorevolezza a livello internazionale, conferendo anche all’Italia un singolare primato nella produzione di intellettuali. Gli ambiti culturali sono ampi, pensiamo al Gruppo 63, con le riviste a esso correlate come «Marcatré» e «Quindici», e «Tempo Presente-Rivista di cultura» ancora riviste apertamente politiche come «Contropiano» diretta da Alberto Asor Rosa e Massimo Cacciari, espressione della corrente operaista nel periodo a cavallo tra anni Sessanta e Settanta. L’unione del paradigma estetico con quello etico e politico ha lo scopo di rilanciare il territorio italiano dopo il secondo conflitto monde e il ventennio fascista. Questi progetti culturali si ispirano all’intellettuale politicamente impegnato che domina la scena nell’Italia degli anni Cinquanta, erede a sua volta della concezione gramsciana dell’intellettuale organico, inteso come costruttore e non come semplice oratore, pronto a scendere in campo e a mescolarsi con la comunità. Strettamente legate a questo clima culturale sono le riviste «Critica marxista», «Il Contemporaneo», «Società», «Voce comunista». Si ricordino «Quaderni Rossi», sorta agli inizi degli anni Sessanta e segnata dalla prematura scomparsa del fondatore Raniero Panzieri. Inoltre, «Classe operaia» è sorta agli inizi del 1964 dopo l’abbandono di Tronti a «Quaderni Rossi» che si troverà a scrivere insieme ad Asor Rosa, a Cacciari e a Negri. Questi intellettuali tuonano contro le organizzazioni ufficiali del movimento operaio, prendendo le distanze dal Partito comunista italiano e dai sindacati. Il loro obiettivo è dare risonanza alla condizione di sfruttamento della forza lavoro all’interno del sistema capitalistico, senza limitarsi alla classe operaia, ma ascoltando anche le voci della borghesia e della medesima classe intellettuale. Si sta definendo l’esatta funzione dell’intellettuale italiano, degli anni Settanta, come colui in grado di mettere a punto un apparato teorico utilizzabile in vista di un agire pratico, al di fuori di qualsiasi prospettiva personale o soggettiva, ma considerando la natura collettiva e condivisa della cultura. Il tentativo di questi gruppi intellettuali è di conferire nuovo vigore alla lotta di classe, in un momento politicamente delicato. L’intellettuale, desideroso di costruire un radicale cambiamento della società, a partire dalle condizioni esistenti, cerca un panorama autonomo per la propria azione, si porrà nella posizione espressa da Tronti «dentro la società e contro di essa nello stesso tempo».
La democratizzazione del sapere e la diffusione generalizzata del lavoro intellettuale, con la conseguenza dell’accrescersi di un pensiero operante, vale a dire di una teoresi direttamente applicata ai contesti produttivi e comunicativi, hanno come esito una sorta di sorprendente speranza in merito alla possibilità di una futura rinascita di un pensiero discorrente, dialogico, capace in ultima analisi di tornare a scompaginare l’appiattimento della nostra visione del mondo. Trascorsi anni, mutati gli eventi lo scenario attuale mostra una complessità globale. Le trasformazioni del mondo contemporaneo sono immense. La storia della cultura e della critica è tutta tratteggiata dai traumi legati ai passaggi storici dovuti alla tecnologia, cambiamenti percepiti come minacce. Nell’era del web, tutto ciò è ancora più plateale. Il passaggio tecnologico nel quale siamo immersi è ancora più dirompente dei precedenti mutamenti. Come nota Furedi, nel Ventesimo secolo, l’immagine eroica dell’intellettuale classico ha lasciato il posto a una figura più pragmatica e terra terra, il cui lavoro non ha un’importanza particolare. Le notizie viaggiano su vari canali comunicativi, duplicando le possibilità del sapere, senza aumentare quelle della conoscenza. I social e si software hanno amplificato la possibilità di comunicare universalmente, ma non hanno davvero incrementato la capacità del pensiero di elaborare. La crescente e smisurata diffusione degli strumenti di informazione dà vita anche a forme sempre più omogenee del vivere e del pensare. I nuovi mezzi di comunicazione non mostrano grandi personalità, spiccano, invece, individui mediocri, indistinti che cercano riconoscimenti, applausi e like.
In Italia, però, a tutto questo si risponde con numerosi momenti culturali, festival, blog dai quali prendono forma progetti e percorsi volti a mischiare arte, spettacolo, filosofia, scienza. Il pensiero critico è vivo. Fluttua sulla rete. Si mescola alle esigenze dei tempi e ai nuovi giovani fruitori. Parla nuovi linguaggi e forme espressive. Scompaiono le figure che presumevano d’aver diritto di far lezione alla storia, ma non può scomparire il pensiero radicato nella storia dell’Occidente.
Quali direzioni, mete o deviazioni vede attualmente caratterizzare il panorama culturale italiano e internazionale?
In Italia gli intellettuali non sono rassegnati a ricoprire spazi ristretti nei salotti televisivi durante i quali poter presentare le proprie pubblicazioni. In molti casi diventano accattivanti protagonisti dei festival filosofici, delle scuole di cultura politica. In altre circostanze sono firmatari di appelli in difesa della scuola, dell’università e della ricerca. E di recenti si sono espressi in favore della pace sulle pagine di un noto quotidiano.
Da Weber a Berlin, da Jaspers a Heller, da Gramsci a Ingrao, da Bobbio a Barcellona, da Garin a Cacciari, il panorama europeo è stato e continua a essere ricco di studiosi il cui fare mostra il legame tra pensiero e azione, tra speculazione e ammonizione. Se Rovatti e Vattimo, negli anni Ottanta, hanno dato vita a un pensiero debole, a un filone della filosofia contemporanea che ridimensiona le pretese metafisiche e totalizzanti, non hanno mai smesso di lottare in favore dell’alterità contro il fondamentalismo della ragione, contro le barbarie della violenza e della tecnica, in opposizione a un potere che depaupera le relazioni tra gli individui. Il panorama italiano ed europeo è ricco di figure pubbliche critiche, capaci di scalfire e porre in discussione il sistema e il potere. Del resto, nel momento in cui Rovatti propone dì associare l’aggettivo riluttante all’intellettuale immagina una figura che si collochi all’interno dei dispositivi di potere e vi svolga un lavoro ai fianchi denunciando le chiusure senza mai gettare la spugna. Questa ci pare una condizione non facile, ma sostenibile. Quindi, una figura responsabile, che abbia da rispondere a coloro che ne ascoltano le parole e che dia risposte per mezzo dell’azione compiuta. Su questo è d’accordo anche Chomsky, consapevole del fatto che coloro ai quali viene riconosciuto tale titolo possiedono un certo grado di privilegio conferito da questo status, con opportunità fuori dal comune. Ma alle opportunità si accompagnano le responsabilità, che a loro volta impongono scelte, talvolta difficili. Si è responsabili solo se integri moralmente. Rinunciando a servire fedelmente il potere, si potrà esercitare una critica serrata che abbia come perno l’esaltazione della giustizia. Quel che dagli intellettuali non ci si deve aspettare è il proporre teorie ex cathedra per le quali non si indichi neppure una documentazione. Contro il culto dell’esperto tout court, rilanciare il modello di un intellettuale indipendente vorrà dire privilegiare figure consapevoli dei meccanismi ideologici messi in atto dalle forme di potere illiberale e antidemocratico. Quindi una delle maggiori responsabilità degli intellettuali consiste nell’analizzare le azioni dei governi in base a cause e moventi spesso occultati. Le democrazie liberali garantiscono tali possibilità in virtù del libero accesso alle fonti d’informazione e alla libertà di espressione. Date queste condizioni è responsabilità degli intellettuali dire la verità e denunciare le menzogne.
Contro la rassegnazione, a dispetto di ogni sfiducia nei riguardi delle istituzioni, la lotta dell’intellettuale deve essere posta dal di dentro del sistema, opponendovi e resistendo. Uomini affidabili. Rintracciabili, oggi, ve ne sono. Penso a Fistetti, Esposito, Bodei, Curi, Givone. Studiose come Cavarero, Forti, Viti Cavalieri, Resta, Battaglia. Studiosi immersi nella realtà disposti a fare, seguendo un’etica pubblica presentabile, scegliendo quando parlare e quando tacere. Rifiutando e mettendo a tacere l’arroganza e la falsità, sono propensi per la pausa meditativa e per la riflessione propedeutica a qualsiasi forma di esposizione mediatica ed espressiva. Intellettuali, quindi, in grado di convertire le idee in leve sociali; proponendo un insieme di convinzioni pervase di passione allo scopo di trasformare l’intero sistema di vita. L’attività filosofica è richiamo alla libertà; è una possibilità attraverso la quale emerga il senso autentico delle nostre azioni. Il fare, che si svela nell’azione pratica, è costitutivo dell’azione teoretica. E viceversa. Questo è quanto ha ben sottolineato Benedetto Croce, affermando la distinzione e la congiunzione tra la forma teorica e la forma pratica del sapere. E la filosofia, secondo l’insegnamento di Croce, diverrà attività critica, colma di consapevolezza e di responsabilità nell’agire.
In riferimento alla filosofia e alla cultura romena in generale, quali nomi hanno attirato la sua attenzione?
La cultura ha una storia di esili e di disperazioni. In terra romena sono nati i Tristia, invettiva sconsolata di un poeta in esilio dalla civiltà. Questo fatto accidentale, questo destino individuale ha segnato l’umore di un’intera stirpe di intellettuali. L’inconscio collettivo di una nazione in esilio, anche, da se stessa. A Roma ancora si stende la Colonna Traiana, dove spirali di bassorilievi raccontano l’asservimento dei Daci, gli antichi barbari di quelle terre danubiane. Chissà se Constantin Brâncuşi, scultore romeno, abbia pensato all’antica colonna quando creò la Colonna Infinita nel 1937?
Emil Cioran, Paul Celan, Costantin Noica, Nina Cassian, Mircea Eliade sono gli intellettuali che maggiormente hanno attirato la mia attenzione. Poeti e filosofi in esilio in Francia (Cioran e Celan) e negli Stati Uniti (Cassian, Eliade). A chi è rimasto in patria, come Noica, non è stata risparmiata la condanna a un esilio domestico, fra le mura di una prigione o nella propria abitazione. Il filosofo ha scontato, infatti, sei anni di lavori forzati negli anni Sessanta. Il destino di un popolo di schiavi, avrebbe detto Cioran. La storia di una schiavitù, ma anche di una disperata ricerca spirituale, di una filosofia votata alla trascendenza, di filosofi ossessionati dalla metafisica.
Il breviario dei vinti di Cioran, scritto a Parigi tra il 1941-1944, è la storia di una filosofia sconfitta dall’ottimismo della metafisica tradizionale, che ha messo al bando la disperazione, il dubbio, la fermezza di un popolo quali punti fermi fondanti della riflessione e del pensiero. La filosofia di un popolo di sconfitti e di vinti. Le parole di Cioran sono emblema di dolore e tenacia: «era scritto che noi, discendenti dei Daci e di altre popolazioni incerte, non consolidassimo alcun pensiero di felicità e che le gocce del nostro sangue formassero un rosario di dispiaceri ereditati da generazioni di vinti. Il sospiro e la maledizione furono la nostra strategia di pastori strappati a qualche stella moribonda, destinati a a scendere al cielo e a svilirsi invece nel tempo». A Parigi Cioran è assediato dalla noia. Le notti parigine di Cioran, tormentate dall’insonnia, gli hanno consentito una lucidità ossessiva. Il non-essere, la notte del pensiero e della storia è elevata alla positività dell’essere e da una metafisica sui generis. L’assurdo e il paradosso, la libertà totale dell’espressione sfiora l’insensatezza che ci conduce dritto all’opera diritto all’opera di un altro romeno illustre, ancora un franco-romeno, penso a Eugène Ionesco e al suo teatro dell’assurdo.
Schiavitù e libertà. L’originalità della filosofia romena consiste in quell’estrema libertà di pensiero dell’uomo in esilio, di chi è nato ai margini dell’Europa, di chi non è in debito con nessuno. E cerca un posto nel mondo. L’anima romena è un’anima in esilio, la figura del desiderio alla ricerca della rimozione originaria. L’irrequietezza di un popolo è affidata all’individualità di grandi intellettuali costretti ad affrontare il deserto della storia.
Per Noica, i grandi autori del canone occidentale sprigionano una verità fuori dal tempo, finalmente liberati dal peso della tradizione storica e storicistica. Finalmente non devono dar conto a nessuno.
A Chicago ha insegnato Mircea Eliade, storico delle religioni, antropologo, filosofo. A New York si è rifugiata, invece, Nina Cassian, poetessa. Entrambi minacciati dalla dittatura di Ceauşescu, che ha messo al bando le opere degli esuli. Cassian è nota per i suoi versi duri e al tempo stesso fiabeschi, pur rifiutando un’unica visione del mondo. Rigettare ogni sistematicità è un tratto distintivo di tutti gli esuli romeni. Per lo storico Eliade il rifiuto del sistema si articola nell’analisi dei riti e costumi dei popoli primitivi. In La nascita mistica del 1958 studia le tribù australiane, gli sciamani siberiani, i riti di iniziazione greci e indiani. Il suo è uno sguardo che si disperde nella pluralità dei miti e delle religioni, ma che ricerca l’origine e la genesi di un unico fenomeno, con l’autentico e malcelato anelito che soltanto un esule può dimostrare. Filosofi e poeti soli davanti alla propria condizione umana e ebri di malinconia e vita.
La scrittura contemporanea può annoverare letterate illuminate, vere pioniere quanto a innovazione e rispetto della tradizione. Qual è l’attuale status della letteratura esperita da donne?
Letteratura esperita da donne e pensiero femminista si fondono, pur, distinguendosi. Il pensiero della differenza nasce dalla critica alle battaglie per l’emancipazionismo egualitario. Il femminismo che si ispira alla teoria e alla pratica della differenza sessuale nasce negli anni Settanta e si sviluppa inizialmente in Francia con Antoninette Fouque e Luce Irigaray. La prima ci ha lasciati nel 2014, la seconda novantenne è ancora attiva e faro per tante studiose e per tutte noi donne. La tesi di Luce Irigaray è importantissima. Infatti, la studiosa coglie come «la differenza sessuale rappresenti uno dei problemi o il problema che la nostra epoca ha da pensare». Irigaray nelle evoluzioni della sua filosofia orienterà sempre più verso l’analisi del linguaggio la sua critica sino a giungere in Io Tu Noi. Per una cultura della differenza (1992) all’idea che sia necessario costruire un linguaggio e una cultura femminili capaci di esprimere un modo altro di pensare e di agire. Si tratta di una necessità vitale per difendere la dimensione relazionale dell’essere umano, in quanto l’omessa esperienza dell’alterità femminile nel corso della storia millenaria del patriarcato è diventata mancata esperienza dell’altro in quanto tale. Per Irigaray è giunto il tempo di costruire, partire dalla differenza sessuata, un’altra cultura, anzi due. La prima appropriata alla soggettività femminile e la seconda relativa alla relazionalità espressa nella formula io-tu-noi, in grado di rompere la ripetitività dei discorsi e di sviluppare le potenzialità dialogiche della lingua.
E se prendiamo in considerazione la situazione italiana?
In Italia ruoli importanti sono svolti da Carla Lonzi, Luisa Muraro, Lia Cigarini. Queste femministe italiane appartengono alla Libreria delle donne di Milano, fondata nel 1975. L’impegno anche filosofico prende corpo nel volume manifesto del 1987 intitolato Il pensiero della differenza sessuale. Tale realtà politica e culturale è incentrata sullo scambio di idee e sulla discussione che si occupa, tra le altre attività di allestire proprie pubblicazioni. Il nucleo della loro posizione teorico-politica è il rifiuto delle tesi emancipazioniste del vecchio movimento femminista in nome di una posizione differenzialista che sostituisce la rincorsa alla parità di genere con la rivendicazione della diversità ontologica del femminile rispetto al maschile. Oltre a quelle della Libreria delle donne, sono tante altre le studiose che insieme ai numerosi collettivi e ai vari Centri di documentazione daranno vita a un movimento culturale e politico che ben presto si diffonde in Europa. Il dibattito è vivo, considerando, anche, le molte critiche. A questa esperienza sono riconducibili la comunità filosofica Diotima, nata a Verona nel 1984. Importante è il volume del 1987 Non credere di avere dei diritti, pubblicato a Milano. Il sottotitolo dell’opera – La generazione della libertà femminile nell’idea e nelle vicende di un gruppo di donne – ben sintetizza l’esperienza e i temi del dibattito politico del tempo. Lo scopo del dibattito è favorire l’aggregazione fra donne e il loro conseguente processo di consapevolezza. Però sono accusate di aver assunto l’ordine simbolico e il sistema di potere maschile come parametro di riferimento, misura e principio unico di realtà. Per questa ragione, secondo le teoriche della differenza, le politiche di parità rischiano di riprodurre l’adeguamento, il conformismo e l’omologazione ai modelli maschili, con la conseguente cancellazione o marginalizzazione della piena e libera soggettività femminile e di un differente principio di realtà. La differenza sessuale pone al centro dell’elaborazione teorica e della sua ricaduta pratica la creazione di un diverso ordine simbolico, che renda possibile la ricomposizione del pensiero con l’esperienza soggettiva, la materialità dei corpi e la forza delle relazioni, attraverso modalità originali e autentiche.
Ruolo importante riveste, di certo, la studiosa Adriana Cavarero, che si distaccherà nel 1991 intraprendendo un’autonoma direzione di ricerca, con il proposito di elaborare un pensiero italiano della differenza. Tale gruppo di filosofe si propone di osservare criticamente la storia del pensiero occidentale con l’occhio della sola figura femminile del Simposio di Platone, cioè attraverso lo sguardo di Diotima.
Cavarero difende l’idea di un pensiero duale che riconosca e dia eco alla differenza sessuale. Muraro sostiene l’alleanza tra donne attraverso il concetto di affidamento che crea quei legami di sostegno necessari per non soccombere in una società maschile. Importante è il tema della genealogia al femminile che prende le mosse dalla rivalutazione paradigmatica del rapporto madre-figlia, come accade nel libro di Muraro L’ordine simbolico della madre, del 1991, che recupera alcune tematiche affrontate dalla semiologa e psicoanalista francese Kristeva, allieva di Lacan. Un elemento fondamentale comune alle teoriche della differenza è la questione del linguaggio e del peso specifico che esso comporta nell’acquisizione delle strutture simboliche, tema sul quale Kristeva ha insistito con la sua teoria dell’ordine semiotico materno.
In linea con la riflessione intorno al linguaggio è quella relativa alla scrittura articolata all’interno di uno dei testi fondanti del femminismo, Il riso della Medusa di Hélène Cixous del 1975, scrittrice e fondatrice del Centro di studi femminili dell’Università di Vincennes. In questo volume la lettura misogina che Freud pone del mito di Medusa, nel saggio del 1922 La testa di Medusa, equiparando la testa mozzata e orripilante della figura mitologica ai genitali femminili, creando così l’associazione tra decapitazione ed evirazione, viene ribaltata traducendo la risata gioiosa di Medusa in una sfida vincente al patriarcato che ogni donna può sconfiggere adoperando la scrittura per ritornare al proprio sé e al proprio corpo, emendandola dai codici fallocentrici che condizionano.
Di recente, la perdita per l’Europa di Ágnes Heller è stata una grande mancanza. La studiosa, appartenente alla scuola di Budapest, corrente filosofica del marxismo facente parte del cosiddetto «dissenso dei paesi dell’Est europeo» prima del crollo definitivo dei regimi dell’Est europeo, ha dato un contributo importante alle teorie etiche, morali, alle concezioni sul bene e sulla giustizia.
Per quel che riguarda, diciamo così, il panorama giovanile penso che vadano annoverate donne come Francesca Romana Recchia Luciani, Maura Gancitano, Lucrezia Ercoli, che in forme diverse rappresentano figure diverse di una riflessione sempre attenta alle questioni attuali, dai saperi di genere, alla popsophia, sino al ruolo svolto dai nuovi media.
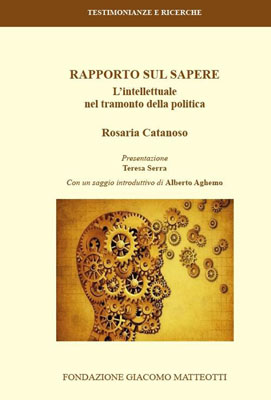
A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone
(n. 5, maggio 2022, anno XII)
|
|

