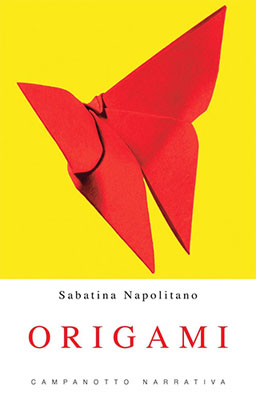|
|
Sabatina Napolitano: «Trovare un buon libro è come portare la tua donna nella casa dell’infanzia»
 Nella sezione Scrittori per lo Strega della nostra rivista, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, vi proponiamo una nuova serie di 10 interviste con gli scrittori candidati al Premio e quelli segnalati all’edizione n. 76, e con i loro libri, allargando ovviamente lo sguardo ad altri argomenti di attualità. Nella sezione Scrittori per lo Strega della nostra rivista, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, vi proponiamo una nuova serie di 10 interviste con gli scrittori candidati al Premio e quelli segnalati all’edizione n. 76, e con i loro libri, allargando ovviamente lo sguardo ad altri argomenti di attualità.
Sabatina Napolitano, scrittrice, poetessa e critica letteraria nata a La Maddalena (SS) nel 1989, è stata segnalata per il suo primo romanzo, Origami (Campanotto, 2021). Renato Bessana lo presenta così: «Questa prima prova narrativa della giovane autrice è ambientata nell’immaginaria città di Itaque, che sembra ruotare attorno a una grande biblioteca. La protagonista, Olga, ne diviene la bibliotecaria e fonda una rivista di letteratura, Origami. [...] Il romanzo può esser letto come un apologo sulla centralità della parola scritta. Lo stile è rapido, colloquiale, non privo di accensioni. La vita come un foglio di carta che si può piegare a ripiegare in forme inattese: un origami, appunto».
In un suo intervento, Sabatina, lei ha citato Nabokov, il quale «racconta un episodio in Pnin dove il protagonista si dimostra alquanto recalcitrante all’idea di dover restituire un libro non ancora finito». Olga, la protagonista di Origami,è una bibliotecaria. Quali sono i suoi mentori rispetto alla «letteratura delle biblioteche»?
Ho citato spesso Pnin di Nabokov, un émigré titolare di un corso all’università di Waindell che si trova sul treno sbagliato. L’università di Waindell non esiste, è un po’ come Itaque. Si tratta di luoghi finzionali che possono rappresentare tutti i luoghi. Nel caso di Nabokov, Waindell era probabilmente a metà tra l’Università di Cornell (Università di Ithaca negli Stati Uniti) e l’università di Wellesley. Pnin è un professore di russo che si trova spaesato negli Stati Uniti e non riesce per niente ad adattarsi. Nabokov spesso inserisce delle manie nei personaggi, anche Pnin ha diverse fissazioni. Le biblioteche sono un po’ come il portafogli, il mondo e le lenzuola dello scrittore e del critico. Non riusciamo per nulla a immaginare un mondo senza tradizione, senza librerie o biblioteche. Credo che leggere non sia solo un modo per scacciare la noia, ma trovare un buon libro è sempre come portare la propria donna nella casa dell’infanzia, dei ricordi. Per alcuni amanti non esiste luogo più bello che la casa dell’infanzia, dico per alcuni. Per altri il luogo dell’infanzia potrebbe semplicemente essere una prigione soffocante. Una biblioteca può essere il luogo in cui ci si ribella a una umiliazione, a una storia di privazioni, a soprusi non richiesti. L’interesse che ho sempre conservato per i libri, per le biblioteche e le librerie in generale è anche riferibile alla capacità delle biblioteche di amplificare la percezione del luogo in cui ci si trova. Nel palcoscenico della vita, l’età matura, gli odi reazionari, le privazioni, sono situazioni che possono identificarsi nel «sacrificio» che un individuo fa per un altro. In questo di certo Pnin è un personaggio emblematico. Il «sacrificio» sta sempre a metà tra l’adattarsi e il sentirsi «impossibili». Un modo per non restare sopraffatti dagli eventi così come dalle cose della vita è sicuramente rivolgersi a esperti tecnici, o semplicemente continuare a farsi delle docce fredde fin tanto che i pensieri di dolore, di sacrificio o di scommessa non cambiano, fino a quando in accappatoio non ci sentiamo più derelitti, nel tentativo di reiterare un passato e un futuro di fatto impossibili.
In Origami è assente lo Spannung, il colpo di scena, eppure la sua «penna» irretisce, esemplificando le trame interiori insite nell’umano. Quale idea ha inteso veicolare del tessuto invisibile di cui siamo fatti?
Il discorso di Origami è inscrivibile nella fiaba onirica e nel romanzo sociale. Ritornando a Pnin, sappiamo che è un inadattato alla ricerca di un senso che non trova mai. Nabokov probabilmente mette un po’ delle sue condizioni in Pnin, era anche lui un emigrato e diventa un professore di russo in California dopo essere scappato dalla Germania. Così Olga probabilmente non è il mio alter ego ma ha alcuni miei saperi iniziatici, anche se poi resta un personaggio finzionale. Olga non compare nei suoi pensieri interiori, se non attraverso i richiami di Rossana ed Emilio che non la turbano affatto e finiscono per non turbare neanche il lettore. In Origami non ci sono momenti divertenti o esilaranti, vengono descritti gli impiegati nella magica biblioteca di Itaque, così come vengono descritti fuori dalla biblioteca. I personaggi sono uniti dall’appassionato interesse per la biblioteca di Itaque, e non hanno grandi difficoltà di integrazione perché la funzione dell’intero romanzo è raccolta dal sogno di Olga. Il discorso dell’intero romanzo sta nel non essere per nulla un romanzo autobiografico, e nell’essere la storia affettuosa e controversa di una bibliotecaria che è inserita nelle logiche strambe e talvolta fuori luogo degli impiegati.
Dalla sua prospettiva, come cambia la vita per mezzo della letteratura?
Origami è un romanzo sulla letteratura delle biblioteche e sulla riflessione letteraria. È un romanzo di una bibliotecaria che non parla mai direttamente di libri e non parla mai direttamente di sé stessa perché tutta l’atmosfera è permeata da una proiezione, come da un sogno. Anche le lezioni che avvengono all’interno della biblioteca sono viste appena nei giochi della narrazione perché tutto è dato al lettore nel senso di una catarsi. Tutto sembra insignificante e irreale, in realtà ci accorgiamo subito che finisce per essere spietato e in dei tratti terrificante. Nessuno avrebbe voluto sentire parlare di Olga se non avesse avuto realmente una vita a metà tra il terrificante e il magico.
Lei è una poetessa, oltre che critica letteraria. La sua versificazione appare sensibilmente refrattaria al rispetto ovvio e ossequioso delle norme. Qual è la chiave d’accesso per discriminare i suoi intenti creativi e comunicativi?
Ho sempre avuto la 'parlantina'. Credo che la voglia di scrivere è venuta molto prima della voglia di poetare. Se avessi avuto una sorella sarebbe andato forse tutto diversamente, il fatto è che sono cresciuta sostanzialmente sola. La mia vita è stata agghiacciante e ridicola come quella di Olga in alcuni tratti. E può essere riletta come una prosa-poesia, anche se le riletture sono rischiose. Non amo le biografie, non ho la pretesa di sostenere che la mia biografia agghiacciante e ridicola per certi tratti possa assurgere a un ruolo funzionale e, tra l’altro, illudermi di contemplare per lassi di tempo la curiosità di un critico. La poesia così come la critica può riempire la vita di un uomo solo. Se ci riesce, e riesce a dare un senso all’infondatezza di gesti comici quanto disperati, ecco che in quel momento sia la poesia che la critica hanno avuto un ruolo. È ben difficile capire quale sia la luce di questi contesti. Sicuramente l’osservazione della complessità aiuta a definire circostanze tristi, e trasformare in opportunità meravigliose. Ma questa tensione appare solo in dei punti. È necessario comprendere che sia il ruolo della poesia come quello della critica sono in realtà fallibili e fallimentari.
La scrittura può avere un potere costitutivo o anche salvifico?
Credo vivamente di no e lo dico con l’esperienza degli anni. Il critico non cambia né alla luce di un romanzo perfetto, di una silloge speciale o di una occasione sensazionale. Il critico non cambia la sua chioma, è fisso, imperturbabile. E in questa sua camera da pranzo, alla fine, non resta che l’illusione di una vita-altra vissuta guardando gli altri, in una modalità immersa e fantasiosa. Se la poesia e la critica hanno il potere di liberare da questo? Ce lo chiediamo? No, non ne hanno il potere. La poesia e la critica non hanno alcun potere salvifico, ma accennano solamente a degli elementi di dialogo e confronto. L’unica cosa che salva è sfogare la pulsione in creatività così gli istinti di morte, come gli istinti di vita, vengono canalizzati verso una opera. A volte la creatività deve essere tenuta a bada, e va portata la macchina al lavaggio.
Bachtin asserisce che il romanzo sia un «genere aperto», destinato non a morire bensì a trasformarsi. Oggi, si notano forme «ibride». Quali tendenze di sviluppo ravvede di un genere che continua a sfuggire a ogni codice?
Sono assolutamente convinta delle forma ibride essendo Origami stesso una forma ibrida. Il punto del romanzo è che finisce per non essere più l’amante di niente e questo «niente» è molto più vicino alla ricerca filosofica che letteraria. La questione del romanzo sta, a parer mio, di non rendere favolose le banalità per poi finire di marginare i capolavori. Se si continuano a rendere spettacolari le banalità, allora perdiamo anni, e decisamente troppi a dare importanza a ciò che non ne ha. Il punto è proprio questo, che la spazzatura esibizionistica dovrebbe essere lasciata andare per un senso dignitoso del fare letteratura.
La scrittura contemporanea può annoverare letterate illuminate, vere pioniere quanto a innovazione e rispetto della tradizione. Qual è l’attuale status della letteratura esperìta da donne?
Non credo nella letteratura femminile e non credo ci siano pioniere prima di me, anzi sostengo fortemente che quell’esibizionismo lasci vita a delle banalità perpetuate a cui viene dato il peso di un capolavoro. D’altra parte, sostengo però che molte sono le scrittrici veramente capaci, soprattutto quelle che tendono al genere biografico e saggistico. E credo che le incontrerò e ci incontreremo per intessere un rapporto di fiducia.
Francesco De Sanctis scrisse che la letteratura di una nazione costituisce una «sintesi organica dell'anima e del pensiero d'un popolo». Posto che la letteratura siauno specchio della rispettiva società in un tempo definito e che varia di opera in opera, quali potrebbero essere il ruolo e la funzione della scrittura nel frangente storico che stiamo vivendo?
Credo che citare De Sanctis sia un po’ anacronistico, come tentativo basti parlare di Siti, Simonetti, Mazzoni, Cortellessa. Immagino che la scrittura sia quel momento in cui da sdraiato ti ostini a non volerti più alzare. La scrittura è spesso un motivo personale, soggettivo, che finisce col diventare comune a una nazione, nel caso di identità cosmiche. Finisco con l’essere una scrittrice mite e in alcuni tratti molto spirituale, quindi sono tra le poche fortunate a poter dire di non avere avuto la poesia in prestito o la scrittura in prestito ma che sono connaturate alla mia identità, come alla mia natura. Diversamente dalla traduzione che non mi appartiene come campo, la scrittura mi fa sentire completa e riempie le mie attenzioni verso altri campi tendenti alla saggistica. La scrittura è una possibilità, un canale. C’è bisogno di una dedizione inaudita così come di un rispetto profondo.
La letteratura romena si fregia di una robusta altresì varia produzione. Essa è costantemente tradotta in lingua italiana, con nomi di punta quali Ana Blandiana, Herta Müller, Mircea Cărtărescu, Emil Cioran, e la rivista «Orizzonti culturali italo-romeni» ne registra le pubblicazioni nel database Scrittori romeni in italiano: 1900-2021. Quali scrittori romeni hanno attirato la sua attenzione?
Di sicuro Herta Müller, in particolare L’altalena del respiro ci rimanda a una riflessione fondante soprattutto in periodi di guerra come quello che stiamo vivendo. Lo stesso Cioran di Lacrime e santi. Cito solo due libri in questa sede perché non basterebbe un saggio di seicento pagine a parlare dell’importanza della letteratura romena. Libri questi due che cito, che predispongono ad abbattere la spazzatura letteraria per la letteratura dell’umanità, si intende la vera letteratura, il vero richiamo.
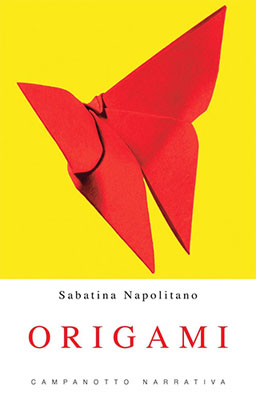
A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone
(n. 5, maggio 2022, anno XII)
|
|

 Nella sezione
Nella sezione